L’esperienza ha dimostrato la capacità dei computer di interagire nonché di estendere le loro capacità se collegati insieme. Internet ha fornito la capacità, ed ora nei gabinetti dei tanti dottor Caligari si lavora a collegare i cervelli. Sono già stati condotti con successo esperimenti sugli animali. La frontiera dell’interfaccia neurale umana è vicina ad essere varcata. La tecnologia relativa si chiama Brainet, rete di cervelli. Si stanno studiando tecnologie i cui esiti saranno super computer biologici frutto della “mente collettiva”. Condivideranno ricordi, forse percezioni ed emozioni. Il taglio con cui arrivano al pubblico le informazioni su Brainet enfatizzano soprattutto l’aiuto alla salute, ma la verità è che è stata spalancata la porta a qualcosa di mostruoso, ancorché dotato di un fascino abbagliante, la creazione di una mente-alveare transumana.
L’alveare, peraltro, non conosce l’individualità dei suoi componenti, tutto è in funzione dell’ape regina, ovvero Tecnopolis, l’élite che possiede e controlla mezzi tecnologici potentissimi trasformati in fine. Vi è una sorprendente analogia con la finzione cinematografica di Metropolis (1927): la mega macchina che ingoia le persone. Brainet è lo strumento perfetto per l’abolizione dell’individualità, ossia della persona umana, obiettivo non più celato dalle avanguardie transumaniste. Un’immensa, mostruosa, antiumana coscienza impersonale, coerente traguardo della post modernità.
Un gigantesco database sarà gestito in vari “cloud”, (la nuvola informatica, il grande magazzino dati on demand) governati dalla tecnostruttura agli ordini di una cupola che potrà affermare non di aver abolito la libertà, il libero arbitrio o le procedure chiamate democratiche, ma l’homo sapiens. La coscienza personale sarà una minuscola cellula del Moloch. Le forme relazionali della neo-umanità verranno gestite attraverso l’interazione delle NBIC (nanotecnologia, biotecnologia, informatica e scienze cognitive) con esiti imprevedibili.
Saremo quello che vorrà il comando della macchina impersonale, padrona dell’alveare formato da milioni di interfacce neurali costituite da nanobot, minuscoli robot di dimensioni molecolari o addirittura atomiche, impiantati nel corpo. E’ l’ultima fase in ordine di tempo dell’evoluzionismo più radicale, l’espressione di un materialismo assoluto, la mistica della mente alveare, una sorta di memoria collettiva, di nastro magnetico che cristallizza e riavvolge la vita. Per alcune correnti transumaniste, “io” sono esclusivamente il mio cervello e l’eternità che promettono è la persistenza della memoria informatizzata della mia vita. Raggelante.
Sarà l’età che avanza e fa capire il significato dell’espressione “vivere di ricordi”, ma la memoria è la parte di noi di cui siamo più gelosi. Fa paura immaginarla avvolta in un nastro virtuale, esposta a chi manovra immensi apparati artificiali, privata dell’intimità, perfino del sapore e dell’odore del ricordo. Chissà che ne penserebbe Marcel Proust, che alla memoria ha dedicato una delle opere più significative della modernità, la monumentale Recherche, Alla ricerca del tempo perduto. E’ celebre il passo in cui il protagonista, l’Io narrante – Marcel come l’autore – ha un trasalimento mentre riceve la colazione, a base di tè e di pasticcini. “All’improvviso il ricordo è davanti a me. Il gusto era quello del pezzetto di madeleine che a Combray, la domenica mattina, quando andavo a darle il buongiorno in camera sua, zia Leonia mi offriva dopo averlo inzuppato nel suo infuso di tè o di tiglio.”
Ognuno di noi ha la sua madeleine personale, intima e solo sua; per chi scrive è il profumo, il fumo e il lieve, particolarissimo fruscio delle lasagne al sugo appena sfornate mentre vengono tagliate. Non voglio far parte della mente alveare, né intendo penetrare nel foro interiore degli altri. Intima è la memoria, personalissima e selettiva. Si dimentica e si rammenta, e ogni volta qualcosa muta nel ricordo; nuovi significati, sensazioni e risvolti – spesso tristi o drammatici, talvolta gioiosi – entrano a far parte del patrimonio immateriale della memoria, cuore, anima e corpo, non solo cervello.
La memoria è anche la sede della cultura, nel senso di conoscenze, saperi, giudizi, pregiudizi e convincimenti che fanno di un’esistenza la “mia” vita, la “tua” vita. Sono i frammenti che – uniti – formano la visione del mondo di ciascuno, la cornucopia da cui estraiamo sentimenti, idee, emozioni, timori. La vita, insomma. Perfino il materialista Voltaire – autore di decine di voci dell’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert – nel Saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni, parla della cultura non come accumulo di conoscenza, ma come capacità di formarsi un autonomo quadro del mondo, dipinto da noi, con i colori, i chiaroscuri e la cornice scolpita da noi: studio ed esperienza. Non un ammasso di dati e metadati, il modello artificioso e transumano dominato dalla tecnologia.
E’ inutile sovraccaricare il file della memoria, ma resta l’aspirazione inesausta e irrealizzata dell’essere umano, l’ansia di conoscenza e di pienezza di un essere che sa di essere incompleto e caduco senza potersi rassegnare alla sua condizione.
Leo Strauss in Che cos’è la filosofia politica? (1957) afferma che il filosofo (l’amico della conoscenza) è colui che, sapendosi limitato, impotente, cerca di discernere, distinguere, dare giudizi. L’uomo – animale culturale (A. Gehlen) – è l’essere che prende posizione, formula giudizi. Impedirglielo, tagliare la memoria con il linguaggio politicamente corretto e l’incultura della cancellazione, significa impedire quella ricerca tra passato e futuro, memoria e zavorra, che ciascun uomo compie a suo modo.
Come comprese Socrate, sapiente è chi sa di non sapere: la memoria è ricerca sempre inconclusa. Nessun alveare, nessuna “mente collettiva” se non nella forma scoperta da Jung, l’immaginario che è sostrato, memoria condivisa entro una comunità. Se fossimo esseri completi, se perdessimo la curiosità genuina, l’ansia di scoperta, sciolte in un mostruoso artefatto come la mente alveare, saremmo esseri conclusi a cui verrebbe meno la voglia di vivere. Da uomini, quanto meno.
Fin dai tempi classici, è esistita l’aspirazione a una conoscenza universale. Un esempio è la biblioteca di Alessandria, summa del sapere antico, prima incendiata, poi distrutta dalla conquista araba. Nel romanzo distopico Il Dio Thoth, Massimo Fini immagina un’immensa biblioteca digitale, fatta però di riduzione della conoscenza, di riassunti, assurdi Bignami che non risparmiano l’Amleto, sepolto da migliaia di rimandi e citazioni parziali. In Fahrenheit 451 la cultura e la memoria sono proibiti e il compito dei pompieri è di bruciare i libri. Metafore di un rapporto con la memoria, la conoscenza e la cultura che è l’essenza della presenza umana sulla scena del mondo.
Memoria, ma anche oblio, dimenticanza, scelta: ecco un’altra cosa di cui ci deruba il futuro che viene, il “datismo” e la mente alveare, registro unificato di milioni, miliardi di irripetibili esistenze. La memoria è un labirinto, il mio labirinto. Nessuno meglio di Jorge Luis Borges poteva raccontarla, analizzarla, sezionarla minuziosamente. Lo fece in un racconto all’interno di Finzioni, un titolo che evoca le corse, i viaggi, i tortuosi andirivieni del pensiero. Funes o della memoria, nell’originale il più suggestivo Funes el memorioso, è, secondo Borges, una lunga metafora dell’insonnia.
Il protagonista è un ragazzo uruguaiano di origini indie, Ireneo Funes, il quale, dopo un incidente all’età di diciannove anni, viene colto da “ipermnesia”, ossia è in grado di ricordare tutto, ma proprio tutto, di ciò che vede, legge e vive. “Cadendo, perse conoscenza; quando la recuperò, il presente era quasi intollerabile per quanto era nitido e ricco, anche le memorie più antiche e più triviali”. Funes mostra una memoria prodigiosa, e terribili difficoltà a prendere sonno. Borges presenta Funes come un ragazzo enigmatico, misterioso. “Lo ricordo, il volto taciturno dall’aspetto indio, singolarmente distante, remoto dietro la sigaretta. Funes era un precursore dei superuomini, uno Zarathustra meticcio e vernacolo”. Soffriva per non poter dimenticare sino a non riuscire a sciogliere l’ansia nel sonno liberatore.
Menomato, privato della speranza, “portava la sua superbia sino al punto di fingere che fosse stato benefico il colpo che lo aveva fulminato. Lo vidi due volte dietro le sbarre che simboleggiavano grossolanamente la sua condizione di eterno prigioniero.” Borges vede la portentosa memoria di Ireneo come un’eterna prigione e l’oblio – il diritto di dimenticare – come libertà. Eppure siamo soliti mettere in relazione la memoria con l’intelligenza, anche se ne è solo un requisito, una precondizione.
Ma che accadrebbe se una memoria prodigiosa quanto malsana e morbosa ci permettesse di ricordare assolutamente tutto, sino al più insignificante dettaglio? Innanzitutto, diventeremmo pazzi, ma non solo. Borges ci mostra come l’oblio selettivo è altrettanto importante della memoria. Il sonno depura e scioglie i ricordi meno importanti per fare posto agli eventi veramente rilevanti. Trascende la curva della memoria, la rende più sopportabile e, al contrario, può gonfiarla di dolore e rancore, ma è ancora umanità, scelta, padronanza. Una memoria assoluta è il sintomo di una condizione di prigionia interiore. La tecno dittatura del dato senza narrativa ci porta al non pensiero, all’assenza di correlazione, di astrazione e di generalizzazione: la vera cultura.
L’eccesso di dettagli, suggeriscono Borges e in fondo Voltaire, impedisce il giudizio. Ossia espropria il carattere essenziale della nostra umanità. Ireneo Funes, chiuso nell’oscurità della sua camera, handicappato “memorioso”, era schiavo dei suoi ricordi che rammemorava continuamente in un circolo vizioso sino a morirne.
In poche ore imparò il latino e recitava passaggi della Storia naturale di Plinio il Vecchio, opera che gli aveva prestato un amico. “La materia di quel capitolo era la memoria; le ultime parole furono ut nihil non iisdem verbis redderetur auditum [affinché nulla di ciò a cui si è prestato attenzione venga narrato con le stesse parole] Prima dell’incidente era un cieco, uno smemorato, ora la sua percezione e la sua memoria erano infallibili”.
Tuttavia quell’infallibilità contraria alla fallibilità umana reca con sé un enorme fardello. “Il vertiginoso mondo di Funes” era la memoria indelebile dell’umanità. “Ho più ricordi io da solo di tutti quelli che avranno avuto tutti gli uomini dacché il mondo è il mondo. I miei sogni sono come per voi la veglia”. Immaginiamo per un attimo la terribile condanna di essersi caricati sulle spalle le miserie del mondo. Immaginiamo di ricordare ogni immagine, ogni parola, ogni suono, senza posa, senza riposo. Immaginiamo per un solo minuto di essere onniscienti anziché creature, esseri limitati, finiti. L’oblio – e il sonno suo fratello – rinnovano la vita e ci riscattano della condanna eterna della memoria.
Funes non riusciva a sottrarsi al ricordo, quindi “gli era molto difficile dormire. Dormire è distrarsi dal mondo”. La disgrazia di conservare nella memoria anche il più piccolo ricordo ci spingerebbe a un tremendo rancore, a un’angoscia esistenziale irredimibile, poiché nessuno è preparato a farsi carico di ogni ingiustizia, dolore, ogni storia e nemmeno di ogni conoscenza. Meglio il consiglio di Voltaire: scegliamo ciò che è migliore. Che tale è per noi, nel giudizio parziale, fallibile certo, ma umanissimo e soprattutto nostro, giacché pensare è giudicare, scoprire o dimenticare le differenze, generalizzare, astrarre. “Nell’ affollato mondo di Funes non c’erano che dettagli. “
Contro l’impero dell’eccesso di dati e informazioni, un mondo di bit e puntini, contro la disumana mente-alveare, evviva l’uomo imperfetto, con i suoi racconti e le sue dimenticanze, il discernimento e il criterio personale. Astrarre e generalizzare: dipingere da soli il quadro del mondo. “E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c’è. Capire tu non puoi; tu chiamale, se vuoi, emozioni.”

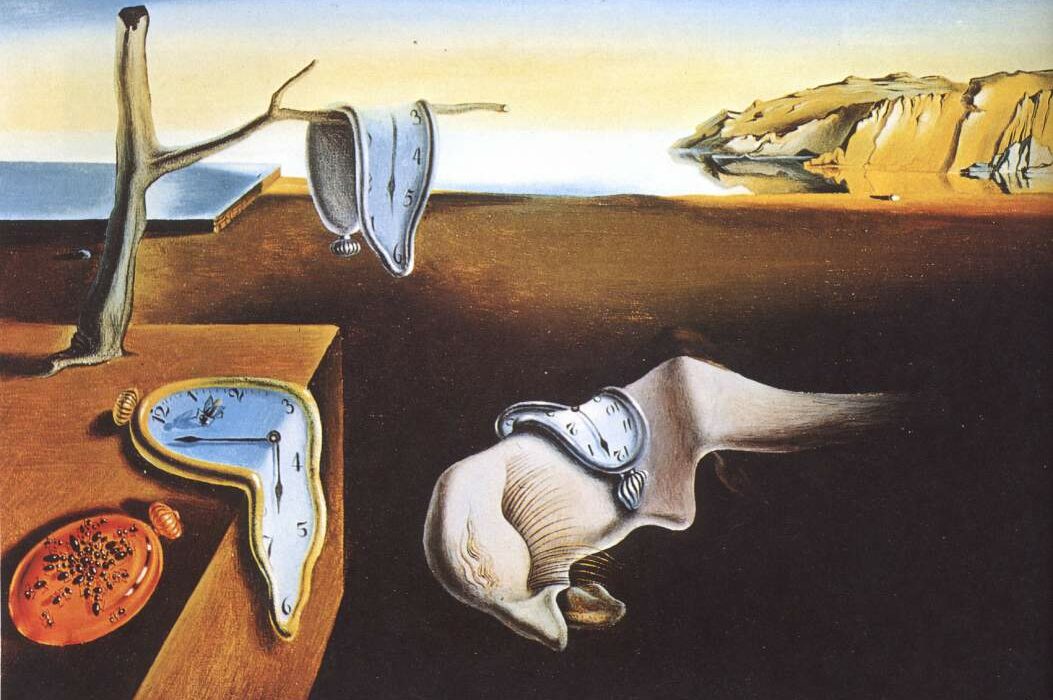





3 Comments