Il dodicesimo libro del Mahabharata ritrae la bellezza del Centro polare primordiale posto in un arcipelago riparato e protetto dove la primavera durava buona parte dell’anno. Senonché, dice, “dopo qualche tempo a causa della maledizione di Brahmanas, quelle regioni della felicità affondarono nelle viscere della Terra” (Shanti Parva, cap. 337).
Se fino a pochi anni fa si poteva pensare a una metafora iperbolica, oggi le rilevazioni satellitari segnalano la presenza di un enorme «buco» rotondo al Polo Nord. Come si è formato? Oppure si tratta di un semplice gioco di luci ed ombre, del risultato dell’inclinazione del pianeta rispetto al sole, della coda della Corrente del Golfo che s’infila nelle acque gelide dell’Artico?
In assenza di risposte convincenti andiamo oltre, prendendo in considerazione un paio di idee plausibili. La “maledizione di Brahmanas” di cui parla uno dei testi più importanti dell’induismo potrebbe alludere all’esplosione del cono vulcanico di enormi dimensioni posto nel centro dell’Isola Bianca. Un’ipotesi avvalorata dall’intensa attività geotermica che tuttora agita il «Crinale di Gakkel», la catena montuosa che attraversa per 1.800 chilometri il fondo dell’Oceano Artico. Quale localizzazione storica dell’evento si potrebbe scegliere invece la maledetta fase compresa tra i 47mila e i 27mila anni fa, quando i ghiacciai himalayani avanzarono in modo significativo rendendo l’aria sempre più secca e la terra ancora più avara di frutti [immagine 1].
 A questo punto l’immancabile avvocato del diavolo dirà che prove tangibili al riguardo non ce ne sono, e, in base al metro di giudizio attualmente in uso, soltanto i dati oggettivi sono considerati proprietà intrinseche del reale. Senza contare che immagini come il cono montagnoso e l’isola si addicono a un contesto di perfezione come quello accordato all’Età Aurea, per cui rientrano nel classico repertorio descrittivo del mondo in miniatura che si «manifesta» all’improvviso in mezzo alle onde (l’isola) e appare non piatto ma spiritualmente elevato (la montagna). Vita felice e pensiero verticale, insomma. Tutto qui.
A questo punto l’immancabile avvocato del diavolo dirà che prove tangibili al riguardo non ce ne sono, e, in base al metro di giudizio attualmente in uso, soltanto i dati oggettivi sono considerati proprietà intrinseche del reale. Senza contare che immagini come il cono montagnoso e l’isola si addicono a un contesto di perfezione come quello accordato all’Età Aurea, per cui rientrano nel classico repertorio descrittivo del mondo in miniatura che si «manifesta» all’improvviso in mezzo alle onde (l’isola) e appare non piatto ma spiritualmente elevato (la montagna). Vita felice e pensiero verticale, insomma. Tutto qui.L’argomentazione è piuttosto debole mentre le tesi proposte offrono maggiori spunti di riflessione. Premesso che le chiacchiere dei marinai godono di una pessima reputazione ma spesso c’azzeccano, sarebbe un errore ignorare la «voce» diffusa fino a non molto tempo fa negli ambienti della navigazione circa la presenza di un cono imponente all’estremo Nord. Persino Mercatore nel 1595 inserì nel suo atlante la Rupes Nigra, cioè l’isola-montagna magnetica che qualche tempo dopo descriverà in una lettera a John Dee come «nera e luccicante», circondata da un mare burrascoso e «alta come le nuvole».
Da ultimo ma non meno importante c’è poi un altro dato oggettivo: la mentalità del Sapiens delle Origini era lontana anni luce dalla nostra e perciò l’immagine del mitico «cono» potrebbe essere stata fraintesa. Chi ci assicura che la «montagna sacra» fosse un soggetto geografico? Se, per ipotesi, travalicando ogni visione moderna, la sua natura appartenesse alla sfera della «passionarietà»? Si tenga presente che gli Antichi utilizzavano il «senso interno» per elaborare qualsiasi informazione, non davano come noi la precedenza agli apparati strumentali che producono dati e numeri.
Partire è un po’ morire
Ora mettiamoci per un momento nei panni di quel lontano antenato e cerchiamo di capire il suo stato d’animo una volta archiviata la fase androginica, corrispondente al Primo Grande Anno del nostro Manvantara (da 65.000 a 52.000 anni fa), quando la stirpe dovette incamminarsi verso l’ignoto. E’ facile supporre che la paura dei nuovi mondi abbia fatto scattare nel Sapiens il sistema di auto-conservazione, a cui sarà subentrato lo stato di allerta permanente. Necessario peraltro alla sopravvivenza del gruppo mentre le imbarcazioni affusolate viaggiavano lungo le vie fluviali precipitando lungo discese vertiginose, o avanzando di sbieco su tratti liquidi assurdamente in declivio.
Ogni tanto qualcuno finiva a bagno, forse morto. Ma poi, più in giù, l’autostrada fluida diventava un sentiero luccicante, e allora si apriva davanti agli occhi degli esausti viaggiatori un fondovalle fatto di massi, cespugli e alberi giganteschi dietro i quali sfavillavano i bagliori crescenti dell’alba, che, oltre il 60° parallelo Nord, non sembrava sorgere da un solo punto della Terra come avveniva nel resto del pianeta bensì da tutto l’orizzonte.
La descrizione del «giorno permanente» s’impresse così profondamente nell’animo delle generazioni successive che gli estensori dei Veda dedicarono ben trecento inni a Ushas, la danzante dea dell’alba, le cui evoluzioni rotanti evidenziavano con inequivocabile chiarezza una durata dell’aurora molto più lunga e una natura fatta di bagliori crescenti. Esclusa la possibilità che i rishi indiani abbiano mai visto di persona uno spettacolo del genere, è evidente che tali resoconti provenivano da epoche assai remote e da osservatori dislocati nelle regioni polari e sub-polari. (Christophe Levalois, La terra di luce. Il Nord e l’Origine, 1988).
Ne consegue che coloro i quali tramandarono il ricordo dell’alba boreale si trovavano nel settentrione siberiano (tra la Carelia e la Chukotka), indicato appunto come il primo approdo della stirpe-matrice in uscita dalla sede originaria. Visto da quei territori, in effetti, l’emisfero superiore appariva come una superficie curva che sorgeva dall’oceano equatoriale per elevarsi fino al Polo celeste. Tutt’attorno ruotavano il sole, la luna e le stelle, mentre sopra il «monte» brillava il faro rassicurante della Stella Polare, ritenuta il vertice del mondo visibile [immagine 2].
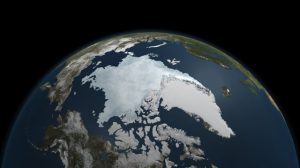 Quando mai si era vista sulla Terra una montagna più perfetta di quella? Idealizzandola il Sapiens non più aureo ma ormai decaduto trasferì così l’immagine dalla dimensione cosmica all’ambiente antropico, generando una serie di simboli destinati ad entrare nella Storia dell’Uomo. Riferimenti alla primordiale «montagna cosmica» si trovano quasi uguali nelle culture di Mongoli, Buriati, Kalmukki, Giapponesi e Tibetani. A seguire vennero i miti del monte Hara e del monte Meru, o Sumeru; del Kunlun (o Hu-Ling) asiatico; del monte Hukairya posto nello spazio sacro dell’Airyana Vaêjo, la mitica patria degli Ari; dell’Harā Bərəzaitī avestico; fino alla Torre di Guardia, o montagna originaria, e via dicendo.
Quando mai si era vista sulla Terra una montagna più perfetta di quella? Idealizzandola il Sapiens non più aureo ma ormai decaduto trasferì così l’immagine dalla dimensione cosmica all’ambiente antropico, generando una serie di simboli destinati ad entrare nella Storia dell’Uomo. Riferimenti alla primordiale «montagna cosmica» si trovano quasi uguali nelle culture di Mongoli, Buriati, Kalmukki, Giapponesi e Tibetani. A seguire vennero i miti del monte Hara e del monte Meru, o Sumeru; del Kunlun (o Hu-Ling) asiatico; del monte Hukairya posto nello spazio sacro dell’Airyana Vaêjo, la mitica patria degli Ari; dell’Harā Bərəzaitī avestico; fino alla Torre di Guardia, o montagna originaria, e via dicendo.
Anche i Norreni ricordavano con rimpianto un primordiale Centro di irradiazione (ormai Nordatlantico, quindi secondario) chiamato «Idavöllr», ossia il «campo del vortice», attorno al quale girava il firmamento. A loro volta gli Accadi rimembravano i bei tempi in cui nel mezzo della mitica Akkad sorgeva una remota «montagna del mondo» di nome Kharsak Kurra, sulla quale s’imperniava la rotazione dei cieli. Gli Assiri ereditarono tale visione, tradotta dai Greci nel mito di Atlante. Da qui il «monte dell’assemblea» divina, cioè all’Har-Moed poi divenuto Har Megiddo, o Armageddon.
In memoria della curvatura polare delle Origini i Sabei di Harran continuarono per secoli a celebrare le loro cerimonie «alla maniera degli Antichi», cioè rivolti verso il Nord. Analogamente gli Aztechi, civilizzati probabilmente dai navigatori nordatlantici, ritenevano che la culla della razza umana si trovasse su un’«alta montagna nordica» avvolta da dense nubi; proprio ai suoi piedi avrebbe fatto ritorno l’eroe-civilizzatore Quetzalcoatl, ma questa è un’altra storia.
Con l’andare del tempo dall’Australia all’Antico Egitto l’immagine più diffusa del morire divenne quella dell’«aggrapparsi alla montagna» poiché l’anima liberata dal corpo tornava naturalmente verso il punto di partenza (il Polo?), dove si trovava la dimora degli dèi. In modo assai eloquente il primo morto della narrazione vedica, Yama, venne immaginato nell’atto di percorrere le «alte vie» della montagna sacra mentre mostrava agli uomini il giusto cammino (Rg Veda, X, 14,1).
Tutti i sentieri dei morti dell’antichità, che inerpicandosi sulla montagna portavano le anime «a casa», potrebbero essere dunque un retaggio della «superficie curva» osservata nostalgicamente dai primi Sapiens in fase di allontanamento dalla «terra dei Padri». Perfino il Demens riferendosi a qualcuno che ha «reso l’anima a dio» guarda istintivamente verso l’alto, e ciò a prescindere dalle sue credenze religiose. Il gesto è innato, c’è poco da fare. Se d’altra parte resistono alle sferzate del tempo i cinghiali di Sulawesi dipinti 45mila anni fa sulla roccia, figurarsi i segni sedimentati nella memoria collettiva!
La nuova nascita
Per chi le sa vedere, scriveva Arthur Machen, le coincidenze portano abiti trasparenti. Motivo per cui sarebbe ingenuo attribuire alla fantasia umana, o peggio ancora al «caso», i mille riferimenti alla montagna sacra delle Origini in cui si mescolano Geografia, Storia e Senso Interno. Il tema è presente nella cultura cinese, indiana, iraniana, eddica; serve altro per confermare la comune radice culturale dei popoli dell’emisfero settentrionale?
Ormai distanti dalla Patria primordiale e dunque privati dello spettacolo grandioso della montagna-mondo illuminata dalla Stella Polare con il firmamento che le vorticava attorno, le stirpi dell’Età Argentea fecero del loro meglio per mantenere vivo il ricordo. Ciò nonostante la forma venne squadernata in innumerevoli modi, diventando infine un canone di perfezione assoluta in quanto il punto e il cerchio erano impossibili da misurare [immagine 3].
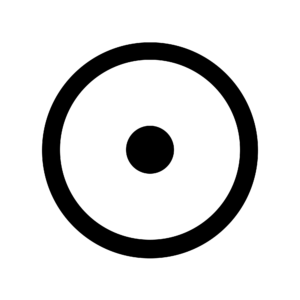 A quei tempi la tecnica di astronomi e architetti era ancora eccellente, perciò le civiltà più evolute s’ingegnarono per catturare l’energia cosmica e trattenere le onde sprigionate dai fenomeni celesti dentro «montagne artificiali». Eressero tumuli e piramidi capaci di riprodurre sulla Terra l’armonia rappresentata dalla primordiale Montagna Sacra, sebbene le due cose presentassero alcune differenze. Rispetto al tumulo a base circolare la piramide presentava una pianta quadrata, una diversità che venne sintetizzata dai Cinesi in una geniale geometria storico-astronomica: in origine la terra degli dèi era rotonda (vista dalla posizione sub-polare), in seguito divenne però quadrata (con la discesa verso Sud, mentre la curvatura spariva dall’orizzonte), fu allora che Shang-ti vi costruì sopra il suo palazzo celeste, o «palazzo del centro» (formò le istituzioni), quindi guidato dalla Stella Polare si apprestò a governare l’universo-mondo.
A quei tempi la tecnica di astronomi e architetti era ancora eccellente, perciò le civiltà più evolute s’ingegnarono per catturare l’energia cosmica e trattenere le onde sprigionate dai fenomeni celesti dentro «montagne artificiali». Eressero tumuli e piramidi capaci di riprodurre sulla Terra l’armonia rappresentata dalla primordiale Montagna Sacra, sebbene le due cose presentassero alcune differenze. Rispetto al tumulo a base circolare la piramide presentava una pianta quadrata, una diversità che venne sintetizzata dai Cinesi in una geniale geometria storico-astronomica: in origine la terra degli dèi era rotonda (vista dalla posizione sub-polare), in seguito divenne però quadrata (con la discesa verso Sud, mentre la curvatura spariva dall’orizzonte), fu allora che Shang-ti vi costruì sopra il suo palazzo celeste, o «palazzo del centro» (formò le istituzioni), quindi guidato dalla Stella Polare si apprestò a governare l’universo-mondo.
Oggi la Fisica Radiestica ha riscontrato nelle piramidi la presenza di onde di forma che vengono rilasciate dalle loro linee geometriche, il che fa pensare che tali interazioni di energia rientrassero dapprincipio in un contesto sapienziale di più largo respiro, ovvero in una scienza geometrica di antichissime origini, della quale però si sono perse le tracce.
In relazione al processo di civilizzazione, l’alto numero di «monti cosmici» fatti da mani umane e dislocati in vari punti del globo può essere interpretato come il primo segnale di ripresa dopo le tragiche vicissitudini legate alla deglaciazione. L’ambiente asciutto ha preservato alcuni di questi manufatti in Egitto e Mesoamerica, ma rovine di montagne di pietra a terrazze alte decine di metri stanno riaffiorando a Gympie, nel Queensland, presso Penrith, nel New South Wales e ad ovest delle Blue Mountains. Anche a ridosso dell’Oceano Pacifico (crocevia dei navigatori dell’Era Glaciale) si trovano resti di ziqqurat sparpagliati qua e là. Sul perché, poi, da qualche parte i monti di pietra siano fatti «a gradoni» e altrove «a copertura liscia» si potrebbero fare molte ipotesi, accorgendosi alla fine di averne tralasciate altrettante.
Ombre, luci e poi ancora ombre
Suggerisce la logica che i popoli più antichi non avrebbero disseminato il globo di montagne di pietra, al prezzo tra l’altro d’immani fatiche, senza un valido motivo. Quale, non si sa. La simbologia iniziatica interpretò il punto come la Volontà originaria, prima Ipostasi dell’Uno, dando all’estensione della circonferenza il compito di rappresentare la totalità del generato. L’alchimia fece invece di questa forma il simbolo dell’oro; finché il progressivo ripiegamento dell’uomo su se stesso rese indecifrabile il simbolo, che finì tristemente i suoi giorni adagiato sul ventre molle dell’essere umano con al centro l’ònfalo, cioè l’ombelico.
Inutile dire che da questo punto sterile non è cresciuto alcun Albero cosmico, né qualcos’altro di realmente importante. Sarebbe tuttavia inutile arrovellarsi sulle cause che hanno portato a un simile degrado nel giro di poche migliaia di anni, che nella Storia equivalgono a un colpo di tosse. Passerà anche questo periodo, come ne sono passati tanti altri.
A patto che nel frattempo non ci si lasci distrarre da voci lusinghiere come quella dell’«effetto Flynn», la teoria creata appositamente per dare ad intendere alla moltitudine che il quoziente intellettivo della specie Homo è aumentato progressivamente nel corso del tempo. A parte il fatto che il linguaggio della Natura è troppo complesso per essere ridotto meramente ad mathematicam e perciò le percentuali lasciano il tempo che trovano, basta guardarsi attorno per accorgersi del contrario.
Non siamo più intelligenti dei nostri predecessori, né più stupidi, ma solo presuntuosi. Quando basterebbe poco per scendere dal piedistallo; per esempio, chiedersi come mai tutti i tentativi di dominazione universale messi a segno dall’evoluto Demens falliscono mentre il primitivo Sapiens è riuscito ad estendere la sua visione a tre quarti del mondo, e ancora se ne parla.
Troppo comodo dare la colpa alla complessità dell’attuale sistema, o all’estinzione del concetto di linearità che rende difficile la lettura del reale. Le cause vanno semmai ricercate nella frammentazione sociale e negli «innesti» di ogni genere (umani e tecnologici) imposti in assenza di una cultura, di una Civiltà. Ecco perché il Demens in un quadro di uniformità planetaria se tutto va bene fa cilecca altrimenti dis-integra, mentre il Sapiens ha integrato e costruito su larga scala operando nel regno della diversità.
Sotto tutti gli aspetti il suo cammino è stato più difficile del nostro; escludendo le emergenze ambientali (quelle autentiche, non mediatiche), si pensi che oltre a lui durante il Primo Grande Anno del nostro Manvantara erano presenti sulla Terra almeno altre tre specie: l’Homo Neanderthalensis, l’Homo di Denisova, l’uomo dell’Asia orientale o della Cina. Le differenze tra le parti erano enormi e riguardavano ogni ambito; eppure quei lontani portatori di precise identità culturali e biologiche sono riusciti a trovare la quadra, non sempre amandosi e talvolta odiandosi. Se non avessero agito in questo modo ognuno si sarebbe aggrappato al suo piccolo mondo non appartenendovi nei fatti, come accade oggi, sarebbero nate tante sub-culture difensive autoreferenziali in lotta tra loro e adesso noi non staremmo qui a raccontarci tante belle cose.
Apparteniamo a una specie ricca di risorse il cui aspetto più affascinante è indubbiamente la volubilità, giacché l’Homo Sapiens è anche Homo Demens. Da sempre lo strano ibrido che incarniamo si muove come un funambolo tra Apollo e Dioniso, sballottato tra ragione e sentimento, saggezza e follia, ordine e disordine, rigore ed eccesso, santità e delirio (E. Morin, Il paradigma perduto. Che cos’è la natura umana?, 2020). Per nostra fortuna non possiamo prescindere dal cammino tras-formativo, dagli alti e dai bassi, né dalle incertezze con le quali siamo obbligati a convivere. Ne consegue che dopo il tempo della follia viene quello della ragione, anche se non si può sapere in anticipo quando questo accadrà.

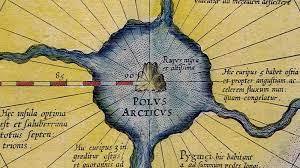

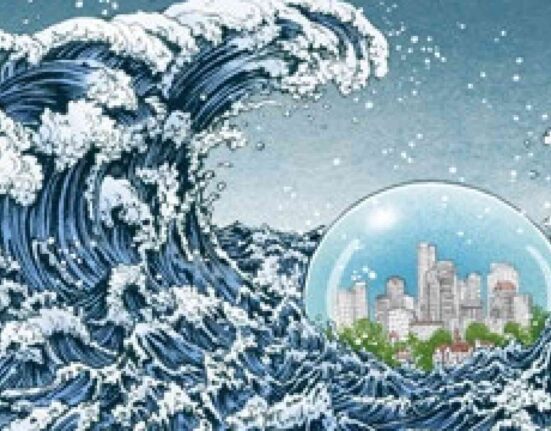
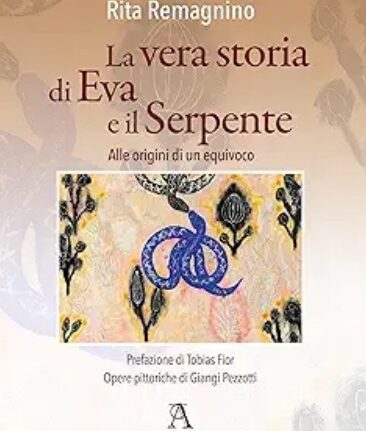


2 Comments