A occidente del continente eurasiatico il ritorno della luce dopo il buio autunnale è tradizionalmente presieduto da solari divinità maschili (Mitra, Gesù), oppure minacciato dai demoni, come nel caso dei krampus europei (letteralmente «morti putrefatti»), che terrorizzano i ragazzini delle aree ex-austro-ungariche prima di essere esorcizzati, ovvero sconfitti, da un San Nicola barbuto che assomiglia molto a Babbo Natale.
Lo scenario solstiziale cambia aspetto nelle aree continentali che hanno conservato più a lungo le tradizioni sub-artiche primordiali, dove il dio atmosferico che annuncia la fine del buio è spesso di genere femminile. Ne è un esempio il Giappone, dove gruppi di persone festanti si riuniscono ogni anno in occasione del solstizio d’inverno per celebrare e blandire la dea-sole Amaterasu, i cui capricci sono poeticamente immortalati nelle pagine del Kojiki (Mario Marega, Luni, 2018), il libro delle «vecchie cose scritte».
Per protestare contro le violente scorrerie del fratello e marito Susanoo (la Tempesta), la splendente Amaterasu va a rinchiudersi in una profonda caverna precipitando il mondo nella più profonda oscurità. Non potendo fare a meno di lei le altre divinità (i pianeti) la invitano ad uscire dal suo nascondiglio allestendo una serie di attività di disturbo. Battono sui tamburi e cantano a squarciagola, suonano cimbali e flauti, portano persino all’ingresso dell’antro un gallo (animale solare fortemente sciamanico) nella speranza che risvegli la dea con il suo canto squillante. Ma niente.
Finché a uno degli dèi viene un’idea: appende uno specchio a un albero, organizza un’allegra festicciola tra pari e chiede alla dea dell’alba e della gioia Ama-no-Uzume di esibirsi seminuda in una comica e licenziosa danza erotica. Divertito il pubblico divino ride e scherza chiassosamente suscitando la curiosità di Amaterasu, che sbircia fuori per vedere cosa sta succedendo.
Perché ridete? Chiede indispettita alle altre divinità. Io ho sprofondato il mondo nelle tenebre, e voi ve la spassate? Proprio così, le viene risposto, e siamo ben contenti di goderci lo spettacolo di una dea ancora più bella e promettente di te. Impossibile! Ribatte la vanitosa donna-sole avvicinandosi all’uscita per provare l’unicità ineguagliabile del suo splendore.
Svelto come un gatto il forte dio dei cieli l’afferra allora per un braccio. Tutti scoppiano a ridere, canzonando l’ingenuità con cui la dea è caduta nel tranello, e alla povera Amaterasu non resta che fare buon viso a cattivo gioco riprendendo il suo posto in cielo. Il sorriso torna così sul volto di tutte le creature celesti e terrestri, che salutano festosamente il ritorno della luce.
Probabilmente l’impresa di convincimento sarebbe fallita senza l’uso delle arti (danza, musica, burla, scherzo, gioco) che secondo Plotino non sono attività di secondaria importanza, come crede l’ignorante civiltà del profitto, ma hanno come scopo la conoscenza e la contemplazione da cui ogni prassi, sia necessaria che deliberata, attinge in varia misura.
Potrebbe derivare da remote visioni della realtà come quella descritta l’imperturbabile indole orientale, più «tagliata» della nostra alla cura delle attività meditative. Appartiene alla stessa famiglia il «sorriso di rottura», da noi puntualmente sottovalutato a vantaggio del ragionamento, in nome del quale ingaggiamo con i problemi quotidiani lotte furibonde. Ma non sempre riusciamo ad averla vinta, motivo per cui diventiamo spesso preda dei sensi di colpa, oppure inventiamo alibi per dare ogni responsabilità a fattori esterni, o, peggio, spingiamo la mente ad alimentare fantasie spaventose che ingigantiscono le difficoltà.
L’immaginazione può essere pericolosa perché una volta attivata va per conto suo, finendo non di rado per arrovellarsi sul «peggio» che ancora deve arrivare. Legittimamente si teme qualcosa che minaccia la vita, o l’incolumità, ma è controproducente attivare il meccanismo di allerta prima del tempo, e magari lavorarci su con la fantasia. Al prossimo disagio le risorse necessarie per fronteggiare il nuovo ostacolo saranno esaurite, così si andrà incontro alla paura disarmati.
Va detto comunque che l’istinto autoflagellatorio nella cultura occidentale non c’è sempre stato ma è il frutto di certe pieghe assunte negli ultimi secoli dalla Storia, dalla società e dalle religioni. Dopotutto usciamo anche noi dalla stessa matrice polare-eurasiatica che ha sfornato le più importanti civiltà sviluppatesi ad est del continente, comprensibilmente differenti, ma affini sotto molti aspetti.
In passato siamo stati campioni mondiali di umorismo, abbiamo inventato persino la commedia (V secolo a.C.), e da un punto di vista strettamente linguistico «comico» e «commedia» hanno una comune origine nell’antica radice indoeuropea aweid, da cui deriva il greco antico aedon, l’usignolo. Secondo la narrativa tradizionale l’uomo-Adamo nel mondo primordiale parlava la lingua leggera e musicale (poetica) degli uccelli, detta anche dell’«illuminazione solare» (loghah suryaniyah), o «angelica», l’unica in cui lo stato umano poteva esprimere la sua corrispondenza con il divino.
Tutto fa pensare che ai primordi il sorriso del cuore fosse la regola. Ma poi vi fu il brutto incidente che tutti conosciamo, il peccato originale, in seguito al quale il dono della vita divenne una specie di affronto dal quale derivarono il diritto alla tristezza e il dovere di espiazione.
Come possiamo rimetterci in pari e recuperare ciò che abbiamo perduto? Non affidandoci sempre e comunque al pensiero, ad esempio, o allargando a dismisura il suo campo d’azione in modo da stemperare l’evento negativo nello spazio e impressionare meno il cervello. Oppure, esercitandoci a creare ingegnosi cortocircuiti sulla falsa riga di quella che le antiche filosofie (dalla Cina alla Grecia) chiamavano «la logica del paradosso».
A questo proposito troviamo un altro spunto interessante in Giappone, dove la Tradizione trascurata pressoché dappertutto non ha mai smesso di parlare all’anima del popolo e tuttora rappresenta la base civile e sociale dell’intera nazione. Tra i vari aneddoti paradossali che circolano laggiù ve n’è uno relativamente recente. Alla fine della Guerra del Pacifico, il 15 agosto del 1945, non contenti della resa incondizionata del Paese gli americani pretesero che l’imperatore Hirohito dichiarasse pubblicamente di non essere una divinità di «stirpe solare». Ascoltando alla radio lo storico comunicato i Giapponesi, poco avvezzi alla logica massmediatica della teologia occidentale, ne dedussero che Hirohito doveva essere davvero un dio solare, perché solo un dio aveva l’autorità di fare una dichiarazione di enorme portata come quella mandata in onda sulla rete nazionale.
Ci voleva una mentalità «antica» come quella nipponica per giungere a una simile conclusione? Nessun altro ci sarebbe arrivato? In realtà alcuni motivi culturali riscontrabili nel mondo mitico del Giappone si ritrovano, mutatis mutandis, nell’intera cintura sub-artica, ivi comprese certe zone settentrionali del Nordamerica abitate da circa 30-20.000 anni da popoli di indubbia provenienza eurasiatica, tanto che per l’immensa area culturale e genetica che comprende buona parte dell’Europa si potrebbe utilizzare il termine ibrido «Eurasiamerica».
Alla fine dei conti siamo anche noi quella roba lì, e il nostro peccato originale non è quello descritto dalla narrativa vigente bensì il ripudio della Tradizione. Distaccandoci dalla radice ci siamo illusi di possedere poteri che l’uomo non ha mai avuto, né avrà l’ambizioso h+, o homo plus, o uomo virtuale. Più andremo avanti a sognare, sempre più inaccettabili ci sembreranno le luci e le ombre che appaiano e scompaiano sul cammino esistenziale di ciascuno seguendo le regole di un gioco creato appositamente per avvicinare l’uomo al divino.
Insistendo in questa direzione auto-condanniamo noi stessi a un triste tramonto. Nonostante gli sforzi non potremo mai capacitarci di come sia possibile che la risposta si trovi solo nella soluzione finale del mistero della natura umana, cioè in un’altra vita. Quando invece possiamo scoprire in qualsiasi momento di non essere in una «valle di lacrime» bensì in una commedia priva logica, buffa, imprevedibile, casuale, indomabile. Una messa in scena da affrontare con avveduta leggerezza alla luce del sorriso che le compete.
Ci sarà pure un motivo se il comune antenato indoeuropeo, abituato a mettere ogni singola parola sul bilancino di precisione, ha dato al termine «spirito» il duplice significato di umorismo e di spiritualità. La radice indoeuropea ghel, da cui proviene il termine greco «ridere», cioè ghelao (γελάω), designa «ciò che brilla», da cui la serenità tipica del sorriso che colora di gentilezza la vita. Non ultima la saggezza del solstizio d’inverno, che presentandosi all’appuntamento annuale in punta di piedi annuncia il ritorno della luce parlando la lingua brillante della brina, dei lunghi tramonti rossi, dei gelidi cieli stellati.
Se il solstizio d’estate ride, quello d’inverno sorride. Entrambe le manifestazioni sono comprese nel processo riflessoidale controllato dalla parte primitiva dei «tre cervelli», quella che governa alcune attività riflesse come il comportamento emotivo, e non dalla corteccia palleale che vigila sulle facoltà cognitive. Ma la respirazione cambia tutto. Il sorriso la lascia intatta, essendo una reazione «gentile». O disinteressata, se si vuole, in quanto slegata dalla lotta biologica per la sopravvivenza. E proprio per questo ispirata. Il riso invece interrompe il respiro, manca il fiato quando si ride a crepapelle.
Il sorriso è un’arte che ama il silenzio e la lentezza, il riso si presenta come una chiassosa azione di rottura sollecitata da un’emozione giunta al culmine che chiede una valvola di sfogo. Tranne l’uomo nessun animale è in grado di produrre il suo suono (alle iene lo abbiamo affibbiato noi), né si fa venire le lacrime agli occhi ridendo.
Il sorriso dichiara l’intenzione di manifestare deliberatamente uno stato di gioia e/o rilassamento, mentre la risata liberatoria rivela un «crollo» improvviso. Vero è che in entrambi i casi c’è la volontà di prendere le distanze da una circostanza ingessata dalla paura e dalle convenzioni sociali, ma l’«atto di protesta» del riso si consuma in fretta mentre la capacità di sorridere una volta acquisita dura nel tempo, trasformandosi in una predisposizione del cuore più centrata su forza, coerenza, autenticità, spontaneità, naturalezza. Libertà.
Allegoricamente il buonumore che subentra alla malinconia è assimilabile all’uscita dalla caverna (il buio autunnale) della dea-sole Amaterasu (il ritorno della luce) e rappresenta in modo plastico il «solstizio della vita terrena» di ciascuno. Quante volte si chiude una fase nera per aprire uno spiraglio alla luce! Il cambiamento è necessario come l’ossigeno, e poco importa se una (libera) azione proiettata nel futuro entrerà in rotta di collisione con la «realtà dominante».
Come dice lo Stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, nessuna strada è migliore di un’altra. Una strada è una strada, ciò che conta è camminare. E ogni specie è stata dotata da una Natura previdente del necessario per sopravvivere, rigenerarsi dopo il buio, curare le ferite fisiche ed emozionali, gestire le difficoltà.
Qualcosa si è rotto oppure è andato perduto strada facendo? Non è la prima né sarà l’ultima volta. I cocci possono essere raccolti e ricomposti in una nuova opera più bella e resistente della precedente. Le riparazioni si vedranno? Vorrà dire che le porteremo come medaglie al valore, essendo parte integrante della nostra storia. Sappiamo per esperienza che qualsiasi esistenza, persino la più perfetta, può rompersi con la stessa facilità con cui può ricomporsi.
Sulla scorta di questi sani principi tradizionali, che un tempo appartenevano anche alla nostra cultura, in Giappone i maestri kintsukuroi spolverano le crepe di un vaso rotto con della polvere d’oro, o d’argento, o di rame, mettendo in evidenza la riparazione per farne il simbolo della fragilità della vita, della sua forza e della sua bellezza. Il risultato è strabiliante. Percorso da linee che lo rendono unico nel suo genere, il «rottame» diventa una vera e propria opera d’arte. La casualità, o l’errore, l’hanno colpito ma non annientato, offrendogli la possibilità di avere un’anima nuova di zecca.
Tutto sommato è una fortuna che le cicatrici siano visibili perché tenendo bene in vista la riparazione di un danno, o la risoluzione di un fallimento, è possibile riderne senza farsi schiacciare dal peso delle frustrazioni. Non c’è motivo di ignorare ciò che tutti sanno: il buio tornerà, e con esso le ore tristi e gli scivolamenti. Elementi comunque insufficienti a rovinare l’armonia della vita presa nel suo insieme, una musica resa perfetta dal lavoro instancabile del mulino celeste che incessantemente divora e mette al mondo solstizi ed equinozi. Luci ed ombre.
A tutti gli amici di Ereticamente, buon Solstizio d’Inverno.


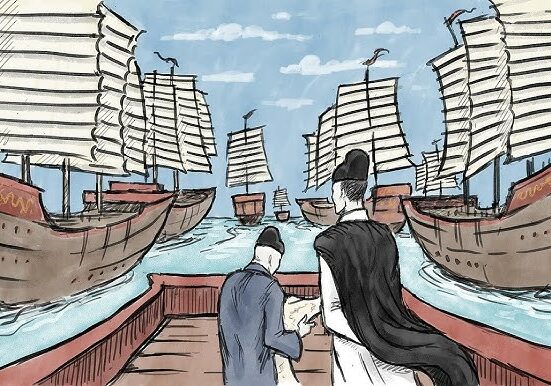
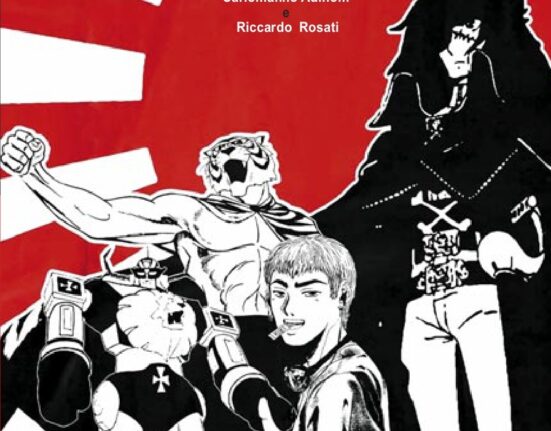




4 Comments