A conclusione di un processo avviato con l’illuminismo, antroposofia della Dea Ragione, la civiltà europea si è organizzata senza Dio, se non contro di lui. Dio è morto, come proclamò tra angoscia e aspettativa dell’Oltreuomo Friedrich Nietzsche. La nuova umanità ha dapprima messo sull’altare se stessa, quindi la Merce, il Consumo, succedanei del vero demiurgo, il danaro. Estenuato, sull’orlo di una crisi di nervi, l’ateo post moderno razionale ha poi finito per intronizzare il Nulla. Di qui disperazione, corsa all’effimero, smarrimento, perdita di direzione.
Specchio di questa perdita è l’arte. Spogliata di ogni trascendenza, si è dapprima centrata sull’uomo, per stancarsene presto, come dimostrano le arti figurative. La letteratura, in particolare la poesia, dialogo costante con il totalmente altro, sguardo gettato al di là dell’orizzonte, ricerca di verità, non è sfuggita alla regola della modernità, contribuendo a disseccare le fonti dello spirito, respingendo ogni possibilità di dialogo con l’Eterno. Tacere l’indicibile, l’incommensurabile, imperativo “logico” prescritto da Wittgenstein, è diventato la regola.
Tra i pochi che si sono sottratti al materialismo, condotta obbligata verso l’esito nichilista, fu uno dei giganti della poesia del Novecento, Thomas Stearns Eliot. Nato nel 1888, americano presto approdato in Inghilterra, patria dell’anima e terra degli antenati, ha percorso un itinerario intellettuale opposto a quello della maggior parte degli artisti del secolo. L’intera sua opera può dirsi cristiana, anche se la conversione ufficiale all’anglo cattolicesimo giunse alla metà degli anni 20, successiva al suo capolavoro poetico, La terra desolata, che è del 1922, agli Uomini Vuoti (1925) e alla prima prestazione giovanile, il Prufrock, del 1917.
Profondamente religiosi sono i suoi drammi teatrali, Assassinio nella cattedrale, sulla vita e morte di Thomas Becket, ministro del re inglese Enrico II, e Cocktail Party, ultima importante opera di Eliot (1950). Un altro grande componimento, pur con esiti artistici inferiori alle opere dianzi citate, furono i Cori della Rocca, scritti nel 1934 su richiesta della chiesa inglese per promuovere la costruzione di nuovi edifici religiosi nelle periferie operaie. Amico di Ezra Pound fin dal 1915, esponente dell’“imagismo’” che rinnovò le lettere britanniche, considerò il poeta dei Cantos come suo “miglior fabbro”, dal verso dantesco dedicato al poeta provenzale Arnaut Daniel, creatore del linguaggio poetico dei trovatori. A Pound, Eliot dedicò la Terra desolata, poema rimaneggiato nella forma e largamente tagliato dall’amico ed estimatore.
Il profondo amore per Dante e il Medioevo italiano è alla base del titolo del poema, The waste land, sempre tradotto come “terra desolata”, ma probabilmente ispirato da un verso dantesco: “in mezzo mar siede un paese guasto (Inf. XIV, verso 94). Guasto come il senso delle disperata accidia che pervade l’opera. Guasto come il mondo intero, privo di significato, in cui al crollo dei valori tradizionali non segue la nascita di nuovi principi. Un mondo di morti viventi, che il poeta, già interiormente cristiano, coglie nel momento dell’esodo, dell’attesa indistinta di un secondo avvento. Significativo dello squallore che diventa guasto è il legame tra la Terra desolata e il poema premonitore del genio eliotiano, il Canto d’amore di J. Alfred Prufrock, in cui l’io narrante è il poeta ventottenne che parla di sé come di un vecchio senza speranze, disilluso, in bilico tra autoironia e disperazione, sino a prorompere nel verso “No, non sono il principe Amleto”.
Il mondo guasto è lo stesso sperimentato nella giovinezza spesa in un’atmosfera di religiosità falsamente puritana, mascherata nell’esteriorità degli atti, soddisfatta del successo mondano, di cui era espressione il fratello maggiore. In radicale contrasto con quell’ambiente, alla ricerca di valori permanenti, il giovane Eliot sembrò trovarli nell’opera di un filosofo inglese del tempo, Francis H. Bradley, avversario dell’utilitarismo, dell’edonismo e del formalismo kantiano, convinto dell’insussistenza di valori individuali fuori dalla comunità.
Dalla fine degli anni 10, Eliot scrisse diverse recensioni di teologia e di indagine religiosa per il periodico International Journal of Ethics, a comprova di come la ricerca spirituale fosse presente nell’animo suo ben prima della conversione. Simbolo di questa fase di passaggio dal vuoto di un mondo guasto alla lenta consapevolezza salvifica della verità cristiana è il personaggio di Sweeney, figura tragica e insieme grigia, immagine dell’uomo medio mediocre, con la sua miseria morale, l’assenza di principi. Sweeney vive squallide avventure, il suo stesso nome richiama il maiale (swine, suino), la sua esperienza si risolve in un nefasto, meccanico senso della vita: “nascita, e copula, e morte”.
Il momento di svolta di Eliot avviene con la composizione del Gerontion, in cui il tema della rinascita, dell’uscita dal mondo guasto si definisce nell’attesa della pioggia, l’acqua che salva, purifica, rigenera: “Eccomi qui, vecchio in un mese arido/mentre un ragazzo mi legge, aspettando la pioggia.”
E’ la medesima attesa di un’intera civiltà che pervade e conclude la Terra desolata, preludio di una poetica che, dopo la conversione, si sarebbe trasformata progressivamente in meditazione religiosa. Esplicita diverrà la condanna per la fredda, materialistica intellettualità del deismo in cui crebbe, in favore di una religiosità fondata sull’incarnazione, la rivelazione e il riconoscimento della limitatezza dell’essere umano. Negli anni 30 Eliot accettò due commissioni dal vescovo di Chichester, che portarono ai Cori della Rocca, una sorta di sacra rappresentazione medievale dagli esiti poetici diseguali, e alla pièce teatrale Assassinio nella cattedrale. La vicenda di Thomas Becket, martire del Medioevo, arcivescovo ucciso da sicari reali nella sua chiesa di Canterbury fu concepita come una tragedia greca in era cristiana, con le donne in funzione di coro e l’immagine del Purgatorio dantesco.
Tutta la cultura di Eliot fu volta a mettere in relazione, legare, presentare idee e immagini nitide, pure, delineate, secondo la prassi letteraria dell’imagismo che egli chiamò “correlativo oggettivo”. La sua ricerca, letteraria, morale, filosofica, spirituale avanzò negli anni sino a un verso rivelatore di East Coker, uno dei Quattro Quartetti, l’ultima opera capitale del poeta: “I vecchi dovrebbero essere esploratori”.
Viene alla memoria un verso leopardiano della Quiete dopo la tempesta: “e chiaro nella valle il fiume appare.” Il cammino di Eliot ci sembra simile: nel Prufrock ogni cosa è indistinta, banale la condizione del protagonista, drammatico il grigiore morale della vita di un’umanità divenuta certa dell’inesistenza di altri universi, insostenibile la ripetitività dei gesti, delle azioni, la noia inevitabile dell’annegamento dentro la realtà, espresse anche nell’iterazione delle frasi. “Perché già tutte le ho conosciute, conosciute tutte. / Ho conosciuto tutte le sere, le mattine, i pomeriggi/ Ho misurato la mia vita con cucchiaini da caffè;// E ho conosciuto tutti gli occhi, conosciuti tutti. / E ho già conosciuto le braccia, conosciute tutte.” La contemporaneità, sembra dirci Eliot, si risolve in noia, guasto, desolazione. Non appare, dopo la tempesta, il fiume sereno della fede nutrito di speranza.
Parla in Prufrock l’uomo contemporaneo, animale ammaestrato che corre nella gabbia, costretto a esperienze sempre nuove, forzato a alzare continuamente l’asticella, prigioniero di una corsa per sfuggire il fantasma del Nulla. Uomini alla deriva come detriti, la superbia che ammutolisce di fronte al nichilismo. Nella Volontà di potenza (che ormai sfuma nel suo contrario) Nietzsche così definisce il nichilismo, già analizzato nel personaggio di Bazarov da Turgenev in Padri e figli: “significa che i valori supremi si svalutano. Manca lo scopo. Manca la risposta al perché. Il nichilismo radicale è la convinzione di un’assoluta insostenibilità dell’esistenza.” Il XX secolo, e con più accanimento il primo tratto del XXI tacciono sui perché, li escludono accanitamente, si accontentano di scoprire le leggi fisiche della natura per utilizzarle a scopo di dominio.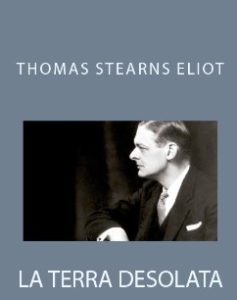
Non vi è chi non veda l’aridità di un mondo siffatto, ricacciato talvolta nella superstizione come antidoto alla perdita dei valori. Nella Terra desolata tale è il ruolo di Madame Sosotris, la chiromante raffreddata ed imbrogliona, chiamata “la donna più saggia d’Europa”. La metafora della Terra desolata ricalca e chiarisce la lirica Gerontion, il tema dell’attesa di pioggia, la rigenerazione, l’avvento, insieme con la necessità di attraversare il presente per ricercare la salvezza nel Tempo.
Desolazione è innanzitutto sterilità. Il poeta ricorre alla leggenda del Graal, alla figura del Re Pescatore, reso impotente da una mutilazione o dalla malattia. La maledizione sarà scacciata solo all’arrivo di un cavaliere che chiederà il senso dei vari simboli che gli vengono mostrati. C’è un passaggio dalla sterilità fisica a quella spirituale che Eliot non sa ancora risolvere, ma diventa preludio della rigenerazione a seguito della (ri)scoperta del senso cristiano della vita, raggiunta nelle opere successive. Nella Terra Desolata centrale è la figura di Tiresia, l’indovino cieco, la concitazione di un incontro che si dispiegherà nell’aspettativa finale di rigenerazione, anticipata nell’allegoria della “morte per acqua”, cui è affidata la funzione di evidenziare la forza del pentimento (l’acqua che lava la colpa) indiscutibilmente cristiana. Solo aspettativa, tuttavia, giacché la Terra desolata ha un finale sospeso, la speranza non è ancora approdata alla certezza: “Riuscirò alla fine a porre ordine nelle mie terre?”.
La circolarità è forse la cifra più netta del pensiero di Eliot; si respira un’aspirazione alla nascita, al ritorno, la formazione di una spiritualità nella desolazione sacrificale del deserto. “Prega per noi ora e nell’ ora della nostra nascita.” Particolare è l’incipit della Terra desolata, una sorta di maledizione alla primavera (Aprile è il mese più crudele, genera lillà da terra morta), sino all’elogio inaspettato dell’inverno, che “ci mantenne al caldo, ottuse con immemore neve la terra, nutrì con secchi tuberi una vita misera.” Salta agli occhi l’analogia con l’Europa orientale e la Russia, il cui inverno di materialismo ateo e collettivista ha paradossalmente conservato lo spirito profondo dei popoli, sino alla rigenerazione successiva, al contrario dell’Occidente guasto, irrimediabilmente ferito da un altro materialismo, quello consumista e individualista.
La speranza, tuttavia, balugina tra i frammenti della desolazione, in cui, simile al risorto di Emmaus, qualcuno ci affianca silenzioso: “chi è il terzo che sempre ci cammina a fianco? / Se io conto, ci siamo soltanto io e tu insieme /Ma se io guardo innanzi a noi per la strada bianca/ c’ è sempre un altro che ti cammina a fianco. “Degli stessi mesi della Terra desolata è un’altra lirica, Gli uomini vuoti. Non c’è più lo sguardo che vede l’Altro, ma riaffiora l’uomo del presente corrotto, vuoto, impagliato. “Siamo gli uomini vuoti/ siamo gli uomini impagliati / che appoggiano l’un l’altro/ la testa piena di paglia” Un’umanità transumante senza forma, ombre senza colore, paralizzate, dai gesti meccanici.
Colpa della vita condotta nella dialettica del profitto e della perdita, la triste partita doppia tesa al conseguimento dell’Avere che li ha privati dell’anima. Il corpo non è che un guscio sostenuto con i puntelli dell’impagliatura, ovvero i riti, i miti, le sciocche credenze della società guasta. Sono venuti meno gli occhi, il mezzo per stabilire la conoscenza diretta del mondo, e di sé per mezzo del mondo. Nell’ultima parte, un barlume di speranza riappare, ma resta un girotondo, poiché “fra il gesto è l’atto cade l’Ombra, perché Tuo è il Regno”, invisibile agli uomini vuoti, impagliati, senza occhi, lontani dalla trascendenza, incapaci di vedere immersi nella greppia quotidiana. Il poema termina con una lucida epigrafe della modernità, un verso ripetuto tre volte: “E’ questo il modo in cui il mondo finisce/ non già con uno schianto ma con un piagnisteo.”
L’itinerario di Eliot ha molto in comune con un opera assai popolare della letteratura inglese, quella sorta di preghiera penitenziale che è il Viaggio del Pellegrino di John Bunyan, contemporaneo di Milton. Tutta l’opera successiva è impregnata della fede riconquistata, a partire dal colto Animula del 1930, amplificazione del canto XIV del Purgatorio, in cui Marco Lombardo prende posizione sul tema della libertà e del libero arbitrio, ricordando vigorosamente le responsabilità umane, non divine delle colpe degli uomini.
Un discorso a parte meritano i Cori della Rocca, spesso trascurati dalla critica, l’opera militante dell’intellettuale cristiano. Come nella tragedia greca, essenziale è il ruolo del coro, contrappunto e voce morale di un’epoca che si è liberata di Dio. L’invenzione infinita, l’esperimento infinito, portano conoscenza del moto, non dell’immobilità; conoscenza del linguaggio, ma non del silenzio. Conoscenza delle parole e ignoranza del Verbo. “Tutta la nostra conoscenza ci porta più vicini alla nostra ignoranza”. Pure, gli uomini delle periferie cui si rivolge Eliot, non ne vogliono sapere: abbiamo troppe chiese e troppo poche osterie. La società si è costruita su valori di individualismo estremo, che hanno condotto alla perdita di ogni senso di comunione, perfino di convivenza e vicinato. L’estraneità degli alveari urbani e suburbani ci frusta e Eliot si chiede: Ma voi avete edificato bene, che ora sedete smarriti in una casa in rovina?
In un coro successivo, si celebra la ricostruzione di Gerusalemme sotto la dominazione persiana, “con una spada in mano e la cazzuola in un’altra”. La vita è lotta, dunque, innanzitutto nella dimensione spirituale, dimenticata la quale l’umanità smarrisce se stessa: “Là dove non c’è tempio non vi saranno dimore. / Sebbene abbiate rifugi e istituzioni/ alloggi precari dove si paga l’affitto.” Il settimo coro enuncia una verità drammatica, peculiare del mondo contemporaneo. Gli uomini evitano le scelte, né accettano né negano Dio, semplicemente lo ignorano. Hanno spostato l’oggetto dell’adorazione, il Denaro, il Potere, e prima la Classe o la Razza. C’è una terzina potente e indignata nel settimo coro: “quando la Chiesa non è più considerata, e neanche contrastata, e gli uomini hanno dimenticato tutti gli dei, salvo l’Usura, la Lussuria e il Potere”.
Folgorante è anche il giudizio sul presente: gli uomini d’oggi non “deporranno la croce, perché mai l’assumeranno. “E comunque, la Chiesa, la Rocca, ma anche la Straniera, dov’è? La risposta di Eliot è un’angosciosa domanda su cui meditò Luigi Giussani: è l’umanità che ha abbandonato la chiesa, o è la chiesa che ha abbandonato l’umanità? Deserto e vuoto, e tenebre sopra la faccia dell’abisso. Ma la vita si rigenera, si ricostruisce, sempre nascono nuovi edifici. La conclusione della Rocca è quanto di più religioso sia stato scritto da un poeta nell’ultimo secolo: “e noi ti ringraziamo che la Tenebra ricordi a noi la luce, o Luce invisibile”. Purché la caverna di Platone non abbaia completamento accecato gli uomini vuoti, gli uomini impagliati.
L’intera opera di Eliot è attraversata dalla certezza che vi è un ordine oltre la dissoluzione, il cui culmine poetico sono i Quattro Quartetti, una successione di meditazioni teologiche e cosmologiche. Trovata la fede, la ricerca procede sui suoi fondamenti, rivisitando i luoghi significativi per il poeta, inseriti nel tempo e nello spazio concreto, se davvero vuole comprendere il senso della propria presenza del mondo, concepirne la permanenza fuori dallo spazio e dal tempo. Un’operazione assai diversa dalla constatazione della “gettatezza” (geworfenheit) esistenziale di un Martin Heidegger. “Essere consapevoli significa non essere nel tempo/Però solo nel tempo può l’attimo nel roseto / …/ e essere ricordato. “
La profondità dei Quartetti (intitolati a luoghi legati alla vita del poeta) muove dall’indagine sulle contrapposte filosofie di Eraclito e Parmenide. Per l’uno, l’essenza delle cose è il divenire, per l’altro il reale “è”, poiché se fu non è, e così non è se dovrà essere in futuro. (Frammenti). In Eliot la soluzione è nella bellezza dell’arte, la quale, pur inserita nel tempo, è immagine dell’eterno, misura ordinatrice, non esoterica ma non immediatamente rivelata, intuita, attinta con occhi immateriali. Un altro tema cui non è estranea la fede è il ritorno, il compimento del ciclo, tanto in termini spirituali che materiali.
Ne è simbolo il Quartetto East Coker, dal nome del villaggio inglese da cui partirono per l’America gli antenati del poeta nel XVII secolo, a cui egli fa ritorno sino a farne il luogo della sua sepoltura: “nel mio principio è la mia fine e nella mia fine è il mio principio”, in epigrafe il motto della dinastia cattolica degli Stuart. In un altro quartetto, Dry Salvages, viene introdotta l’immagine del fiume – probabilmente il Missouri della sua infanzia – simbolo del tempo distruttore, rammemoratore di cose che non durano, strumento infido di commerci fini a se stessi. Ma il fiume procede verso l’eternità rappresentata dal mare; ancora il motivo della purificazione rappresentato dall’acqua, con una elevata preghiera alla Vergine, figlia del suo figlio in termini danteschi, affinché con la sua purezza pontificale, punto di incontro, ponte tra il tempo, l’uomo e il divino, interceda in favore di tutti coloro che solcano il mare dell’esistere, compresi quelli che hanno fatto naufragio.
Thomas S. Eliot fu anche un grande animatore artistico, dominò per decenni il panorama culturale inglese, e la funzione catartica, rigeneratrice dell’arte fu una costante del suo orizzonte. L’arte deve determinare una serenità complessiva volta a favorire un ordine della realtà. Critico intransigente della società contemporanea, di cui antivedeva gli sbocchi nichilisti ed egoistici, pubblicò anche un saggio intitolato L’ idea di una società cristiana. Testo dalle ambizioni politiche più che filosofiche, enuncia con precisione le idee che hanno compromesso la nozione di cristianità, quelle democratiche e quelle liberali. Queste ultime hanno costruito una società in cui l’uso delle risorse naturali (e delle persone degradate a risorse umane) si è trasformato in sfruttamento a vantaggio di pochi; le prime, lungi dal rappresentare un’alternativa esistenziale, propongono di estendere all’infinito il medesimo sfruttamento. Una marmaglia, spiega, non cesserà di essere marmaglia perché è ben nutrita, ben alloggiata e ben disciplinata. Si avvertono gli echi dell’avversione eliotiana allo stalinismo e al nazismo. Per contro, la sua idea di tradizione è, per così dire, dinamica: “La tradizione, da sé sola, non è sufficiente; deve essere criticata continuamente e aggiornata sotto la supervisione di ciò che io chiamo ortodossia. “
In conclusione, un’opera di straordinario rilievo artistico e di elevata tensione morale, la cui lettura ci sentiamo di consigliare, magari nelle edizioni con testo a fronte, al fine di apprezzarne, per chi è in grado, il terso, classico inglese. Quella di Thomas Stearns Eliot fu una vita di altissime, energiche prestazioni intellettuali al servizio di una visione spirituale dell’uomo, intimamente cristiana. Molto originale è la ragione del suo rifiuto della riforma protestante, considerata un’aberrazione dottrinale, aver proceduto da un’unica rivelazione a tante spicciole rivelazioni quanti sono gli uomini che scelgono di leggere le scritture.
L’approdo fu il canone di una cattolicità diffusa, intesa come tragitto verso l’unità morale del popolo cristiano, innanzitutto delle genti europee che accolsero il messaggio dell’uomo di Nazareth. Unita alla portentosa eredità di Atene e al rigore romano, ne fecero la civiltà comune di un continente oggi morente, terra guasta, desolata di uomini vuoti, impagliati per aver smarrito se stessi insieme con il loro Dio.
ROBERTO PECCHIOLI







