di Franca Poli
Aprile, la guerra era finita, terminati da poco i bombardamenti erano arrivati gli alleati, i liberatori, e la gente provata dai sacrifici aveva creduto paradossalmente nella loro venuta disinteressata e missionaria. Alcuni si erano sentiti davvero liberati, non certo da un regime che aveva dato sicurezza, lavoro e giustizia sociale, ma dallo sgomento ossessivo della guerra che li aveva terrorizzati atrocemente con fame, morte e distruzione. Una strategia del terrore portata ai massimi livelli nei mesi precedenti con lo studio a tavolino di colpi di mano, attacchi, attentati, finalizzati soltanto a provocare la reazione dei nazisti e le conseguenti rappresaglie, un disegno psicologico, strategico che aveva esasperato gli animi, fiaccando il morale della popolazione umile e orgogliosa.
Subito dopo il cessare delle ostilità, proprio quando tutto sembrava finito, i Partigiani usarono una ferocia inaudita verso civili inermi, certi della totale impunità poiché avevano occupato, coi loro uomini, i centri di potere e controllo, i Comuni e le Questure. Episodi drammatici causati da motivi non soltanto politici, ma soprattutto ritorsioni, delinquenza comune, odio di classe. Negli anni sono emerse tante scomode verità sulle quali la storiografia ha steso un colpevole velo d’oblio, verità che la “democratica” Italia ha taciuto, nascosto, insabbiato. La longa manus dei centri di potere della sinistra italiana, così come i media e le case editrici, hanno coperto per anni le atrocità commesse. Cito uno su tutti il professor Gianfranco Stella che provò a raccontare i fatti avvenuti e gli omicidi perpetrati dai partigiani nel triangolo rosso, ma fu denunciato e mandato per ben due volte sotto processo.
Sono innumerevoli i casi successi, ma vorrei soffermarmi a raccontare, in particolare, qualche accadimento della zona di Conselice, paese (che conosco bene) situato al centro di un ipotetico triangolo che ha come vertici le città di Ravenna, Ferrara e Bologna. In un territorio a economia prevalentemente agricola, l’eredità della guerra erano macerie e rovine, nel 1945 risultavano perduti il 60 per cento dei raccolti, il 50 per cento delle trattrici agricole e l’80 per cento del bestiame e del pollame. Dopo i bombardamenti a tappeto e gli spezzonamenti aerei, le interruzioni stradali, ferroviarie e delle linee telefoniche, mantennero quella zona nell’isolamento totale per lunghi mesi. Mesi in cui la popolazione civile cadde in mano di uomini senza scrupoli che fregiandosi del titolo di “resistenti” e “vincitori” fecero il bello e il cattivo tempo minacciando, saccheggiando, uccidendo, rubando in quella terra già così devastata e tutto ciò che di terribile accadde in quei mesi rimase per anni smarrito nella nebbia, fra i piatti orizzonti delle campagne circostanti.
 La violenza si intensificò dopo la liberazione anche grazie al lievitato numero di “combattenti” che avevano aderito alla resistenza dopo il cessare delle ostilità, soltanto per chiudere vecchi e nuovi conti col fascismo e con i paesani, anche non fascisti, in un clima di tensione sempre crescente e molti innocenti pagarono con la vita. Nel solo comune di Conselice si registrarono 132 vittime civili (senza contare le sparizioni) di cui a lungo si dimenticarono volutamente i nomi e si nascosero i cadaveri, mentre dei 29 uccisi dai nazisti durante la guerra, ancora oggi, si trova memoria nei cippi marmorei lungo le strade di campagna.
La violenza si intensificò dopo la liberazione anche grazie al lievitato numero di “combattenti” che avevano aderito alla resistenza dopo il cessare delle ostilità, soltanto per chiudere vecchi e nuovi conti col fascismo e con i paesani, anche non fascisti, in un clima di tensione sempre crescente e molti innocenti pagarono con la vita. Nel solo comune di Conselice si registrarono 132 vittime civili (senza contare le sparizioni) di cui a lungo si dimenticarono volutamente i nomi e si nascosero i cadaveri, mentre dei 29 uccisi dai nazisti durante la guerra, ancora oggi, si trova memoria nei cippi marmorei lungo le strade di campagna.A Conselice, Lavezzola e Massa Lombarda operava l’unità partigiana “Umberto Ricci” della 28a Brigata Gap, la dirigevano il comandante Idalgo Tampieri, il suo vice Dergo Donigaglia e il commissario politico Silvio Pasi (detto Elic), a guerra finita i disertori gappisti, non dovevano più vivere alla macchia e allestivano depositi di armi nei rifugi provvisori, i cosiddetti “buchi “, costruiti durante gli ultimi mesi di guerra, lungo gli argini dei fiumi.
Il primo a raccontarmi una storia accaduta alla sua famiglia è stato M. che fa il cameriere in una pizzeria e mi ha parlato di una sua parente, Lucia. Poco più che ventenne, una sera di fine maggio venne fermata dal Donigaglia e da alcuni suoi uomini, mentre percorreva in bicicletta la via Selice, che conduce alla frazione di Lavezzola. La ragazza venne portata a Villa Fernè, famigerata sede del comando della Polizia partigiana, dove fu violentata, bastonata e derubata di quarantamila lire che custodiva nella borsetta. Infine, condotta in aperta campagna, fu uccisa, sepolta e il povero corpo martoriato, fu rinvenuto soltanto nel 1949. Successivamente uno zio, tornato illeso dalla guerra, dopo aver prestato servizio nella Repubblica Sociale, fu costretto a pagare un riscatto in denaro sonante per non essere prelevato e ucciso a sua volta. Appartenevano entrambi a una famiglia benestante che aveva aderito al Fascismo e il nonno, data la precedente sparizione, pagò di buon grado per salvargli la vita, senza mai denunciare l’estorsione. Ancora oggi il nipote, dopo avermi raccontato la storia, non vuole che io faccia il suo nome a testimonianza del terrore inculcato per anni in famiglia a tutti i discendenti.
Dopo la cosiddetta liberazione, al cumulo delle macerie, si aggiunse così quello delle paure, delle sofferenze, dei lutti, degli odi profondi e dei risentimenti. Riporto la testimonianza di un partigiano Fiorenzo Tasselli: “ Eppure mi rimangono in memoria delle incisioni profonde che non mi abbandoneranno mai, immagini di morte e di dolore, solchi di sentimenti violenti; è difficile trovare serenità nei ricordi di quei tempi” (da “Angelo Babini “) Sul finire degli anni ’90, Tarlazzi Severino detto Padèla,un partigiano resosi colpevole della partecipazione a numerosi atti di violenza nella zona, si uccise sparandosi in testa
. Nel biglietto lasciato spiegava che non riusciva più a convivere con “certi pensieri”.
. Nel biglietto lasciato spiegava che non riusciva più a convivere con “certi pensieri”.
Nel conselicese, come nei comuni vicini Lugo, Massa Lombarda e limitrofi, si verificarono numerosi episodi che l’arciprete del paese aveva già predetto all’indomani del 25 luglio 1943: vendette e ritorsioni, delitti politici talora mirati, ma più spesso indiscriminati, poiché come detto, essendo totalmente assente ogni qualsivoglia forma di autorità costituita, i partigiani, detentori di armi e mezzi, agivano indisturbati dettando legge.
Ancora oggi i vecchi raccontano sottovoce, ricordando i nomi delle vittime, di quel lontano maggio 1945. Era il giorno 9, da due persone a bordo di una motocicletta vennero uccise davanti le loro case a sangue freddo: Anello Volta economo comunale, Albo Negrini padre di un giovane che aveva aderito alla RSI, il prete di Spazzate Sassatelli don Tiso Galletti senza che avesse nessuna colpa e, il caso più eclatante, a testimoniare quanto fossero sommarie e affidate a persone senza scrupoli le esecuzioni di sentenza di morte, anche un tale Aristide Olivieri, che era semplicemente omonimo di un noto gerarca fascista di Conselice.
Il falegname Francesco Rambelli, 61 anni, di Lavezzola (frazione di Conselice) era titolare di una avviata segheria dove costruiva, con un buon margine di guadagno, cassette per la frutta. Nel periodo della guerra si era trasferito a Ferrara e subito dopo la liberazione i partigiani avevano arbitrariamente, in una sorta di esproprio proletario, preso possesso della sua attività.
Nell’estate del ’45 il falegname aveva comunicato a un paesano la decisione di ritornare al suo lavoro a Lavezzola, ma durante il tragitto in bicicletta, la mattina del 30 giugno, con la moglie Doradina e la figlia Nara che allora aveva solo diciassette anni, fu bloccato a un “posto di controllo”. Tre partigiani dopo aver chiesto loro i documenti e assicuratisi così della loro identità, li condussero nei pressi delle valli di Campotto, li crivellarono di colpi di pistola e se andarono lasciandoli sul margine della strada, non prima di aver rubato tutto quanto possibile: orologi, denaro, un braccialetto d’oro, le biciclette e finanche le scarpe. Le due donne morirono immediatamente, mentre il capo famiglia, pur ferito in modo grave, sopravvisse. Coperto di sangue trovò la forza di ergersi per chiedere aiuto a un camionista di passaggio il quale vedendolo ridotto in quello stato ebbe paura e fuggì, così con la forza della disperazione, il Rambelli si trascinò in mezzo alla carreggiata e il successivo mezzo di passaggio fu costretto a fermarsi. Trasportato all’ospedale e curato, si salvò. Appena ne fu in grado, avendo ben riconosciuto gli aggressori suoi paesani, si recò in Questura a Ravenna a presentare denuncia, ma la cosa ovviamente non ebbe nessun seguito e, trascorso qualche tempo, Rambelli incontrò gli stessi indicati alle forze dell’ordine aggirarsi tranquilli per le strade di Lavezzola, dove era dovuto, controvoglia, tornare per cercare di vendere la sua falegnameria. Il desiderio, mai sopito,di avere giustizia lo portò a presentare una nuova denuncia, questa volta ai Carabinieri di Argenta un paese in provincia di Ferrara. Fu così che i tre giovani colpevoli (Panfilio, Baldassarre e Corbia) vennero arrestati, processati e condannati, ma non scontarono più di cinque anni perchè nel frattempo sopravvenne l’amnistia voluta da Togliatti che liberò dalle carceri tutti i “compagni” che, nonostante le coperture, non erano riusciti a cavarsela impunemente. La cosa più sconvolgente per il Rambelli, fu prendere atto che era stato condannato a morte, non per i suoi inesistenti trascorsi fascisti, ma proprio perchè titolare di una avviata attività che con la eliminazione totale della famiglia, avrebbe consentito la creazione di una “segheria del popolo”.
Fra i numerosi e tragici episodi di violenza accaduti in quel periodo quello che ha segnato il punto massimo di acutezza e che ancora è oggetto di varie indagini storiografiche è stato l’eccidio dei conti Manzoni, non tanto per, il pur non trascurabile numero delle vittime, ma perchè rispecchia più di ogni altro il clima di intolleranza e di odio di classe diffuso nelle campagne romagnole contro i cosiddetti “padroni”, persone colpevoli soltanto di essere possidenti.
La famiglia dei conti Manzoni era proprietaria di una buona parte di terreni nel comune di Conselice, fra le frazioni di Lavezzola e Voltana e di una grande villa “La Frascata”, sita nel comune di Lugo, dove avevano la loro residenza. In quei mesi del ’45 vi abitavano i figli Giacomo di 41 anni che si occupava esclusivamente della tenuta, Luigi trentottenne diplomatico che aveva prestato servizio presso il Ministero degli Esteri nella Repubblica Sociale e Reginaldo che invece era professore e direttore dell’istituto di Chimica all’università di Bologna. Con loro abitava la madre vedova del conte Giuseppe, la signora Beatrice Manzoni Ansidei di 61 anni. Per questa donna conosciuta da tutti i concittadini come buona e gentile vorrei spendere due parole di più. Era dedita alla carità, fervente cristiana, generosa e di una dolcezza infinita. Allo stesso tempo era però una donna arroccata su vecchie tradizioni nobiliari, e di conseguenza pretendeva il rispetto dovuto al suo rango. Per questo motivo, non sempre fu capita e amata anche se nota a tutti per le opere di beneficenza. Presidente dal 1931 della congregazione San Vincenzo provvedeva anche alla vendita di poderi della proprietà, se si rendeva necessario a soddisfare le esigenze dei braccianti.
“L’immensa fortuna, la grande tenuta appartenente in antico ai Bentivoglio, scemava lentamente da quando la contessa aveva deciso di vendere un podere ogni anno a beneficio dei suoi coloni e dei suoi paesani” (G. Stella – L’eccidio dei conti Manzoni).
Altri proprietari terrieri, dopo la guerra, si erano momentaneamente allontananti dalla zona per mettersi al sicuro, ma non lei, non i Manzoni “che nulla avevano da temere”. Si sbagliava la contessa: la sera del 7 luglio 1945 un gruppetto di partigiani di Lavezzola fece irruzione nella villa. Nemmeno preoccupati di coprirsi il volto, caricarono con la forza su due auto tutti gli appartenenti alla famiglia, la domestica Francesca Anconelli e il cane di casa.
Giunti in località Villa Pianta li fecero scendere e li uccisero tutti, vigliaccamente, cane compreso. I cadaveri furono occultati in una buca anticarro costruita dai tedeschi e la loro ignota sepoltura durò fino al 1948. La sera stessa della sparizione, gli assassini si recarono a depredare la villa caricando su di un camion ogni bene possibile appartenente alla famiglia: oggetti di valore e vestiario, gioielli, fucili, macchine fotografiche e libri. La rapina aveva lo scopo ulteriore di avvalorare la tesi menzognera che i conti erano fuggiti volontariamente in America.
Solo tre anni più tardi, quando i partecipanti all’eccidio iniziarono a far uso per se stessi o per le mogli degli oggetti riconosciuti come appartenuti ai conti: fucili da caccia, pellicce e gioielli, qualcuno richiese un approfondimento di indagini. Un testimone rilasciò finalmente ampia confessione e i resti dei conti Manzoni vennero dissepolti. Da un’autopsia successiva si appurò che i tre figli e il cane erano deceduti in seguito a ferite da arma da fuoco, per le due donne invece la morte era sopravvenuta a causa di colpi da corpo contundente.
Fra i principali imputati risultò Silvio Pasi, capo partigiano, medaglia d’argento al valor militare che, quando venne arrestato, rivestiva il prestigioso incarico di segretario della Camera del lavoro di Faenza. Le indagini e le testimonianze stabilirono che era stato proprio lui l’organizzatore dell’impresa, compartecipata dai comandanti Tampieri e Donigaglia, da Martini Ettore e altri ancora che formano un lungo elenco di assassini impuniti, fuggiti in Cecoslovacchia o che anche dopo la condanna all’ergastolo, ridotta successivamente a 28 anni per “motivi politici”, scontarono al massimo sei anni di carcere effettivo. Infatti, nonostante le aggravanti di occultamento di cadaveri e di rapina, usufruirono dell’indulto per reati politici e di natura militare commessi tra l’8 settembre 1943 e il 18 giugno 1946.
Gli imputati inoltre, avevano nell’occasione, come molti altri in casi analoghi, beneficiato della difesa legale gratuita offerta dal comitato “solidarietà democratica” a dimostrazione che in quei primi anni del dopoguerra ci fu un “movimento” che aveva avvelenato le coscienze, nascosto le verità, falsato la realtà, deviato le intelligenze, anche di persone in buona fede, con l’unico scopo che l’Italia potesse diventare una repubblica popolare socialista-leninista il cui fulgido esempio era la Russia di Stalin.
E mentre a Lugo si discute ancora oggi, se intestare una via alla contessa Manzoni, va detto che invece il Pasi tornò a casa a testa alta, ricevuto con tutti gli onori dai suoi concittadini e nel 1958, a simbolica compensazione della medaglia al valor militare revocatagli dopo la condanna per omicidio, Luigi Longo, già “degno” comandante generale delle Brigate Garibaldi e dirigente nazionale del PCI, lo insignì della Medaglia d’oro al merito partigiano.(fonte biografia Pasi – A.N.P.I).
In conclusione, il protrarsi della violenza ben dopo il 25 aprile non si può dimenticare o rimuovere secondo l’ipocrita richiesta di pacificazione e di memoria condivisa, più volte chiesta a gran voce da parte di coloro che, mentre continuavano e continuano a negare la realtà o a cercare addebiti nei comportamenti degli uccisi, nella frazione di Lavezzola, con delibera comunale del 27 luglio 1982, intestarono al loro compagno partigiano Silvio Pasi una via che conduce alla piazzetta dove ha sede oggi il supermercato Coop.
E’ ancora più assurda questa decisione del comune di Conselice arrivata a vent’anni dalla morte, le cui motivazioni ho letto in un documento ufficiale della seduta di Consiglio che approvò l’intestazione, che facendo leva su aberranti falsità dipingeva Pasi come un eroe e ometteva volutamente di menzionare la condanna subita per omicidio e la revoca della medaglia al valor militare, se si pensa che, a suo tempo, dopo avergli reso tutti gli onori per non ammettere ufficialmente colpe e commistioni proprio il partito lo aveva abbandonato ed Elic, nel 1962 era morto solo, dimenticato e senza gloria.








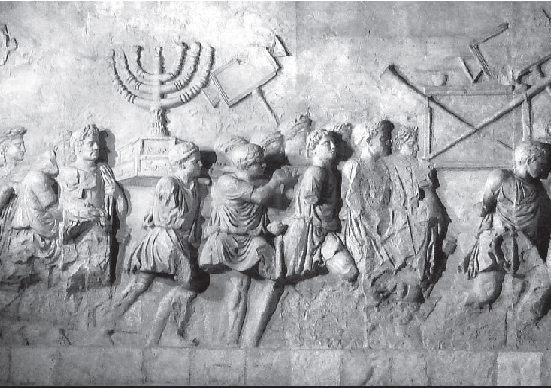
2 Comments