Un’immagine su tutte domina la preistoria dell’uomo: il «sacro palo»; al secondo posto si trova invece il tempo remoto in cui «il Cielo si separò dalla Terra». Le due cose sono chiaramente collegate, e poiché i racconti arcaici erano finalizzati alla trasmissione della memoria se ne deduce che il movente di una tale diffusione fu concreto.
Verosimilmente l’immagine del «palo» si riferisce all’asse terrestre, cioè allo djed dritto come un fuso attorno al quale la Terra ruotava allorché la Stella Polare costituiva il vero zenith, l’alternanza luce/buio era meno accentuata e il ciclo stagionale risultava sconosciuto agli abitanti dell’attuale Polo Nord, i quali vivevano in un clima da eterna primavera.
Proprio in quel contesto, spiega l’elaborata cosmologia zoroastriana del Bundahishn (Creazione), un’opera pahlavi della tarda antichità basata in gran parte su fonti avestiche, Ahura Mazda modellò il cielo, l’acqua, la terra, le piante e tutti gli animali, uomo incluso, nei quali soffiò infine il fuoco (dello Spirito) per dare loro un’anima.
Finché l’assalto di Ahreman scosse l’universo (un’allusione allo spostamento prospettico della galassia?) e i due equatori (celeste e terrestre) si disposero ad angolo l’uno con l’altro. La linea immaginaria che fino a quel momento aveva trafitto il globo dritta come un fuso s’inclinò, portandosi agli attuali 23° 27′ sul piano dell’eclittica, e allora si ebbe l’impressione che il Cielo e la Terra si fossero «separati» provocando un brusco cambiamento del clima e la comparsa delle stagioni.
Rievocando lo stesso evento la narrazione ellenica costruirà i miti di Fetonte e del titano Atlante, uno dei pilastri del cielo. Altre furono comunque le versioni dell’accaduto poiché doveva essere chiaro a tutti che le leggi della meccanica celeste rendevano l’universo un posto instabile, imprevedibile e dunque potenzialmente pericoloso, la qual cosa metteva in ridicolo certe dispute volte alla conquista di poteri effimeri destinati a sfumare in breve tempo davanti agli occhi dell’uomo.
C’era una via di fuga? Sì, secondo la dottrina escatologica zoroastriana. Fermo restando che gli eventi traumatici erano inevitabili, appariva altrettanto evidente che ad ogni Fine seguiva un Nuovo Inizio e perciò chiunque poteva prepararsi in anticipo. Mai la salvezza era stata negata a chi lavorando per la propria anima aveva mantenuto fede alla relazione magnetica (spirituale) esistente tra gli influssi cosmici, la parte sottile all’Asse e le vibrazioni universali che scendendo dalla volta celeste avvolgevano tutto ciò che sulla Terra era vivente.
Contemplando unicamente la ricostruzione meccanica dei processi l’istruzione moderna evita simili argomentazioni, limitandosi ad insegnare che l’inversione magnetica è un grande evento planetario legato alla circolazione convettiva nel nucleo fluido metallico della Terra. Stop. In concomitanza di questi eventi non risultano catastrofi documentate, tutt’al più una maggiore penetrazione del vento solare verso la superficie della Terra può danneggiare i sistemi satellitari e le reti di distribuzione dell’energia elettrica. Stop.
E gli impulsi elettrici (nervosi) che viaggiano dai nervi al cervello? L’essere umano non è forse una macchina elettromagnetica governata da un’unica tipologia di carica elettrica composta di varietà positive (protoni) e negative (elettroni)? Gli atomi che formano la materia di cui è fatto il corpo non creano legami indispensabili alla formazione di molecole, anche le più complesse?
Per lo scientismo dogmatico il concetto di natura siderea dell’uomo sarebbe puramente filosofico e perciò i movimenti cosmici, come le inversioni magnetiche, produrrebbero sui corpi fisici effetti irrilevanti. Affinché lo status quo sia mantenuto è necessario che il Demens rimanga all’oscuro delle funzioni svolte da ogni sua singola particella vibrante di energia. Quanto ancora durerà questa storia?
Axis mundi et universalis columna
La tendenza a minimizzare le conoscenze pregresse è chiaramente volta all’affermazione dell’idea illuminista di vivere nel «miglior mondo possibile». In teoria sappiamo che gli antenati primordiali non muovevano un dito senza pensare al senso cosmico delle proprie azioni ma in pratica preferiamo non pensarci, né sentirne parlare.
Ne consegue che uno dei tanti falsi miti con cui il Mondo Nuovo tra qualche anno si troverà a dover fare i conti riguarda certe pratiche spirituali un tempo diffuse sia nel mondo uraloaltaico sia in quello amerindo, dove i gruppi umani NON scolpivano e piantavano per terra i pali di legno allo scopo di ballarci attorno come tanti cretini.
Tali manifestazioni vanno innanzitutto inquadrate nella dimensione spazio-temporale di pertinenza, ovvero nel tribolato periodo in cui terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, incendi, alluvioni ed altri fenomeni estremi conclusero in modo violento la relativa stabilità mantenuta dalla lunga glaciazione di Würm (110.000-11.700 anni fa).
La fase del disgelo fu catastrofica. Mentre lo scioglimento dei ghiacci riassestava le placche crostali intorno ai Poli e il calore endogeno della Terra rimodellava gli assetti territoriali rimasti pietrificati per millenni, l’uomo si mise così all’opera per rimappare il mondo delineando la concezione arcaica di un cosmo composto da tre distinti livelli sovrapposti:
il primo sotterraneo, oscuro, misterioso e infido (infero); il secondo visibile grazie all’espressività della vita, nonché sede della «scala sciamanica» che consentiva i collegamenti tra una dimensione e l’altra (terrestre); il terzo esteso nel regno divino affinché l’uomo non dimenticasse la propria natura, intrecciasse storie, ricavasse pronostici e plasmasse l’Altro da sé (celeste).

Chiaramente i vari piani di questo orizzonte planetario, oscillante tra l’infero emisfero australe e il celeste emisfero boreale, necessitavano di un mediatore reale (l’uomo) e di vari mediatori simbolici che garantissero il rapporto di corrispondenza mantenendo la «dritta via» indispensabile a rendere la Terra un posto stabile. La scelta dei popoli di terra cadde inevitabilmente sull’Albero, onnipresente nelle immense foreste di larici e betulle dell’area a clima temperato che orlavano gli ultimi ghiacciai. Famoso fu il persiano Gaokerena, le cui radici affondavano nel centro dell’oceano del mondo (Vourukasha) e la cui chioma appariva circondata dalla cintura stellata delle costellazioni zodiacali che i popoli Ari si portarono dietro scendendo da Nord a Sud.
Svilupparono una funzione analoga l’asse portante del Rig-Veda, i tanti bastoni di dèi e demoni dell’India, l’ombrello della cosmologia birmana, la lancia del civilizzatore giapponese Izanagi, e così di palo in palo fino al tragico Albero al quale l’apostolo Giuda s’impiccò per pagare il prezzo del proprio tradimento.
Più la cultura di riferimento era raffinata, più l’«albero di trasmissione» risultava elaborato e ricco di riferimenti. Sul grande papiro di Harris gli Egizi dinastici scrissero: “O lunga colonna, che inizi nella parte superiore e nei cieli inferiori”. Si ritrova la «colonna portante della terra», la spina dorsale di Osiride, lo djed, anche nel Libro dei Morti.
Attualmente l’axis-mundi più popolare è il frassino Yggdrasill: “(…) un albero alto, bagnato di bianca brina: di là provengono le rugiade che cadono nelle valli, e sempre verde sta presso la fonte di Urdh” (Vǫluspá, La profezia della veggente, Edda poetica, str.19).
Pregno di un sincretismo prodigioso e intensamente poetico questo asse era capace di raccogliere in sé il senso di tutte le rappresentazioni legate al Fato e di esprimere l’esistenza di un’unità organica articolata in nove mondi, o dimensioni. Le sue proporzioni erano immense. I rami si stendevano su tutta la Terra e il fogliame copriva la volta del Cielo. Tre radici-mondo lo sostenevano: la prima si calava negli abissi più profondi, giù in basso, fino ad arrivare al Regno dei Morti, e un numero imprecisato di serpenti rosicchiava incessantemente i suoi filamenti; la seconda si spingeva nella terra glaciale dei Giganti della Brina (il «popolo delle doppie asce», cioè i cacciatori iperborei con l’ascia litica?), arrivando fino alla fonte magica del gigante Mimir, custode di tutta la sapienza e di tutta la conoscenza; la terza stava sotto il mondo affidato alla custodia degli esseri umani e lambiva la sacra fonte dove gli dèi tenevano consiglio ogni giorno.
Questo specchio d’acqua era abitato dai due cigni primordiali e su una delle sue sponde sorgeva la magnifica dimora delle tre fanciulle chiamate Nornir, le intagliatrici di rune che tessevano il destino degli uomini. Spettava a loro occuparsi del benessere dell’Albero attingendo quotidianamente alla sorgente l’acqua limacciosa che poi versavano sulle radici, spalmavano sul tronco e applicavano sui rami.
Troneggiava nella folta chioma del frassino un piccolo zoo. Un’aquila molto saggia portava in mezzo agli occhi un falco e quattro cervi saltavano tra i rami mordendo tutte le foglie acuminate. Il tronco era costantemente percorso da uno scoiattolo chiamato «dente che perfora», il quale portava su e giù gli insulti che si scambiavano tra loro l’Aquila che svolazzava in alto e il Serpente alloggiato tra le radici. L’attività di tutte queste creature dal nome antico e impronunciabile contribuiva a mantenere l’equilibrio del frassino, che senza le loro vibrazioni vitali (magnetiche) sarebbe seccato e marcito.
Pali di terra e di mare
Yggrasill è un’enciclopedia di simboli, significati, immagini sapienziali, suggestioni e reminiscenze storiche. Prima di relegarlo al fantasy il Demens farebbe bene a riconsiderarlo e magari pensare, perché no, a quanto sembrerà fantasioso tra cent’anni il linguaggio «scientifico» osannato dal suo mondo.
Non sempre la funzione mediatrice era affidata all’Albero. Talvolta al suo posto c’era un ponte, come nel caso del Chinvat della tradizione avestica che collegava il Daitik (la montagna sacra dell’Airyanam Vaêjah) all’Eden posto al «centro della terra», cioè in Eurasia.
Mansioni analoghe furono affidate al ponte-arcobaleno Bifröst, al monte Su-Meru degli indù, alla talmudica collina di Sion, alla colonna leggendaria sulla quale l’imperatore cinese tentò invano di salire da vivo, all’Al Sarāt della penisola araba e via dicendo.
Per ovvie ragioni l’immaginario dei popoli di terra costantemente immersi nel fogliame non poteva essere uguale a quello dei popoli di mare, la cui attenzione si concentrò infatti sul «palo della nave», anch’esso ligneo e simbolicamente accessibile all’anima per salire e scendere, percorrere l’intera gerarchia, attraversare i tre mondi.
Meno chiassoso e più solitario dell’esuberante parente verde, questo pilone alto e liscio piantato in mezzo al ponte dello scafo dei velieri era per i naviganti un compagno discreto e silenzioso. Bastava a se stesso, non ospitava nessuna creatura sulla sua superficie né manifestava alcuna volontà di dirigere attorno a sé le evoluzioni immani delle stelle, del sole e dei pianeti che ruotavano lungo la fascia zodiacale.
In un certo qual modo la forza dell’albero maestro, come quella dell’albero di mezzana e dell’albero di trinchetto, appariva meccanica e priva di volontà, cioè sottoposta alla legge superiore a cui erano soggetti gli stessi dèi. I marinai lo rispettavano come una specie di memento mori messo lì apposta per ricordare che l’Universo era destinato ad essere creato e annientato nei limiti di un tempo cosmico prestabilito.
Nel continuo farsi nessuno poteva intervenire né interferire, il che dava parecchio da pensare. Forse per questo motivo fino a pochi decenni fa non era infrequente trovare riflessioni profonde e opinioni particolarmente originali nella gente di mare.
Nel mondo-Demens ciò non può accadere. Ormai a bordo delle navi tutto è computerizzato, previsto, programmato, scontato. Terribilmente noioso. Ma per millenni una solitudine dinamica ha seguito come un’ombra i lunghi viaggi del marinaio, fornendogli infinite opportunità per meditare e scoprire cose nuove.
Le occasioni per pensare non mancavano durante le interminabili giornate di bonaccia, oppure nei momenti di pericolo, quando il cielo cominciava a dare segnali preoccupanti e le nuvole grigio-piombo andavano a nascondersi dietro le montagne, lasciando presagire che l’abissale luccichio del mare si sarebbe presto trasformato in mercurio fluttuante.
In simili frangenti era inevitabile passare in rassegna la propria vita e considerare il senso profondo delle cose, paragonando se stessi e la precarietà dell’esistenza all’albero della nave, sradicato anch’esso dalla sua terra e rivolto come una preghiera verso il cielo. Idealmente quel frutto dell’ingegno umano rappresentava l’opus, mentre il risultato era il suo oro. L’oro della conoscenza.
Quale Età della Pietra?
A livello immaginifico l’Albero vestito e/o nudo fu per l’antenato preistorico l’emblema della vita che trionfando sull’inclemenza degli elementi e sui rigori del clima si muoveva lungo i tre distinti livelli sovrapposti dell’essere, ma anche attraverso i cinque livelli elementali: la Terra assorbiva dal cosmo energia che trasmetteva alle radici; l’Acqua era l’agente chimico che produceva il fluido della linfa; l’Aria filtrava la luce e tesseva le forme ideali (come osservato

da Goethe nella sua concezione della «forma archetipica»); il Fuoco celeste della folgore lo scuoteva con la sua forza tonante caricando l’Etere di energia.
Tale moto proseguiva nel firmamento, dove il Fuoco diventava il cerchio che passando per i Gemelli si estendeva nell’universo dopo avere attraversato i poli celesti e i punti equinoziali. Difatti il segno zodiacale dei Gemelli, oggi rappresentato da due persone, veniva disegnato anticamente con due righe, due paletti, due bastoncini, cioè i primi strumenti utilizzati dagli esseri umani per produrre il fuoco.
Nello spazio domestico l’essere umano, che è una spugna intellettuale sempre pronta ad assorbire le influenze esterne per rilasciare immagini, proiettò il turbinio di rette lignee e cerchi infuocati di provenienza celeste sull’«occhio solare» che un tempo si apriva in cima alla yurta asiatica, o al tipì, la tipica tenda conica dei villaggi indiani.
Entrambi i ripari erano attraversati da un palo assiale anche quando questo non c’era materialmente e perciò gli occhi non lo vedevano, pur tuttavia immaginandolo. Identiche funzioni svolgeva in mare la «coffa» presente su tutti gli alberi dei velieri e utilizzata dai marinai sia per lavorare alle vele sia come posto di osservazione per le vedette.
Com’è ovvio che sia non si conosce la data di nascita di queste elucubrazioni, ma è lecito supporre che l’uomo abbia caricato di significati il palo ligneo verso la fine del Pleistocene, l’epoca abitata da un antenato più concreto di quello boreale e meno ispirato di quello paleolitico. Agli occhi di costui l’Albero deve essere apparso un elemento perfetto nella sua verticalità, il paradigma ideale della vita che crescendo si sviluppava su se stessa, spingendosi fino al cielo.
Risale allo stesso periodo l’idolo di Šigir, ritrovato nell’omonima torbiera della Siberia occidentale, datato attorno all’11.500 a.C. e prodotto da una cultura inequivocabilmente sciamanica [immagine 1]. Nella zona si trovano anche i resti del cosiddetto «Tempio del Tempo» di Sunduki, una specie di santuario astrologico che comprende un luogo di culto e un antico osservatorio astronomico.
Più in generale si può dire che l’«asse» terrestre e/o celeste sia stato presso i popoli dislocati nelle rigogliose foreste della fascia sub-artica il termometro con cui l’uomo ha misurato l’intensità del rapporto tra la sua specie e il Mondo Verde, ovvero il suo grado di spiritualità.
Cosa che rende doppiamente incomprensibili le ragioni che hanno portato gli accademici ottocenteschi a definire «Età della Pietra» il tempo arcaico che fu a tutti gli effetti un’«Età del Legno», essendo il «palo» ligneo l’emblema di un tempo rivolto al recupero delle radici e attento alle idee di vertice.
Il rigore orientale del Wu Ling cinese (五令), cioè l’ordine dei cinque elementi, pose invece il Legno al primo posto del ciclo della generazione madre-figlio: il Legno (primavera) alimentava il Fuoco (l’estate), che provocava la cenere nutrendo la Terra (fine estate) dalla quale veniva estratto il Metallo (autunno) che trasportava l’Acqua (l’inverno) e nutriva il Legno, dando vita ad un nuovo ciclo.
La profanazione dell’Albero
Diffusa nel cerchio comprendente tanto l’area siberiana quanto quella lappone e nordamericana [immagine 2], la simbologia legata al «sacro palo» di origine sciamanica ebbe meno fortuna nelle regioni centrali e meridionali dell’Eurasia, dove al posto delle grandi foreste c’erano le grandi pianure, oppure i grandi deserti.
In uscita dall’area continentale di nord-est i Sumeri esportarono in Mesopotamia un sosia di Yggdrasill, il mitico Khuluppu. Tracce dell’Albero sacro a Inanna/Ishtar si trovano nel poema conosciuto con il titolo di Gilgamesh, Enkidu e gli inferi, dove si apprende che “tutto solo, un albero tutto solo” dimorava sulla riva del puro Eufrate (Giovanni Pettinato, La Saga di Gilgamesh, 1992).
Come il gemello nordico anche Khuluppu era abitato da strane creature: un serpente restio a ogni incantesimo se ne stava attorcigliato alle radici; un essere chiamato Ki-sikil-lil-la-ke, forse un gufo, risiedeva nel tronco; l’uccello-tempesta Anzud aveva il nido nella chioma.
Finché lo travolse una specie di Ragnarǫk in salsa mediorientale, forse una tempesta eccezionale (magnetica?). L’intervento di una mano santa di genere femminile ne evitò tuttavia la distruzione totale: “Una donna, rispettosa della parola di An, vi passò accanto / rispettosa della parola di Enlil, vi passò accanto / essa prese l’albero nella sua mano e lo portò a Uruk, / nel santo giardino di Inanna essa lo portò (…)” (op. cit., pag. 330).
Fa specie che nella tradizione euroasiatica classica l’Albero del Mondo venga salvato da una donna, mentre in quella biblica sia una donna a profanarlo. Due pesi, due misure, due mentalità profondamente diverse. Più arcaica e radicata la prima narrazione si estese nel continente opposto, dove un mito cosmogonico dei Pellerossa raccontava l’opera decisiva della bella fanciulla che lanciò una freccia nel gorgo delle acque che conduceva al Regno dei Morti (la Via Lattea?) al fine di scongiurare lo spegnimento del fuoco (dello Spirito).
Ne consegue che sulle spalle della povera Eva è stato caricato un fardello di colpe non sue, il quale ha fatto il paio con la damnatio memoriae toccata a quel povero diavolo del Serpente Antico.
Un abisso di senso separa inoltre l’Albero della Conoscenza orientale di chiara matrice sciamanica dall’Albero del Bene e del Male del racconto veterotestamentario, il quale attraverso un «mistero pratico-politico» neanche troppo difficile da smascherare ha introdotto nella società occidentale il pernicioso concetto di «giudizio», da cui dipende la maggior parte delle azioni umane, le quali contribuiscono a formare una determinata visione del mondo, quella sostanzialmente gnostica del Demens.
Passare al bosco
Indubbiamente le metropoli contemporanee non si prestano alle suggestioni del passato. Nei centri urbani il verde scarseggia, le cose brutte spuntano da ogni pertugio come la gramigna e l’umanità sembra impazzita. Scriveva nel 1995 il filosofo Jean Baudrillard: “L’Occidente, [infatti] si riflette in uno specchio che esso stesso ha costruito, ossia nello schermo narcisistico del virtuale, dell’economia globale e della sub-cultura mediatica, venendone letteralmente risucchiato – non sa più qual è il riflesso e quale l’originale, il reale” (tratto da Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, 1996).
Tutto assumerebbe un senso logico se nell’individuo l’idiozia fosse stata abbinata all’intelligenza al fine d’impedire alla specie umana di diventare divina; per capirlo, però, c’è un solo modo: passare al bosco, ovvero accordare alle proprie riflessioni un accento di anacronismo, assaporando il piacere di «tornare a casa», all’Origine.
Caso vuole che proprio nelle regioni siberiane da dove è partita la grande avventura del Sapiens si respiri ancora un’aria pulita. Il clima si è inasprito rispetto a un tempo, ma al visitatore che si spinga fin lassù è concesso il privilegio d’immergersi nel paesaggio primordiale, eterno, immortale, in mezzo a giganti vegetali alti quaranta metri.
Il pino silvestre, l’abies, e il cedro siberiano non temono il confronto con il frassino Yggdrasil e continuano ad allungare i loro rami verso il cielo per trarne l’energia necessaria alla Terra e ai terrestri. Da tempo immemorabile queste creature arboree sono il simbolo della «quiete verticale», puntano in alto mentre intorno scorre lento e discreto qualche piccolo fiume che taglia in due un villaggio, lambendo le case fatte di legno, con l’orto per l’autosostentamento.
Le persone da quelle parti parlano poco e a voce bassa, per non disturbare. I gesti sono misurati, ovattati, come la neve sul paesaggio. C’è poco da bleffare in un ambiente eterno dove ognuno è solo con se stesso mentre i polmoni si gonfiano di ossigeno, gli occhi si riempiono di spazio, le orecchie piano piano ricominciano a sentire, nel silenzio, gli ultrasuoni del mistero cosmico capace di asfaltare ogni altra voce.
Mentre l’energia vegetale esplode in quelle lande inabitate, contagiando ogni specie animale, il Demens pensa di farle esplodere in senso stretto. Attualmente sono presenti negli arsenali mondiali circa quindicimila ordigni nucleari, quando ne basterebbero cinquanta per annientare il mondo. Quindi, a cosa servono i restanti quattordicimilanovecentocinquanta? Non bastano le catastrofi naturali che ciclicamente (s)travolgono la vita terrestre a complicarne l’esistenza?
Mai come oggi si è sentito il bisogno di pace e di silenzio; e qui non c’entra la Siberia perché basta un click per spegnere la «tecnomagia» esercitata dai nuovi ladri di anime. Succederà, l’aumento vertiginoso delle aspettative soggettive insoddisfatte lascia ben sperare.
Uno dopo l’altro gli scheletri stanno uscendo dagli armadi, lo spettro della povertà si aggira nelle stanze del benessere e la sfiducia nelle classi dirigenti (le peggiori di sempre) ha toccato il massimo storico. Già s’intravede la fine dell’attuale sistema, a breve non capiterà un’occasione migliore per ripristinare la superiorità della propria natura cosmica su un presente arrogante e presuntuoso, cioè totalmente privo di una colonna portante che lo sostenga.



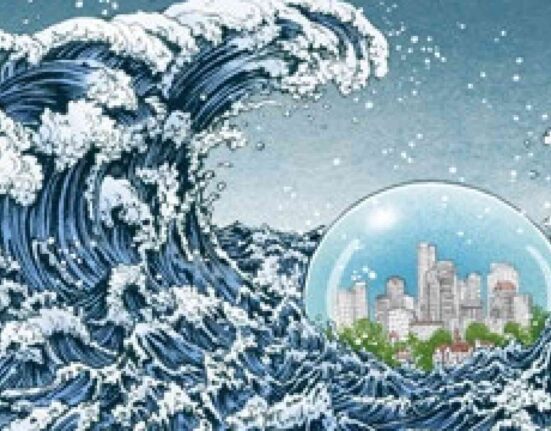
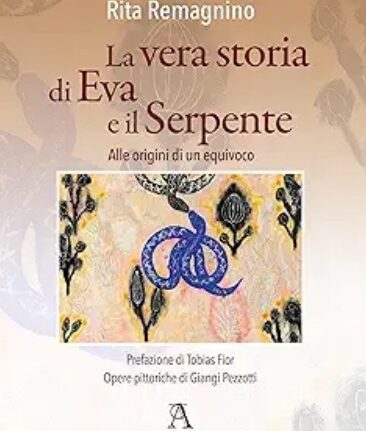


2 Comments