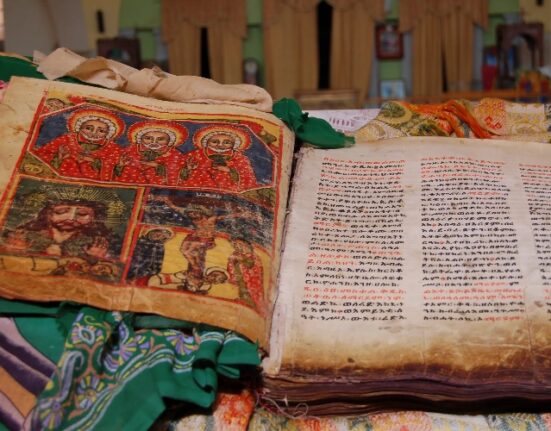L’India è la patria di due grandi famiglie linguistiche: indoariana (parlata da circa il 74% della popolazione) e dravidica (parlata da circa il 26%, come il tamil). Altre lingue parlate appartengono alle famiglie austroasiatica e tibeto-birmana (come le lingue ao naga).
Le lingue austroasiatiche fanno parte di gruppi tra di loro affini ma probabilmente non imparentati geneticamente (secondo alcuni), cioè non deriverebbero da un progenitore comune. Alcuni le intendono affini con quelle sinotibetane (Campbell), altri con le lingue austronesiane.
I gruppi delle lingue austroasiatiche sono questi:
-
- Lingue mon-khmer: parlate in Vietnam, Laos, Malaysia, Cambogia e sporadicamente anche in Birmania e in India (è il caso della lingua khasi parlata in Assam e in Bangladesh). Haudricourt ha difeso il carattere mon-khmer del vietnamita;
- Nicobarese: parlato nelle isole Nicobare, amministrativamente soggette all’India;
- Sottogruppo palaungic: formato da un nutrito gruppo di lingue tra Thailandia, Laos, Birmania, la provincia cinese dello Yunnan;
- Lingue munda (o kol): parlate soprattutto negli stati indiani del Bihar, Orissa e Madhya Pradesh. Originariamente erano distribuite massicciamente sul subcontinente indiano, poi vennero molto ridimensionate dalle invasioni arie. Si tratta di lingue agglutinanti (caratterizzate da lunghe sequenze di affissi, specialmente nel verbo). Sono fortemente influenzate dalle altre lingue indiane, indoeuropee e dravidiche. Nelle lingue munda il nome prevede una distinzione essenziale tra animato e inanimato e, normalmente, le relazioni di caso sono segnalate sia dall’ordine delle parole sia da posposizioni e da affissi pronominali.
Dapprima confuse con le lingue dravidiche, le lingue munda furono riconosciute come famiglia separata dal linguista Max Müller nel 1857. Alcune lingue minori del gruppo furono scoperte solo negli anni Sessanta del XX secolo: si tratta del parenaga e del bonda, diffuse nella parte meridionale del distretto di Koraput, nello stato indiano dell’Orissa.
Le lingue munda sono parlate da popoli tribali e non hanno tradizione scritta. I parlanti sono circa nove milioni. Oggi la più diffusa è il santali (sei milioni di locutori).
Le lingue munda sono una ventina, nello specifico:
-
- Lingue munda settentrionali (kherwarian): gruppo kherwari (agariya, bijori, korazu), gruppo mundari (mundari, asuri, koda, ho, birhor, bhumij), gruppo antali (santali, mahali, turi)
- Lingue munda occidentali: lingue korku
- Lingue munda centrali (kharia-juang): kharia, juang
- Lingue munda meridionali (koraput munda): gruppo remo (gata’, bondo, gutob), gruppo savara (perenga, sora, juray, lodhi).
La relazione genetica dei membri indiani e del Sud-est asiatico della famiglia linguistica austroasiatica è stata ipotizzata da alcuni autori (Schmidt 1906, Pinnow 1959), ma i rispettivi rami sono così opposti dal punto di vista strutturale che George Grierson (1904) osservò che sembra come il linguaggio originario sia stato adottato da etnie con leggi di pensiero opposte. Per questo, come abbiamo detto, altri non danno per valida la teoria della parentela tra i rami delle lingue austroasiatiche e nemmeno ravvisano un progenitore comune delle sole lingue munda.
In ogni modo è stata supposta una classificazione delle lingue munda sulla base dell’esito del fonema *q del proto-munda:
-
- Gruppo kherwari: h;
- Gruppo occidentale e centrale: k;
- Gruppo meridionale: perdita del fonema *q.
Nelle lingue austroasiatiche ci sono tre tendenze:
-
- Un gruppo orientale: il determinante (come l’aggettivo o il genitivo) segue il determinando (come il sostantivo o il nominativo);
- Il nicobarese: in cui questo fenomeno si osserva solo parzialmente; infatti per quanto riguarda l’aggettivo, senza affissi, esso precede il sostantivo, per esempio in una lingua appartenente al nicobarese abbiamo questa forma: ãã yuaŋ lepaa keliŋ, “i due buoni stranieri”, letteralmente “due persone buoni stranieri”;
- Lingue munda: normalmente il determinante precede il determinando, ma ci sono eccezioni in certi casi, per esempio in sora il genitivo spesso segue il nominativo, abbiamo e-jeelu-booŋ-en, “carne di bufalo”, letteralmente “carne di bufalo la”.
Pertanto, la linguistica storica ha ricostruito questo quadro:
-
- In un primo periodo nelle lingue austroasiatiche era predominante l’ordine determinante-determinando;
- In seguito in tutte le lingue austroasiatiche il determinante veniva posto dopo il determinando, ma non esclusivamente;
- Le lingue munda ritornarono a far precedere il determinante al determinando probabilmente per influenza delle lingue dravidiche e arie.
Si fanno anche queste altre osservazioni. Il proto-austroasiatico aveva un accento crescente e un ordine delle parole Head-First, come il mon-khmer. Le lingue munda hanno invertito la struttura con accento cadente e ordine Head-Last, ma hanno la vecchia struttura nelle parole complesse.
Schematicamente ecco le differenze prosodiche più importanti:
-
- Mom-Khmer: Head-First (Verbo-Oggetto); Frasi (in aumento); Parole (in aumento: giambiche/monosillabiche); Affissazione (prefissi, infissi o parole isolate); Isoaccentuali;
- Lingue Munda: Head-Last (Oggetto-Verbo); Frasi (cadenti); Parole (in caduta: trocaiche); Affissazione (prefissi, infissi, suffissi); Isosillabiche, Isomoraiche.
Recenti studi mostrano come le caratteristiche prosodiche di una lingua difficilmente passano ad un’altra per imitazione sincronica: difficilmente un parlante fa proprie strutture prosodiche di una seconda lingua non materna. Pertanto, le inevitabili somiglianze prosodiche delle lingue munda con quelle attigue dravidiche e indoeuropee, si spiegano solo in chiave diacronica: nel contatto reiterato nella storia tra questi tre gruppi.
Bisogna anche rilevare come le lingue austroasiatiche si dividono sostanzialmente in due gruppi per queste caratteristiche:
-
- Lingue khmer e nicobarese: nelle quali prevale la paratassi e l’analiticità (lingue analitiche);
- Lingue munda: prevale la ipotassi e la sinteticità (lingue sintetiche, cioè con declinazione e coniugazione verbale).
Però nel nicobarese abbiamo più che altro una posizione intermedia. In esso le proposizioni subordinate participiali, così frequenti nelle lingue munda, sono praticamente assenti; quindi, il nicobarese si comporta come le lingue orientali. Tuttavia, in esso si osservano casi di declinazione di origine antica. Per esempio, in nicobarese i casi del pronome sono: nominativo, interrogativo, obliquo. La prima persona singolare è cin (nominativo), öic (interrogativo), cu (obliquo).
Nelle varie tradizioni orali composte nelle lingue munda le canzoni e le poesie sono molto sentite e quindi molto importanti, sono spesso accompagnate dalla musica e dalla danza.
Nelle canzoni e nelle poesie in mundari si utilizza una metrica quantitativa. La unità di tempo più piccola è un “battito” composto per lo più di una (la chiameremo breve) o due (lunga) sillabe. Esempi di battiti di tre sillabe sono rari, e la tendenza è di ridurli a due sillabe. Ad esempio, bakana “descrivere” può essere realizzato come bakna, e jatara “fiera di campagna” come jatra.
I tipi di metro variano da tipo di canzone o poesia. I più importanti generi di canzoni sono questi:
-
- Jadur (cantate prima e durante la “festa dei fiori” che si svolge tra febbraio e aprile): caratterizzate dal metro 7-7, 7-7;
- Mage (prima e durante la “festa del raccolto”): 7-7, 7-7; ma anche 4-7, 4-7; 4-5, 4-5;
- Japi (al ritorno di una battuta di caccia): 5-5, 5-5;
- Aṛandi (durante un matrimonio): 4-4, 4-4.
All’interno di una strofa i versi ripetuti sono il primo o il terzo. Il primo verso viene ripetuto in due posizioni: nel secondo o nel terzo. La possibilità di ripetizione del terzo verso è solo una, cioè nel quarto verso. Il secondo verso non si ripete mai all’interno della stessa strofa. Facciamo questo esempio:
buru mandukam hale
buru mandukam ho
bera sarjom hale
bera sarjo
aŋ nam reoge? Ci giti?nam gonoe?
cimin cimin(e)laŋ hiatiŋa
aŋnam reŋge? Ci giti?nam gonoe?
cimin cimin(e)laŋ cakatiŋa
“Il mandukam (fiore) sulla collina, amico,
il mandukam sulla collina.
Il sarjom (frutto) nella valle, amico,
il sarjom nella valle.
Alzarsi affamati o morire nel sonno
per molto tempo dovremmo preoccuparcene?
Alzarsi affamati o morire nel sonno
per quanto tempo dovremmo pensarci?”.
La lingua ho è un idioma non classificato appartenente al gruppo mundari. In questa lingua la parola “ho” vuol dire “uomo”. Negli altri idiomi munda, Horo è il termine che si riferisce al genere umano. Grierson ha chiamato “ho kaji” la lingua degli Ho (dove il termine kaji vuol dire parlata, idioma). Secondo il censimento del 1971, il totale dei parlanti la lingua ho è di 7, 51, 000.
Secondo una ricostruzione, la comunità di lingua HO non ha mai avuto un vero e proprio modello letterario univoco prima di Lako Bodra (XX secolo), il quale in età moderna ha dato avvio a una tradizione presa come modello. Ma Lako Bodra ha ipotizzato che prima di lui ci sia stata una tradizione letteraria ho, messa per iscritto su monumenti di pietra. Secondo Lako Bodra, queste iscrizioni vennero ideate molto tempo fa da un personaggio di una tribù ho (occultista tantrico) chiamato Turi, probabilmente in un alfabeto brahmi. Invece l’alfabeto ideato da Lako Bodra si chiama Warang Kshiti, dove il primo termine vuol dire “potere” e il secondo “simbolo”.
Nello stato indiano di Jharkhand, la popolazione Ho è concentrata principalmente nel distretto Paschimi Singhbhum, seguito da Purbi Singhbhum. Sono presenti anche nei quartieri Bokaro, Ranchi e Dhanbad. I luoghi in cui gli Ho si trovano in abbondanza sono i seguenti: Chakradharpur, Noamundi, Jhinkpani, Kumardungi, Chaibasa, Majhgaon, Tant naga, Manjhari, Jagnanahtpur. Nello stato del Bihar, i parlanti. Ho si trovano scarsamente a Katihar, Paschim Champran, distretti di Samastipur e Patna.
La lingua ho è usata prevalentemente tra i membri della famiglia nel dominio domestico. Viene utilizzata anche con i loro parenti. Nei villaggi in cui gli Ho vivono in numero elevato, la lingua ho è utilizzata anche nel mercato. La lingua ho viene utilizzata con amici e parenti durante occasioni come lo svolgimento di rituali, cerimonie e feste. La divinità suprema dei popoli Ho è Sing Bonga. La lingua ho ha una ricca tradizione orale. Contiene canzoni e racconti popolari.
I nomi al singolare non sono marcati, il duale ha la marca –kiM, il plurale ha la marca –ko. “Cane” è se:ta; “due cani” è se:takiM, “cani” è se:tako. Per dire “ci sono tre cani”: enko apiya se:tako (dove enko è “ci sono”, apiya è “tre”).
Il nome maschile esce generalmente con –a oppure –e. “Padre” è ba:ba. Il nome femminile esce con –i oppure a volte –a. “Ragazza” è kui. La lingua ho presenta otto casi:
-
- Nominativo: non marcato
- Accusativo: esce in –i
- Strumentale: -te
- Dativo: -tee
- Locativo: -ree
- Ablativo: -ete
- Genitivo: -a/-ya
- Vocativo: per esprimerlo sono adoperate le interiezioni ei, ah, sh. Per esempio, ei! Hujume, “oh! vieni qui”.
La forma base del verbo si trasforma in verbo finito con degli affissi. Seno è la base del verbo e significa “andare”; senotana “io vado” (presente), seno a “io andrò” (futuro).
Quando un verbo intransitivo prende l’oggetto, -ui la base intransitiva viene cambiata in -a:, la base transitiva. Per esempio, “il cane abbaia” è se:ta bu’uitana, invece “il cane abbaia al gatto” è se:ta bilai’e bu’a:tana.
I tempi sono:
-
- Presente: -tana
- Passato: -yana/-ana
- Futuro: -a.
I modi:
-
- Imperativo: -me. Nenta hujume, “vieni qui” (dove nenta è “qui”)
- Infinito: -te/-lagiDte
- Gerundio: -tan
- Participio: -kan.
Abbiamo poi forme speciali del verbo:
-
- Causativo: –icui
- Verbi ausiliari: tana, kana
- Verbi servili: posso (-daiya), potrei (dayaDa)
- Passivo: si forma con etee (“da”) + –o aggiunto al verbo. Per esempio, “noi picchiamo il ragazzo” ho:n laM tami:tana (dove ho:n è “ragazzo”, laM è “noi”, tami:tana è il verbo attivo), ma “il ragazzo viene picchiato da noi” è ho:n alaM etee tamotana (dove alaM è “noi”, etee è “da”, tamotana è la forma passiva).
Un passato iterativo (stavo mangiando, stavo dormendo) è espresso così: l’affisso –tana del tempo presente si trasforma in –tan, mentre si aggiunge –Taikena. Per esempio, bazar teM senotanTaikena, “stavo andando al mercato” (dove il presente seno-tana, “vado”, si trasforma in senotanTaikena, “stavo andando”).
Nella lingua ho l’ordine delle parole della frase principale è: Soggetto-Oggetto-Verbo. La coordinazione tra proposizioni è espressa da onDo, “e”, mendo, “ma”. La proposizione interrogativa si forma aggiungendo cikanreya, “perché?”, okon, “dove?”, e altre, in posizione iniziale o dopo il soggetto.
Ci sono molte subordinate. Quando una frase subordinata modifica una frase nominale, si chiama relativa. I pronomi relativi sono questi:
-
- Okoiči: il quale (who)
- Okoike či: chi
- Okoikoa: di chi
- Okoinači: il quale (which)
- Okonreci: nel quale.
Per esempio, Jargi mido (un) ho (uomo) okoiči (che) haku (pesce) sa?p (prendere) sena (va) suku-a-e (come un poliziotto). Cioè: Jargi un uomo che pesca come un poliziotto. Si tratta di una frase nominale, tipica della lingua ho, pertanto andrebbe tradotto in italiano come: Jargi (è) un uomo che acchiappa il pesce come un poliziotto.
L’idioma ho, come le altre lingue munda settentrionali, presenta la cosiddetta armonia vocalica. Per armonia vocalica si intende quel fenomeno per il quale le vocali si trasformano in quelle con cui hanno delle caratteristiche in comune. Per esempio:
-
- /e/ = /i/. Ne + kin = nikin, “questi due”;
- /a/ = /e/. Hiju + yana = hiju + yene, “vieni”.
Bibliografia
- G. D. S. Anderson, The Munda Languages, Londra 2014;
- E. Banfi, N. Grandi (a cura di), Le lingue extraeuropee: Asia e Africa, Roma 2022;
- J. L. Bybee et alii, Prosody and segmental effect: Some paths of evolution for word stress, in Studies in Language 22 (2) (1998), pp. 267-314;
- E. Delais-Roussarie et alii, Prosody and Language in Contact: L2 Acquisition, Attrition and Languages in Multilingual Situations, Berlino 2015;
- Donegan, Rhythm and Vocalic Drift in Munda and Mon-Khmer, in Linguistics of the Tibeto-Burman Area, Vol. 61.1 (1993), pp. 1-43;
- M. Emenau, Linguistic prehistory of India, in American Philosophical Society 98 (1954), pp. 282-292;
- B. Hoffmann, Mundari Grammar with Exercises, New Delhi 2001;
- K. Khanrah, Lako Bodra – A Study in the Context of Social, Cultural and Literary Emancipation of the Ho Community, in Indian Literature, Vol. 67, No. 5 (337) (September-October 2023), pp. 163-174;
- D. Munda, Some Formal Features of Traditional Mundari Poetry, in Oceanic Linguistics Special Publications, No. 13, Austroasiatic Studies Part II (1976), pp. 843-871;
- Perumal Samy, Linguistic Description of Ho Language Spoken in Jharkhand, in Linguistic Survey of India: Jharkhand (2021), pp. 339-431;
- H.-J. Pinnow, The Position of the Munda Languages within the Austroasiatic Language Family, in H. L. Shorto (a cura di), Linguistic Comparison in South East Asia and the Pacific, Londra 1963, pp. 140-152;
- N. Ramswami, Ho Grammar, Mysore 2007;
- H. Ring, G. D.S. Anderson, On prosodic structures in Austroasiatic diachrony: ‘Rhythmic Holism’ revisited in light of preliminary acoustic studies, in H. Ring, F. Rau (a cura di), Papers from the Seventh International Conference on Austroasiatic Linguistics, Honolulu 2018, pp. 1-35;
- R. Schiering, H. van der Hulst, Word Accent System in the languages of Asia, in H. van der Hulst, R. Goedmans, E. van Zanten (a cura di), A survey of word accentual system in the language of the world, Berlino 2010, pp. 509-613;
- D. Sharma, Munda: Sub-Stratum of Tibeto-Himalayan Languages, Delhi 2003;
- K. Sinha, Mundari Grammar, Mysore 1975.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022. Ha dato alle stampe con varie Case Editrici 54 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web.