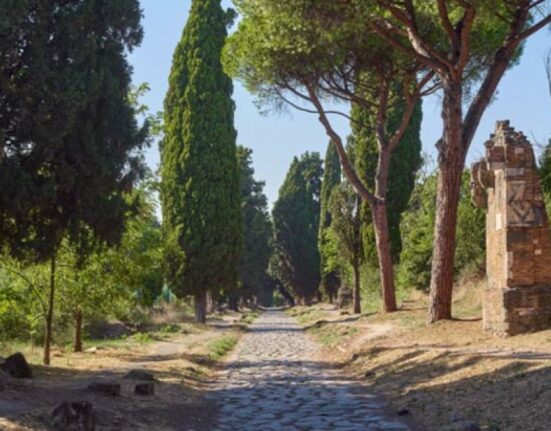Siamo ancora impegnati con marzo 2024, precisamente la terza decade, e la mia tabella di marcia mi dice che questo articolo non potrà uscire sulle pagine di “Ereticamente” prima di maggio. La “forbice” tra gli eventi di cui vi parlo e il momento della comparsa degli articoli sulla nostra testata, sta tornando ad allargarsi. D’altra parte, questa è una conseguenza necessaria e ovvia del fatto che sono tornato ad alternare L’eredità degli antenati con articoli di altro tipo. Vedrò di fare in modo che non diventi di nuovo eccessiva, ma, come vi ho già detto, non esistono soluzioni ideali e perfette.
Partiamo ancora una volta da “Ancient Origins” che continua a dimostrarsi il sito più ricco di informazioni sulla preistoria e la nostra storia remota.
Un articolo di Sahir del 21 marzo ci porta in Inghilterra, nella località di Must Farm. Quest’ultima è stata chiamata dagli archeologi inglesi la Pompei della Gran Bretagna, anche se a me come Pompei sembra un po’ scarsa. Si tratta di un villaggio palafitticolo della tarda Età del Bronzo, 2.850 anni fa, che è stato incendiato, forse da dei razziatori, poi allagato e sommerso dal fango, il che però ha permesso un ottimo stato di conservazione dei reperti carbonizzati. Gli archeologi dell’Università di Cambridge che l’hanno recentemente studiata, sono rimasti sorpresi dalla quantità dei manufatti rinvenuti.
Ricordiamo che l’età classica è stata un’epoca fondamentale per la civiltà umana non solo per le sue vicende di imperi e battaglie o per la ricca mitologia che ci ha tramandato, ma per le sue conquiste nel campo del pensiero, e “Ancient Origins” ce ne ricorda due figure chiave con due articoli di Aleksa Vučković, uno il 23 marzo sul matematico greco Euclide, il “padre della geometria, e uno il 24 sullo storico romano Tacito.
Se noi cerchiamo di visualizzare il medioevo, è probabile che una delle prime immagini che ci si presenteranno alla mente, è quella di cavalieri con armature dalle elaborate sopravvesti che, a cavallo di possenti destrieri si sfidano in torneo. Un cavallo da giostra di buona qualità, forte e robusto, era per i cavalieri un elemento essenziale in questo genere di scontri. Un articolo di Nathan Falde del 25 ci racconta di un’indagine che è stata compiuta sui resti di 70 cavalli di età medioevale rinvenuti in un cimitero per questi animali nei pressi dell’abbazia inglese di Westminster, la loro provenienza è stata determinata mediante l’analisi degli atomi di stronzio e di isotopi di ossigeno presenti nello smalto dentario. Si è verificato che la maggior parte di essi proveniva dall’Europa continentale, soprattutto dalla Svizzera e dall’Italia settentrionale. Evidentemente, i cavalieri inglesi non risparmiavano gli sforzi pur di procurarsi un buon cavallo.
Non possiamo non tornare a parlare di qualcosa di romano. In particolare, quello che oggi è chiamato l’elmo Hallaton, di cui ci parla Sahir in un articolo del 27. Ritrovato in un campo del Leicestershire assieme ad altri reperti di età romana nel 2001, sottoposto a un attento lavoro di pulitura, restauro e ricostruzione, quello che inizialmente era considerato “un secchio arrugginito” si è rivelato essere uno splendido elmo da ufficiale romano di cavalleria.
Abbiamo visto che oltre che all’archeologia, “Ancient Origins” dedica spazio alla mitologia, e sempre il 27 marzo abbiamo un articolo di Martini Fisher sul mito di Arianna, un mito con una morale. La figlia di Minosse abbandonata da Teseo che le preferì la sorella Fedra, nell’isola di Nasso (da qui l’espressione “piantare in asso”), fu qui trovata e fatta sua sposa da Dioniso. La morale è che nella vita non bisogna mai disperare, persa un’occasione, se ne può presentare una migliore.
Il 28 ci spostiamo in Bretagna. Qui, su incarico della città di Vannes, gli archeologi dell’INRAP hanno riportato alla luce i resti del perduto castello dell’Hermine, costruito dal duca di Bretagna Giovanni IV a partire dal 1380. Ridare vita a un autentico castello medioevale, spiega l’articolo non firmato, il sogno di ogni appassionato di archeologia.
Sempre il 28 un articolo di Robbie Mitchell ci parla di qualcosa di cui vi ho già parlato e su cui ora non mi soffermo troppo, la mostra dei mobili lignei, carbonizzati ma riconoscibili rinvenuti a Ercolano.
Il 30 marzo Joe Green ci dà una notizia singolare, quella del ritrovamento a Hrubieszów nella Polonia orientale di un’ascia di rame risalente a un periodo tra il IV e il III millennio avanti Cristo, il che ne fa il più antico attrezzo metallico mai rinvenuto in Polonia, ma non finisce qui, perché l’ascia sembra tipica della cultura di Trypillia diffusa tra Romania, Moldavia e Ucraina.
Più vicino temporalmente a noi, meno sorprendente, ma esteticamente più pregevole, il ritrovamento di cui sempre il 30 ci parla Sahir, una splendida testa di Apollo risalente a 1.800 anni fa rinvenuta nella città greca di Filippi.
Negli articoli del 30 e 31, Aleksa Vučković ci parla di due tribù o etnia della Britannia preromana, il 30 dei Durotrigi, che attraverso una complessa rete di relazioni tribali, costruirono un dominio che comprendeva gli odierni Dorset, Somerset e Devon, e il 31 dei Catuvellauni che opposero una fiera resistenza alla conquista romana.
Quale è stato l’anno peggiore nel quale essere al mondo? Robbie Mitchell non ha dubbi, ce lo spiega in un articolo del 31, il 536 dopo Cristo, quando i cieli del Globo, da Bisanzio alla Cina furono oscurati dalle ceneri di una mega eruzione vulcanica, come ci testimoniano, oltre ai resoconti degli storici, i carotaggi nei ghiacci groenlandesi. Questo fatto, con il sole oscurato per mesi, provocò la perdita di raccolti, carestie ed epidemie (la malnutrizione indebolisce il sistema immunitario).
Vediamo ora cosa ci riserva nello stesso periodo “Ancient Pages”, senza soffermarci su articoli che parlano di cose che abbiamo già visto. Il 25 marzo Conny Waters ci parla delle regole di un mercato dell’età medioevale. L’onestà era molto importante, e la frode e il furto venivano puniti con estrema severità. Tuttavia, alcune usanze dell’epoca ci sembrerebbero strane, ad esempio quella di tagliare le monete e usare i pezzi come spiccioli, ma allora il valore di una moneta non era un valore nominale dichiarato, ma proprio quello intrinseco del metallo di cui era composta.
Il 28 marzo Ellen Lloyd ci parla delle modificazioni corporee presso i vichinghi. Sappiamo che diversi popoli precolombiani delle Americhe ma anche alcune popolazioni eurasiatiche come gli Unni praticavano l’allungamento artificiale del cranio. Tale pratica non risulta finora attestata presso i vichinghi, ma nell’isola svedese di Gotland sono stati ritrovati i resti di tre donne dal cranio allungato, non si sa se artificialmente o per una mutazione naturale. Invece, come molti resti umani hanno dimostrato, la limatura dei denti presso i vichinghi era pratica comune.
Abbiamo visto che, come “Ancient Origins”, anche “Ancient Pages” dedica spazio alla mitologia, e infatti il 29 marzo abbiamo un articolo di A. Sutherland sulle ninfe, queste figure femminili semidivine che avevano un ruolo molto importante nella mitologia classica, greca e latina, le ritroviamo infatti in moltissimi miti, ma basterebbe un solo esempio: le istituzioni religiose romane che secondo il mito sarebbero state dettate dalla ninfa Egeria attraverso il re Numa Pompilio.
E’ forse il caso di segnalare qui una coincidenza temporale davvero significativa, infatti, se passiamo a esaminare ora cosa hanno da offrirci in questo periodo i siti minori e le fonti generaliste, vediamo che il 16 marzo è apparso su Youtube un filmato che riporta una conversazione fra Giuseppe Barbera, che ben conosciamo come animatore dell’associazione Pietas che sta ridando vita alla religione gentile, e il giornalista Leonardo Petrocelli, che ha come oggetto precisamente un approfondimento sulla figura di Numa Pompilio, il secondo re di Roma.
Il 14 marzo “ArcheoMedia” presenta un link a un altro filmato su Youtube, questa volta postato dall’associazione di rievocazione storica La Fara, una conferenza che ha come oggetto La selva Longobarda: il bosco nell’alto medioevo.
Sostanzialmente, nel trapasso tra tarda antichità e alto medioevo, si verifica una contrazione delle coltivazioni e un’estensione delle aree boschive nell’Europa meridionale, a causa sia del declino demografico delle popolazioni già facenti parte dell’Impero Romano, sia di un raffreddamento climatico verificatosi fra il quinto e la metà dell’ottavo secolo. Per conseguenza, i boschi e le risorse che potevano offrire, dai frutti spontanei alla cacciagione, al legname, si sono trovati ad avere un’importanza economica centrale. Nello stesso tempo, la riduzione delle aree coltivate porta a un’espansione della pastorizia, si afferma così quel modello economico che gli storici hanno chiamato agro-silvo-pastorale.
Arriviamo al 17 marzo. La ricorrenza di questa data mi provoca sempre un certo imbarazzo e sentimenti contrastanti, infatti, come ci ricordano diversi siti, è il St. Patrick Day, cioè il giorno di san Patrizio, patrono dell’Irlanda e celebra la cristianizzazione dell’Isola di Smeraldo, ma è ormai celebrata da presunti “celti” in ogni parte del mondo, Italia compresa, con chiassose esposizioni di grandi trifogli e indumenti di colore verde.
A prescindere dal fatto che non so proprio se sia da festeggiare, o invece considerare un giorno di lutto la cristianizzazione di un qualsiasi Paese europeo, considerando che essa, dovunque sia avvenuta, è consistita in un vulnus, una frattura profonda con le proprie radici ancestrali, corre osservare che non si tratta nemmeno di una ricorrenza di origine irlandese, bensì americana, inventata agli inizi del XX secolo dagli immigrati irlandesi di Boston, il che ne spiega la chiassosità non dissimile da quella di un halloween fuori stagione.
Ma soprattutto sembra che ben pochi ricordino che il 17 marzo è anche l’anniversario della nostra unità nazionale recuperata dopo 15 secoli di divisioni e dominazioni straniere; infatti, il regno d’Italia (un vero stato nazionale esteso dalle Alpi alla Sicilia, non una modesta appendice del Sacro Romano Impero o di quello napoleonico), è stato proclamato il 17 marzo 1861.
Mi spiace doverlo dire, ma sul futuro di un popolo che dimentica la propria storia, e in compenso è sempre pronto a scimmiottare usanze straniere, è difficile fare previsioni che non siano fosche.
Come vi ho evidenziato più di una volta, l’area archeologica di Pompei è ancora lontana dall’essere stata esplorata fino in fondo, e il lavoro dei ricercatori su di essa continua. Da “Notizie.it” del 25 marzo apprendiamo che i lavori nella Regio IX, insula 10, hanno portato alla luce i resti di un cantiere edilizio che pare fosse in piena attività al momento dell’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo. Dall’analisi dei reperti rinvenuti, ci si aspetta una sempre migliore comprensione delle tecniche costruttive romane.
Sempre per quanto riguarda Pompei, “Voloscontato” del 27 dà notizia dell’inaugurazione nel Parco Archeologico di un nuovo percorso turistico verde extra moenia, che costituisce anche uno spazio disponibile per eventi e altre attività.
RAInews del 27 marzo riporta la notizia che gli archeologi dell’Università di Gottinga hanno individuato in Grecia, nell’antico villaggio di Thorikos vicino alla città di Lavrio a sud di Atene i resti di quella che sembrerebbe essere la più antica casa greca conosciuta dell’Età del Ferro. Si sarebbe trattato di un’abitazione molto grande, composta da cinque o sei stanze e un cortile pavimentato, risalente a un periodo fra il 950 e l’825 avanti Cristo. La zona di Lavrio pare fosse economicamente importante perché vi si trova una miniera d’argento.
Anche questa volta, prima di congedare questo articolo, non mancherò di dirvi due parole conclusive e riassuntive. Già altre volte mi è capitato di paragonare questo lavoro alla ricerca di funghi, a volte si può essere fortunati, altre volte meno, e stavolta sembra una di quelle in cui la ricerca sembra essere meno fruttuosa.
Cosa c’è di rilevante dal nostro punto di vista in ciò che la seconda metà di marzo ci ha riservato? Non molto, pare, ma qualcosa si.
Innanzi tutto, vediamo una volta di più che quando si parla di antichità, si parla soprattutto di civiltà classica. La grecità in particolare, sia per quanto riguarda la mitologia, sia le conquiste del pensiero, ma ancora di più il mondo romano. Abbiamo visto l’area vesuviana, sia per quanto riguarda la decifrazione dei papiri ercolanesi, sia per gli scavi e le scoperte che tuttora proseguono nell’area di Pompei.
Ma forse più importante e significativo, è quando le tracce della romanità emergono dall’estero, come nel caso della ricostruzione dell’elmo di Hallaton di cui ci ha parlato “Ancient Origins”, esse ci testimoniano che la centralità che attribuiamo al mondo romano non è il frutto di uno snobismo nazionalistico, che del resto in Italia esiste molto poco o per nulla.
Anche stavolta vediamo che se ci spostiamo dall’antichità al medioevo, che una centralità in qualche modo simile a quella che nell’età antica ha caratterizzato il mondo romano, si può attribuire ai Vichinghi, e in effetti non è difficile sentire in qualche modo vicini a noi questi ardimentosi esploratori, pirati e guerrieri dell’Età di Mezzo.
Quel che è mancato questa volta, è qualche tuffo nella preistoria profonda, e, ad essere sinceri, non vedo l’ora che l’occasione si ripresenti, perché qui letteralmente ogni nuova scoperta sbugiarda la teoria farlocca dell’Out of Africa, costruita e imposta per i motivi politici che sappiamo.
Va a finire che stavolta il punto politicamente più rilevante sono proprio le considerazioni che vi ho esposto circa la ricorrenza del 17 marzo. Ho usato un linguaggio senza peli sulla lingua, lo so, ma spesso quella che molti chiamano durezza è semplicemente sincerità.
Con questo articolo, chiudiamo finalmente il mese di marzo, ma la mia tabella di marcia mi avverte che non potrà comparire sulle pagine di “Ereticamente” prima di metà maggio. La “forbice” fra gli eventi di cui vi parlo e il momento della comparsa sulle nostre pagine elettroniche, che ero riuscito a comprimere dedicando quasi per intero il 2023 a L’eredità degli antenati, è tornata ad allargarsi, è purtroppo una conseguenza inevitabile dell’aver preso ad alternare questa rubrica con articoli di altro tipo, per non rendere troppo monocorde il mio lavoro. Se sarà necessario, tornerò, almeno per qualche tempo a concentrarmi soprattutto su quest’ultima.
Di una cosa siate certi. In ogni caso, vedrò di fare il meglio possibile.
NOTA: Nell’illustrazione, da “Ancient Origins”, ricostruzione dell’elmo di Hallaton. Nell’angolo superiore destro il reperto originale, che inizialmente era stato scambiato per un secchio arrugginito.