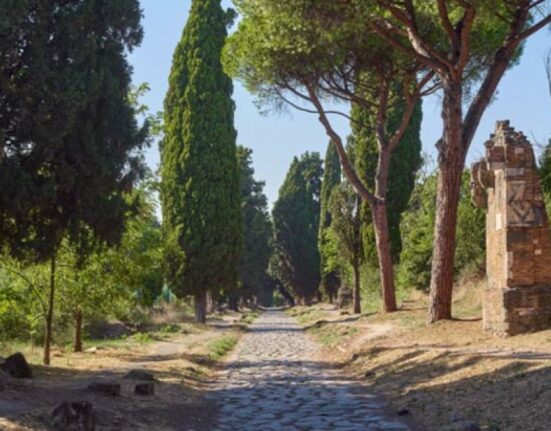Riprendiamo il nostro cammino alla metà di maggio 2023, uno strano maggio: sebbene manchino appena un paio di settimane a giugno, siamo ancora ad alternare cappotti e maniche corte. Il 1818 è stato definito dagli storici l’anno senza estate, perché a causa di un’eruzione vulcanica che disseminò grandi quantità di polveri nell’atmosfera intercettando la luce solare, le temperature rimasero basse provocando un anno interamente freddo e con gravi perdite di raccolti. Se si mantengono queste premesse, c’è da temere che anche il 2023 si riveli un anno del genere, sebbene non si abbiano notizie in questo momento di estese eruzioni vulcaniche. Intanto, a quanto pare, ricerche scientifiche serie stanno smentendo le paranoie mediatiche sul riscaldamento globale, nel senso che il momento attuale di innalzamento complessivo delle temperature, che certamente esiste, come esiste la riduzione dei ghiacciai, rientra nelle fluttuazioni periodiche del clima del nostro mondo, e sembra dipendere poco dalle attività umane.
Ma veniamo a noi. Come avete visto, negli ultimi tempi ho dedicato pressoché per intero a L’eredità degli antenati il mio spazio settimanale su “Ereticamente”, nel tentativo di ridurre “la forbice” fra i tempi degli eventi narrati e quelli della pubblicazione su “Ereticamente”, che, nonostante ciò, continua ad aggirarsi sui tre-quattro mesi. Continua un periodo “di piena” delle informazioni, mentre i tempi di pubblicazione su “Ereticamente” sono ovviamente fissi, ma vorrei ricordare che altrettanto facilmente potremmo trovarci “in secca” da un momento all’altro. Sono già venuti momenti in cui questa serie o rubrica non si è interrotta solo perché c’erano articoli pregressi da smaltire.
Questa volta vorrei, se me lo permettete, iniziare con una nota personale. Questo fine settimana appena trascorso, per motivi che adesso non occorre spiegare, mi sono recato a Pavia. Questa città ha oggi, tra i capoluoghi di provincia lombardi, un’estensione relativamente modesta, tuttavia ha avuto nel passato una considerevole importanza, infatti è stata la capitale del regno d’Italia longobardo. Probabilmente pochi lo sanno, ma re Alboino decise di sceglierla come propria capitale perché la città resistette a un lunghissimo assedio da parte sua, che pare sia durato addirittura due anni, ed era rimasto ammirato dal coraggio e dalla determinazione dei pavesi, e ritenne che fosse cosa migliore contare su un valoroso nemico fatto amico, che su chi si fosse invece dimostrato debole e vile.
È un discorso che ci rimanda a qualcosa che abbiamo visto poche Eredità degli antenati fa, quando ho avuto occasione di parlare del leone di Cheronea, il monumento fatto erigere da Filippo II di Macedonia, il padre di Alessandro Magno in omaggio alla Legione tebana, da lui battuta, ma del cui valore era rimasto ammirato.
Sono fatti che ci danno tutta la misura della differenza di mentalità fra l’uomo antico-medioevale (compreso un “barbaro” come re Alboino) e quella moderna dove invece da ottant’anni i vincitori, e soprattutto i servili servitori saltati sul loro carro, continuano a diffamare e ingiuriare in tutte le maniere e, sembra, con un accanimento sempre maggiore, gli sconfitti della seconda guerra mondiale.
Che non ci invitino a essere moderni, non lo siamo e non vogliamo esserlo, se questo significa, come pare, essere eticamente degeneri, preferiamo essere uomini della tradizione.
Tuttavia, anche nella nostra epoca degenere, un traditore non può ricevere altro che il disprezzo, non solo di coloro che ha tradito, ma anche di chi beneficia del suo tradimento. Un vigliacco può essere utile, ma senz’altro riceve meno considerazione di un avversario coraggioso. È esemplare il fatto che nonostante il voltafaccia dell’8 settembre 1943 (o forse a causa di esso) casa Savoia abbia perduto il trono d’Italia, mentre la dinastia imperiale giapponese che ha combattuto fino all’ultimo contro gli “alleati”, abbia conservato il proprio.
È con soddisfazione che apro le notizie di questo periodo con qualcosa che riguarda la mia Trieste. Un comunicato ANSA dell’11 maggio ci informa che un intervento compiuto dalla nostra municipalizzata ACEGAS AMGA per la riparazione di una condotta della rete idrica nella centralissima Piazza della Repubblica all’incrocio con via Mazzini, ha portato al rinvenimento di resti della Tergeste romana.
“Dalle indagini, condotte da Archeotest srl, è emersa la presenza di strutture e materiali archeologici, tra i quali frammenti di intonaco dipinto, di anfore, ceramica sigillata e laterizi, databili in via preliminare al IV-V secolo d.C. Il livello individuato, di frequentazione tardoantica o successiva, ricopre uno strato di distruzione con tracce della precedente occupazione di età romana”.
Vi è dunque l’evidenza che all’epoca del trapasso fra antichità e medioevo, la città è stata ricostruita dopo una precedente distruzione. Si tratta forse del segno lasciato dagli unni di Attila che devastarono parecchi centri della Venetia romana.
Rimaniamo in alto Adriatico perché il giorno dopo, il 12, “Corriere TV” ci informa del ritrovamento al largo dell’isola dalmata (oggi croata) di Curzola, del ritrovamento da parte dei sub, delle tracce di un’antica strada sommersa. Non è una novità che manufatti e costruzioni un tempo all’aria aperta possano finire sott’acqua per i cambiamenti del livello dei mari e il mutare dei profili delle coste, ma quello che sorprende è la datazione che le è stata attribuita in via preliminare, attorno al 5.000 avanti Cristo, settemila anni fa.
Continuiamo a rimanere dalle mie parti. Il 14 maggio è caduta la festa della mamma, una ricorrenza che ovviamente ciascuno celebra a suo modo, e per l’occasione il nostro Michele Ruzzai che, vorrei ricordarlo, oltre che sodale nell’avventura politico-culturale, è anche mio concittadino e caro amico, ha postato sul suo gruppo facebook “Manvantara” un link a un suo articolo, Dopo la caduta, l’età della madre e la luce del sud, già pubblicato su “Ereticamente” in data 12 ottobre 2014, che tratta ovviamente dell’antico matriarcato che ha preceduto le civiltà storiche. Intanto, la sua nuova rubrica sulla nostra pubblicazione, Strade del nord, è giunta al nono capitolo, e sono certo che tutti voi avrete avuto modo di apprezzare la ricchezza e la competenza delle informazioni fornite.
Passiamo ora a una notizia che MSN.com ha riportato con sorprendente insistenza da diverse fonti il 15, il 16 e il 17 maggio: il ritrovamento a Pompei degli scheletri di due nuove vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo, fra i resti di quella che è stata chiamata dagli archeologi l’insula dei casti amanti. Pare trattarsi dei resti di due persone anziane, entrambe di sesso maschile, il che rende improbabile che fossero amanti.
I due uomini pare siano stati travolti dal crollo di un muro causato dal terremoto avvenuto nelle prime fasi dell’eruzione.
Ricordiamo, a ogni modo, che l’area di Pompei è ancora una buona parte sepolta sotto la cenere dell’eruzione vulcanica, quindi è tutt’altro che da escludere che possa riservarci nuove sorprese in futuro.
Questo excursus campano, tuttavia non sembra modificare il fatto che in questo periodo sembra essere l’area triveneta-alto adriatica a dominare la scena. Il 12 maggio a Tolmezzo (Udine) nella Sala Multimediale di Palazzo Frisacco (via del Din 7), Pietro Favero, l’autore del bel libro La dea veneta, ha presentato la sua nuova opera La barca solare.
Come specifica la locandina di presentazione, si tratta di Un viaggio nel tempo alla riscoperta di comuni radici nell’orizzonte archeologico locale: nuova luce su miti antichissimi, come “la barca solare”.
 E non dimentichiamo neppure Elena Righetto, che venerdì 19 maggio ha tenuto presso la libreria “La gatta del Petrarca” di Este (Padova), via Matteotti 10, una nuova presentazione del suo libro Folklore e magia popolare del Veneto, rituali, superstizione e antica stregoneria.
E non dimentichiamo neppure Elena Righetto, che venerdì 19 maggio ha tenuto presso la libreria “La gatta del Petrarca” di Este (Padova), via Matteotti 10, una nuova presentazione del suo libro Folklore e magia popolare del Veneto, rituali, superstizione e antica stregoneria.
Andiamo a vedere cosa ci offre in questo periodo “Ancient Origins”, con la solita avvertenza che scremerò tutto quanto non riguarda l’archeologia, la storia, la preistoria europee.
Un articolo di Lex Leigh dell’8 maggio ci parla di un personaggio poco conosciuto della storia romana, Bulla Felix, questo non era davvero il suo nome, che non conosciamo, ma un soprannome che significa “amuleto fortunato” o “portafortuna”, l’uomo sarebbe vissuto nel II secolo dopo Cristo, al tempo dell’imperatore Commodo, e si narra fosse una sorta di Robin Hood dell’antica Roma, un ribelle che avrebbe raccolto un gruppo di seguaci nelle foreste attorno a Roma, dedito a rapinare i ricchi romani e aiutare i poveri. Tuttavia, non è nemmeno certo che sia veramente esistito, e non invece un personaggio letterario creato per dare voce alle tensioni sociali dell’epoca.
Il 10 maggio un articolo di John Black ci porta in un ambiente e in un’epoca completamente diversi, precisamente nella “Stonehenge russa” di Arkaim. Quest’ultima, che si trova nella regione degli Urali meridionali, e le cui rovine furono scoperte nel 1987, sarebbe stata un’antica città fortificata risalente al 2000-3000 avanti Cristo appartenente alla cultura Sintashta.
“Arkaim vantava due mura circolari concentriche, fortificate da un muro difensivo esterno e da un fossato largo due metri. Abitazioni rettangolari riempiono lo spazio tra le pareti, con l’intera struttura che si estende per ben 160 metri di diametro. Caratterizzato da quattro porte allineate con punti cardinali, l’insediamento mostra un’ingegneria avanzata con il suo sistema di distribuzione dell’acqua e tunnel per la rimozione dell’acqua in eccesso. Circa 35 case sono adiacenti al muro esterno, le loro uscite si affacciano sulla strada principale, dimostrando il design ben pianificato della città”.
Se avete dei dubbi sul fatto che le tracce del nostro passato, preistoria compresa, sono sempre intorno a noi, forse l’articolo di Nathan Falde del 9 maggio vi farà ricredere, ci racconta infatti di un caso accaduto a Vestland nel sud-ovest della Norvegia, dove una bambina di otto anni (chiamata convenzionalmente “Elise” per privacy), giocando nel cortile della scuola ha rinvenuto un’ascia neolitica che risalirebbe a circa 3.700 anni fa.
Non mi ci soffermo a lungo, perché è una cosa che almeno da noi dovrebbe essere ben conosciuta: un articolo di Dhwty del 12 maggio ci parla della spada nella roccia italiana, si tratta della spada di san Galgano, conservata a Montesiepi, solo che in questo caso, a differenza dell’Excalibur arturiana, il momento “magico” o “miracoloso” non è rappresentato dall’estrazione dell’arma, ma da quello in cui sarebbe stata conficcata nella roccia da Galgano, deciso ad abbandonare la vita del cavaliere per diventare eremita.
Può sembrare veramente strano, ma sembra che nemmeno la terribile situazione bellica in cui oggi si trova l’Ucraina, abbia interrotto del tutto la ricerca archeologica, infatti, sempre il 12 maggio un articolo di Nathan Falde ci parla del ritrovamento nella grotta di Verteba, nella regione di Borshchiv nell’Ucraina occidentale, di cinque statuette femminili stilizzate risalenti al primo millennio avanti Cristo, che sono state identificate come appartenenti alla cultura Cucuteni-Trypillian, che dominò una vasta area dell’Europa orientale durante il tardo Neolitico e l’età del rame (dal 6.000 al 2.750 aC).
Queste statuette venivano probabilmente usate come idoli o feticci durante cerimonie religiose.
Anche “Ancient Origins” festeggia a suo modo la festa della mamma con un articolo di Joel Christensen del 13 maggio sulla maternità nell’antica Grecia: se da un lato la mitologia le accordava grande valore, si pensi alla figura di Cibele, la “grande madre” nel pantheon ellenico, le condizioni reali di vita erano assai poco idilliache. Quella greca era una società misogina che teneva la donna in condizioni di di inferiorità, e le condizioni di igiene e di vita erano precarie, è stata calcolata una media di sei parti per donna, e il 40% dei nati non raggiungeva l’età adulta.
Sempre il 13 maggio, un articolo di Robbie Mitchell ci parla dell’inflazione nell’impero romano: essa ha avuto un ruolo chiave nel causarne alla fine la dissoluzione. Le continue campagne militari, i progetti faraonici degli imperatori, una gestione complessivamente inefficiente hanno causato un’inflazione galoppante, una svalutazione dei salari che ha acuito enormemente la distanza fra le classi sociali, mentre l’impero rimaneva senza mezzi economici per far fronte alle esigenze della sua vasta popolazione.
Un articolo di Ashley Cowie del 14 maggio ci parla dei resti dei due uomini ritrovati a Pompei, ma poiché ve ne ho già parlato, passiamo oltre.
Torniamo a parlare dell’antica Grecia, il 15 maggio un articolo di Martini Fisher ci parla di Alcibiade, figlio di un cugino, e poi adottato da Pericle, personaggio di grande fascino e noto per la sua bellezza, ebbe un ruolo alquanto ambiguo durante la guerra del Peloponneso.
Un articolo di Natalia Klimczak del 17 maggio ci parla dei figli di Cleopatra. L’ultima regina d’Egitto ne ebbe quattro, tre maschi e una femmina, il primo da Cesare, gli altri da Antonio. Il maggiore, Cesarione fu fatto assassinare da Augusto poco dopo la battaglia di Azio e la morte di Cleopatra. In quanto figlio di Cesare poteva rappresentare un serio concorrente al dominio imperiale. Il destino degli altri due maschi è incerto. Sorprendentemente, però, la figlia, Cleopatra Selene, fu trattata da Augusto con munificenza, e fatta sposare on un lussuoso matrimonio a Giuba, re di Numidia.
Sempre il 17 maggio, un articolo di Ashley Cowie viene a ricordarci che la nostra Italia è uno scrigno di tesori archeologici che ancora siamo lontani dall’aver esplorato a fondo, e che possono sempre saltare fuori nuove sorprese: infatti, nella grotta di Battifratta vicino a Poggio Nativo in Sabina, gli archeologi hanno rinvenuto una statuetta femminile risalente a 7.000 anni fa.
Per il momento mi fermo qui, con una avvertenza: non abbiamo visto qui cosa hanno da dirci in questo periodo i siti “minori”, ora interrompo per ragioni di spazio, ma vi premetto che soprattutto “ArcheoMedia” è ricco di novità per quanto riguarda l’archeologia italiana. Ve ne parlerò nella centoventiseiesima parte che, come mi è già capitato di dover fare altre volte, metterò in lavorazione subito dopo la stesura del presente articolo.
NOTA: Nell’illustrazione, a sinistra la venere di Willendorf menzionata da Michele Ruzzai nel suo articolo sul matriarcato (non si tratta però della stessa immagine che correda l’articolo di Michele), al centro, la locandina della presentazione del libro La barca solare di Piero Favero, avvenuta a Tolmezzo (Udine) il 12 maggio, a destra il libro di Elena Righetto Folklore e magia popolare del Veneto.