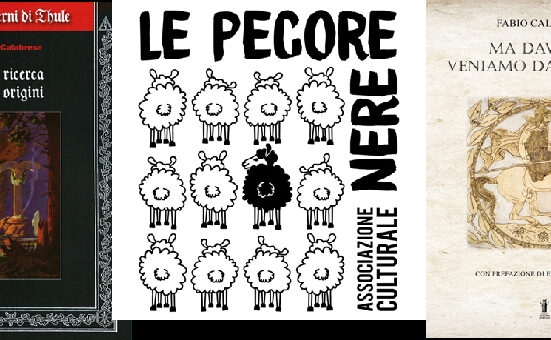Mi rimetto di nuovo a percorrere il cammino della nostra eredità ancestrale nel mese di maggio, il che significa che un terzo di questo 2023 che si sta rivelando un anno non meno sorprendente di quelli che l’hanno preceduto, se n’è ormai andato. “Non esistono più le mezze stagioni”, è considerata la tipica frase fatta, tuttavia sembra non essere mai stata vera come in questa primavera in cui tra aprile e maggio siamo passati quasi repentinamente dai cappotti alle maniche corte, ma non saranno certo le bizze meteorologiche a farci deflettere dal nostro intento.
Negli ultimi tempi, come avete potuto vedere, ho concentrato i miei sforzi soprattutto su L’eredità degli antenati, con l’obiettivo quanto meno di ridurre lo scarto temporale fra gli eventi di cui vi sto parlando e il momento della pubblicazione di questi articoli su “Ereticamente”, tuttavia, data la messe di novità emerse riguardo alla nostra eredità ancestrale esso rimane alto, e la mia tabella di marcia mi avverte che questo articolo che sto iniziando a maggio, non lo potrete leggere prima di agosto.
L’articolo precedente, la centoventitreesima parte, come avete visto, è tutto basato su informazioni raccolte dai siti generalisti, che sono state talmente tante da indurmi a rimandare il discorso su quanto avessero da dire i siti che si occupano specificamente di tematiche archeologiche come “Ancient Origins”, mi aspettavo quindi, riprendendo ora in mano l’argomento, di trovarvi una massa di informazioni sin qui trascurate, invece, ad esempio, sul sito irlandese c’è ben poco, a parte ritrovamenti extraeuropei di cui poco c’interessa: Mesopotamia, questioni bibliche (penso, e lo dico fuori dai denti, che il famoso “libro sacro” ebraico-cristiano non valga molto nemmeno come fonte storica), un articolo sull’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra (che ha ben poco a che vedere con il passato, tranne il fatto che è sembrata una rievocazione da film hollywoodiano) e sempre, più che mai, l’onnipresente Egitto.
Forse l’unica notizia d’interesse dal nostro punto di vista, la troviamo in un articolo di Nathan Falde del 30 aprile. Nell’isola di Karmoy al largo della costa occidentale della Norvegia, si trova un tumulo funerario noto come tumulo di Salhushaugen, a lungo ritenuto vuoto, invece un’indagine con il georadar ha messo in luce, a grande profondità, i resti di una grossa nave risalente all’VIII secolo. Quella di seppellire i capi insieme alle loro navi, era una prassi comune nella società vichinga.
È strana la metamorfosi che presenta negli ultimi tempi “Ancient Pages”, che presenta molti articoli di scienze naturali, paleontologia, geologia, biochimica, persino astronomia, cose senza dubbio d’interesse, ma altrettanto certamente fuori dal nostro campo. Stranamente, anche qui, quello che è forse l’unico articolo storico ci riporta al mondo vichingo. Quest’ultimo, risalente al 25 aprile ci parla di un personaggio piuttosto singolare, Ivar il disossato, “l’uomo senza ossa” che era affetto da una rara malattia, forse di origine genetica, vissuto nel IX secolo, malattia che gli procurava l’impossibilità di muoversi autonomamente. Nonostante la sua invalidità, Ivar fu uno dei più influenti capi vichinghi del suo tempo, e fondatore di un’importante dinastia reale norrena.
 L’articolo, firmato Ellen Lloyd ci racconta una vicenda poco meno singolare dello stesso personaggio: nel momento in cui le cronache irlandesi smettono di parlare del capo vichingo Imar, ecco che Ivar compare sulle coste dell’Inghilterra. È possibile che in realtà si tratti della stessa persona che ha spostato il suo interesse dall’Isola di Smeraldo a quella maggiore? Le somiglianze fra le due figure sono tante e tali, secondo l’autrice, da suggerire questa conclusione.
L’articolo, firmato Ellen Lloyd ci racconta una vicenda poco meno singolare dello stesso personaggio: nel momento in cui le cronache irlandesi smettono di parlare del capo vichingo Imar, ecco che Ivar compare sulle coste dell’Inghilterra. È possibile che in realtà si tratti della stessa persona che ha spostato il suo interesse dall’Isola di Smeraldo a quella maggiore? Le somiglianze fra le due figure sono tante e tali, secondo l’autrice, da suggerire questa conclusione.
Una cosa di cui noi spesso ci dimentichiamo, è che l’Irlanda ha subito l’influenza vichinga non meno dell’Inghilterra. Basti pensare, ad esempio, che Dublino, oggi capitale irlandese, nacque appunto come insediamento vichingo.
Pare proprio che dobbiamo continuare a parlare di vichinghi, e la cosa non fa meraviglia, infatti, se togliamo il mondo dell’Europa mediterranea, il mondo greco-romano, questi antichi navigatori, guerrieri e pirati sono forse la cosa più ricca di fascino della storia europea antica e medievale.
Devo dirvelo con una certa frustrazione: un sito che di recente ho alquanto trascurato, è “The Archaeology News Network”, a motivo del fatto che negli ultimi tempi sembrava diventato stranamente silente. Una recente scorsa mi ha rivelato un paio di nuovi articoli dei quali mi accingevo a parlarvi, ma quando sono tornato sul sito per una lettura più approfondita in vista dell’estensione del presente testo, non li ho più trovati, eliminati probabilmente perché datati per far posto a cose più nuove… prevalentemente di paleontologia e altre cose che con l’archeologia hanno poco a che fare. Vedo comunque di darvene un sunto, anche se non ho potuto memorizzare i riferimenti, e pertanto vi devo pregare di credermi sulla parola.
Tanto per cambiare, anche qui si parlava di vichinghi: il primo faceva notare che le invasioni vichinghe hanno trasformato grandemente la fisionomia della Gran Bretagna, non solo dal punto di vista antropologico, ma anche da quello zoologico, con l’importazione di cani, cavalli, capre originari della Scandinavia. Il secondo era in un certo senso il contraltare del primo, perché analizzava un villaggio anglosassone medievale e faceva notare che, nonostante la conquista normanna del 1066, la struttura e, a quel che era possibile capire, le consuetudini di vita dei suoi abitanti erano rimaste immutate.
In compenso, c’è un articolo che ci parla della ricostruzione, ad opera dello scultore e archeologo Oscar Nilsson, dei lineamenti di Vistegutten, il “ragazzo di Viste”, o “ragazzo solitario”, deceduto a soli 14 anni, risalente all’Età della Pietra, 8.300 anni fa, i cui resti sono stati rinvenuti in una grotta vicino a Viste nel sud-ovest della Norvegia.
Non c’è niente da fare, sembra proprio che in questo periodo gli uomini del Nord dominino il dibattito archeologico.
En passant, si può anche segnalare che lunedì 8 maggio “Focus”, canale 35 che è uno dei pochi canali televisivi (forse l’unico) che ha una programmazione intelligente e sembra non rivolgersi a un pubblico di decerebrati, ha mandato in onda un documentario sui vichinghi che restano ancora oggi, per dirla con Manzoni, un popolo e una cultura “più famosi che conosciuti”.
Il mondo nordico non mi dà la stessa sensazione di estraneità che mi procurano invece l’Egitto o la Cina, è certamente parte di una comune identità europea che condividiamo anche noi, ma andando a esaminare cosa offrono in questo periodo i siti generalisti che, come è prevedibile, si occupano soprattutto dell’Italia, si sente più facilmente un terreno familiare sotto i piedi.
Comincio con un comunicato ANSA del 28 aprile: A Venezia, i carabinieri del TPC (nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale) hanno recuperato una stele funeraria di età romana, che riproduce un busto femminile, nota come La Sposa del Deserto, che era stata illecitamente trafugata dai tombaroli nella necropoli di Zeugma in Turchia. La stele è stata poi consegnata all’ambasciata turca a Roma.
Nell’apprezzare la correttezza delle nostre autorità a questo riguardo, viene però un dubbio: se GLI ALTRI fossero altrettanto corretti nei nostri confronti? I musei di tutto il mondo sono pieni di opere d’arte italiane che perlopiù hanno lasciato i nostri confini illecitamente, o sono stati oggetto di razzia come quella condotta con un inaudito spirito di saccheggio da Napoleone su ordine della repubblica francese. Non lo dico io, è una stima dell’UNESCO, il 70% delle opere d’arte di tutto il mondo è italiano.
Sempre il 28 aprile “Notizie.it” ci porta a Murlo (Siena), località della Val di Merse, dove si trova un museo etrusco.
“Il museo di Murlo è uno dei luoghi più particolari da visitare per la scoperta della civiltà etrusca, con le sue decorazioni dei tetti, gli arredi, gli oggetti all’interno di una residenza principesca che risale al periodo tra la fine del settimo e la prima metà del sesto secolo avanti Cristo”.
Ma la particolarità che lo porta adesso agli onori delle cronache, è il fatto che in esso è stato inaugurato un “percorso tattile” di cui potranno beneficiare soggetti non vedenti e ipovedenti, ma anche bambini, per i quali il contatto fisico con gli oggetti è una fonte importantissima di apprendimento, insomma, come dicono gli amministratori, “Vietato non toccare”.
Il 29 aprile “La repubblica” ci presenta restaurato e riassemblato il carro della sposa di Pompei. Questo carro, di cui vi ho già parlato in articoli precedenti, ritrovato fra i resti della città campana seppellita dall’eruzione del Vesuvio, era un carro che si usava nelle cerimonie nuziali, con il quale la sposa era accompagnata alla casa del marito, finemente ornato, i sui resti sono stati l’oggetto di un’attenta ricostruzione durata due anni. Sarà in mostra a Roma a partire dal 4 maggio alle terme di Diocleziano.
Facciamo ora un salto lontano dall’Italia, nell’ormai famosa grotta di Denisova nell’Altai, dove sono state trovate le tracce di un’umanità a lungo sconosciuta, e molto indietro nel tempo, a 25.000 anni fa. La notizia è riportata in un articolo di Valentina Di Paola su AGI.com di giovedì 4 maggio: i ricercatori dell’Istituto Max Planck di Lipsia sono riusciti a ricavare da un ciondolo fatto con un osso di cervo, il DNA della persona che l’aveva indossato, e constatato che si trattava di una donna denisoviana vissuta circa 25.000 anni fa. La notizia è importante, perché i resti di denisoviani di cui disponiamo sono tuttora estremamente scarsi.
Ora, io non vorrei qui ripetere se non in estrema sintesi un concetto che vi ho più volte espresso: nel tentativo (patetico) di salvare il dogma dell’Out of Africa dalle irriverenti smentite dei fatti, i suoi sostenitori non hanno trovato nulla di meglio che restringere l’Homo sapiens paleolitico al solo Cro Magnon, negando l’umanità di neanderthaliani e denisoviani, al punto che in parte della letteratura sull’argomento, si trovano menzionati come “ominidi”. La paleogenetica li smentisce in pieno: Cro Magnon, neanderthaliani e denisoviani si sono ripetutamente incrociati dando luogo a una discendenza fertile: noi, e possibilità di incrocio con discendenza fertile significa solo una cosa: appartenenza alla stessa specie.
In realtà non si tratta di un testo nuovissimo, visto che è giunto proprio ora alla seconda edizione, ma vale senz’altro la pena di parlarne: per i tipi della Carocci, è giunto a una nuova edizione La cultura villanoviana all’inizio della storia etrusca di Gilda Bartoloni, archeologa che è stata docente di etruscologia presso le università di Lecce, Siena, Parigi la Sorbona, La Sapienza Roma.
Ritengo importante parlarne perché, una volta di più, qui si affronta un punto nodale per la percezione della nostra identità. La cultura etrusca, la cosa dovrebbe essere ormai assodata, ma il testo della Bartoloni ce lo conferma una volta di più, non è altro che la fase più matura della cultura villanoviana che, a sua volta affonda le sue radici nell’antichissima cultura terramaricola, si tratta quindi di quell’antichissimo sostrato di popolamento dell’Italia precedente alle invasioni indoeuropee, che possiamo davvero considerare autoctono e primordiale della nostra Penisola.
Sappiamo che gode ancora di credito la leggenda di una presunta origine mediorientale (anatolica) degli Etruschi, che è supportata da un’affermazione di Erodoto (e da nient’altro, mi pare). Ebbene, fuori dai denti, cosa vi fa pensare che una fonte antica non possa riferire una sciocchezza? Di mezzo c’è, come sempre, il fascino insidioso dell’Oriente, quello che io chiamo lo strabismo mediorientale, che ha portato a tante letture scorrette della nostra storia e della nostra civiltà. Vorrei ricordarvi che ho dedicato ben 34 articoli che potete trovare su “Ereticamente”, ad analizzare quella che ritengo una vera e propria patologia dello spirito.
Adesso vengo a parlare di qualcosa di decisamente “nostro”. Venerdì 5 maggio il gruppo fiorentino di Casaggi, costola culturale di “Destra identitaria” ha organizzato in collaborazione con le edizioni Passaggio al Bosco, nella sua sede di via Frusa 37, il convegno “Sacro e identità, i simboli runici e l’universo della tradizione europea”, con la partecipazione di Francesco Perizzolo, autore dell’opera in due volumi Rune, e di Alberto Brandi, autore della prefazione della stessa opera.
Di passata, sarà forse il caso di ricordare che le rune sono una simbologia germanica e norrena, e dunque anche questo evento si inserisce a pieno titolo nel momento di fortuna che, come ho ricordato nella prima parte dell’articolo, sembrano ora godere gli uomini del Nord e le tradizioni che li riguardano.
Poiché siamo giunti a parlare dei contributi specificamente “nostri” al dibattito sulle origini e l’eredità ancestrale, non sarà certamente fuori luogo ricordare che sulle pagine della nostra “Ereticamente” la rubrica “Strade del nord” del nostro Michele Ruzzai è, nel momento in cui scrivo, ormai giunta all’ottavo capitolo, capitolo che, come i precedenti, fa in realtà parte di un lavoro organico, corposo e documentato, che ha il preciso scopo di offrire un’alternativa all’Out of Africa che, nonostante le sue evidenti pecche che ho più volte rilevato, costituisce il dogma, la vulgata ufficiale “democraticamente” imposta sulle nostre origini.
Vengo ora a parlarvi di un evento che nel momento in cui scrivo si situa nel futuro, ma nel momento in cui voi leggerete l’articolo, si sarà certamente svolto: per domenica 28 maggio è prevista ad Ariccia (Roma) presso l’albergo ristorante Fontana di Papa la conferenza Misteri della storia da riscrivere. I relatori sono Felice Vinci, autore di Omero nel Baltico e I misteri della civiltà megalitica, Susy Blady, co-autrice assieme a Vinci de Il meteorite iperboreo, e Marco Pesci, autore di Babilonia. La creazione. Indagine tra mito e scienza. Su una cosa i relatori hanno indubbiamente ragione, riguardo alla storia, soprattutto quella antica, le pagine da riscrivere sono parecchie.
Trarre una conclusione complessiva è forse più difficile che altre volte: rimane un segno di difficile interpretazione il fatto che le tematiche connesse alla nostra eredità ancestrale sembrano aver guadagnato spazio sui media generalisti proprio nel momento in cui i siti specializzati nelle tematiche archeologiche latitano o paiono decisi a ignorarle. È come se la voce dei nostri antenati si rifiutasse di farsi zittire.
NOTA: Nell’illustrazione, immagine tratta dall’articolo di “Ancient Pages” del 25 aprile, che ci presenta una sorta di sintesi del mondo vichingo.