Secondo una delle tante e celebri espressioni del filosofo Martin Heidegger, e non a caso definito ‘L’ultimo sciamano’ in un ricordo, pubblicato a trent’anni dalla morte, dallo studioso Franco Volpi, ‘l’uomo abita nella casa del linguaggio’. Circondato dalle cose familiari, di cui ci prendiamo ‘cura’ (altro termine caro al filosofo) e di cui sovente ci rendiamo conto del loro valore solo in particolari circostanze e tempi e privazioni, a cui si è dato un nome e di cui ignoriamo, però, l’essenza più profonda. Ecco perché – non essendo qui intenzione di percorrere le suggestioni la fascinazione le provocazioni del suo filosofare, per cui mi si perdoni la dura e scorretta semplificazione – egli può aggiungere come il parlare sia darsi all’ascolto. (E ciò vale anche per la scrittura, va da sé, che trasmette ad altri ‘il divino stupore’, come lo definiva Platone, o ‘la meraviglia’, come rammenta Aristotele nella Metafisica. E se, per i due filosofi riguardi l’insorgere della domanda filosofica, appunto, anche di questo qui non ci interessa operare i distinguo).
Ascoltare, dunque, a che l’Essere si doni e si riveli tramite la parola ed essendo egli stesso parola (forse eco, direbbe la teologia del Cristianesimo, di quel Verbo che s’è fatto carne per manifestarsi – ed Heidegger era figlio di un sagrestano cattolico come Nietzsche di un predicatore luterano, da cui trasse espressioni quali, ad esempio, ‘Dio è morto’ mediato da un canto evangelico. Il che non li sottrae, si badi bene, a seguire e a perseguire una riflessine di critica alla religione rivelata, confondendo per il primo l’esistente con l’essere e per il secondo imponendosi quale ‘morale degli schiavi’). Le parole diventano simili al canto delle sirene di cui Ulisse volle ascoltarne l’armonia e l’inganno, pur cautelandosi mettendo cera nelle orecchie dei marinai e da costoro facendosi legare all’albero della nave. Per chi non si rende accorto il gorgo l’infrangersi contro gli scogli, insomma il blaterare privo di senno l’ignoranza… ‘Tempus loquendi, tempus tacendi’, cappella di Ixotta nel Tempio malatestiano di Rimini.
L’in-canto delle parole… Avvolti dalla melodia, quando la voce della comunità si eleva a raccontare la storia di dei ed eroi, tramite il linguaggio del cuore, un io narrante collettivo perché le vicende di uno sono di tutti ed esempio sul destino dell’uomo e di un popolo. Fu così che nacque il senso tragico e virile dell’esistenza, la rappresentazione originaria, la catarsi, l’incontro del dio Apollo dalle belle forme con Dioniso, il dio della danza e dell’ebbrezza (Nietzsche docet e non solo lui). Difatti, in origine, la tragedia greca s’affidava al coro e gli attori non potevano calcare la scena se non in due soli. Il moderno Io narrante è la voce dell’individuo dell’egoismo e dissociazione dalla società, che appunto si fa interesse di ‘soci’ e non più unità di comunione ed intenti… dove, con il pensiero calcolante, la ragione tutto spiega giustifica rinnega ed assolve.
‘Intorno al fuoco bevono buon vino i cavalieri ed il chiaror riflette i lor profili neri’… oppure ‘basta prendere una chitarra farci sopra quattro accordi attaccarci due parole e cominciare a cantar storie’, magari sui monti Lepini, il fuoco il cerchio intorno ad esso in attesa del sorgere del sole, Solstizio d’inverno. Notti magiche il silenzio scandito dal vento a frusciare tra i rami le parole misurate e serie le canzoni di una comunità altra ed alta rispetto al vivere quotidiano. Questo è l’in-canto delle parole che abbiamo conosciuto che hanno la mente ed il cuore alimentato di sogni e ideali… e di questo incanto che trova le sue misteriose sorgive fonti negli albori della civiltà d’Occidente ci facciamo carico nel corso del tempo con i poemi le utopie la fantasia simboli metafore suggestioni mai rimpianti rimorsi rancori. (Chiuso nella cella d’isolamento, avrei trascorso a Villa Triste qualche mese, ho pochi motivi di distrazione, non potendo leggere il giornale ricevere posta o libri neppure gli occhiali o i fiammiferi per accendermi le sigarette. Conto le mattonelle trasudanti umidità in verticale in orizzontale le pari e le dispari… e canto rido ballo e mi racconto i libri letti i film visti le fantasie che creo e scompongo. Parlo, dunque, sono!).
Racconta Tolkien d’aver iniziato a tratteggiare la Terra di Mezzo quando era in trincea, immerso nel fango pidocchi merda sangue corpi gonfi in putrefazione, durante la Prima Guerra Mondiale, fronte francese, e di averne scritto alla fidanzata lontana. I tedeschi come gli Orchetti? Chissà. La montagna di Mordor il mondo moderno? Forse. D’ogni cosa costruire la controparte in forma di magia, evasione dal reale o rammemorare il reale prima che il razionale lo neghi così come l’adulto recide, illuso, il cordone ombelicale da quel che egli era bambino (alla faccia della saccenteria di Hegel nell’identificare il reale con il razionale e viceversa). ‘Le radici profonde non gelano mai’. E, forse, sarà un caso, ma, durante la guerra civile di Spagna, quando la quasi totalità della cultura anglosassone si schierò con la repubblica egli parteggiò per Franco e la Falange. Per una parte dove ancora, magari retoricamente, Don Chisciotte contava qualcosa.
Omero Dante Joyce e il loro Ulisse, sempre uguale e così diverso… come, del resto, è il viaggio per ciascuno di noi e nel modo di raccontarlo. Ad occhi aperti con la valigia in mano oppure – mi insegnava mio padre – a guardare il mondo tramite i libri fra le pareti della propria stanza. Ed è un mondo di parole, di carta straccia forse, ma che raggiunge lo stesso le vie del sogno e della commozione. Emilio Salgari fece una navigazione breve ed unica da Chioggia e dintorni in tutta la sua sfortunata esistenza, eppure ha donato a generazioni di italiani d’ogni età e censo quella letteratura nazional-popolare dove si può in cortile ridare vita ai pirati di Monpracem, ‘la tigre non è morta!’, e imbarcarsi sul vascello del Corsaro Nero veleggiare per i mari del Sud a caccia del ‘perfido’ olandese nei giardinetti pubblici.
Qualcuno vorrebbe farci sopra dell’ironia, togliere alla parola il suo potere evocativo – ‘Apriti sesamo!’ e la grotta ricca di tesori si apre al misero Alì Babà – ricordare che si abbaia, simili a cani, quando non si hanno più denti per mordere. Il grande Totò o ‘Tante me ne ha date ma quante ne ho dette!’… Arrogarsi il diritto di stabilire dei fatti la superiorità, dimentichi che tra questi e l’interpretazione non v’è alcuna scissione. Il privilegio così breve e così nostalgico della giovinezza. L’età della spranga e del sacco a pelo. Mi irritava mio padre, chiuso in camera con i suoi libri e la radio a trasmettere musica classica, e la sua bonarietà sulla noia fedele compagna, fonte creativa. Altri ad altra soluzione estrema si danno. In un alberghetto nei pressi della stazione di Torino, 28 agosto 1950, Cesare Pavese si toglie la vita. Dieci giorni prima, la data è del 18 agosto, aveva annotato su Il mestiere di vivere – ed è l’ultima – ‘Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più’. Eppure, avevo sedici anni, decisi d’essere un futuro insegnante, conscio che dalla cattedra era possibile dischiudere un universo, fatto sì di parole, ma tali da consentire alla mente ed al cuore di mettersi in cammino. E così è stato…
L’in-canto delle parole. Venne prima lo sguardo a riconoscere la diversità o fu la parola, dare il nome alle cose, che resero gli occhi vigili e attenti? Chiudo gli occhi e il mondo svanisce; nella mente esso si preserva tramite il linguaggio. Avete letto i racconti, a volte simili ad aforismi o fiammelle guizzanti nella notte, dello scrittore argentino J.J.Borges, cieco? Oppure Jacques Prévert (fu una giovane bionda di Verona a farmi apprezzare i suoi versi in una soffitta polverosa secchi manifesti riviste bastoni di una delle tante realtà che credevano alla bontà di Mao e alla sincerità della ‘rivoluzione culturale’), Paris at Night, ‘Tre fiammiferi un dopo l’altro accesi nella notte – il primo per vedere intero il volto tuo – il secondo per vedere gli occhi tuoi – l’ultimo per vedere la tua bocca – e l’oscurità completa per ricordarmi queste immagini – mentre ti stringo a me tra le mie braccia’? E cosa valgono le cose che ho scritto e che, ostinato, continuo a scrivere nelle notti insonni (Robert Brasillach: ‘E i miei libri, le mie visioni – possono essere dispersi al vento: amore e coraggio – non sono soggetti a processo’. Avete notato che i libri si accostano all’amore e al coraggio?), io, scrittore e genio e buffone funambolo e giocoliere, maschera di me stesso?
La parola e i suoi mille volti e i suoi mille inganni… Ma, in fondo, non accade lo stesso agli occhi, quando in penombra o nell’improvviso irrompere della luce, vediamo svanire le cose farsi esse mobili e imperfette? Come la verità, pensava Heidegger, quell’aletheia che, non essendo più nascosta, si manifesta ma, per sua stessa natura, tende ad ottenebrare la mente… Platone, nella Repubblica, parla delle ‘divine menzogne’ per rendere le gerarchie della pòlis stabili fin dalle origini. Gli uomini impastati di fango ed oro ed argento e di bronzo. E, allora? Anche la ‘casa del linguaggio’ può essere una prigione, forse lo è sempre, sta a noi far sì che appaia dorata e non catena servile. ‘Hanno detto che i miei versi possono fare del bene, non me ne rallegro. Hanno detto che i miei versi possono fare del male, non me ne dolgo…’: così Charles Baudelaire. Dimenticavo: io poeta…
Mario Michele Merlino






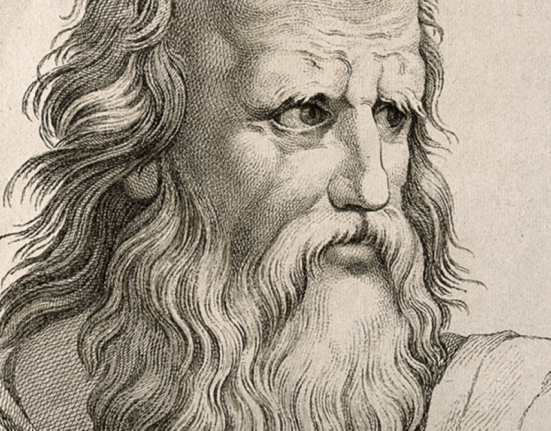

4 Comments