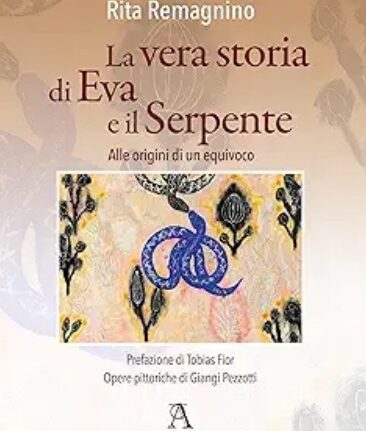La tradizione sciita, una delle più preziose per la ricostruzione del nostro passato, ricorda un tempo antichissimo in cui l’Adamo-primordiale era ancora «nella terra d’India», e precisamente nella regione che i geografi greci chiamavano Taprobana, gli arabi Serendib (da cui deriva il termine inglese serendipity) e la geografia moderna Sri Lanka.
Ancora oggi frotte di pellegrini buddisti, indù, cristiani e musulmani s’inerpicano sul Picco di Adamo (2.304 mt.), un monte circondato da elefanti e piantagioni di tè, per rendere omaggio all’«impronta sacra» (Sri Pada) ritenuta dai buddhisti essere appartenuta a Buddha, dagli induisti a Shiva, dai cristiani a San Tommaso e dai mussulmani ad Adamo [immagine 1].
Citata da grandi viaggiatori come Marco Polo e Ibn Battuta, la montagna sacra avrebbe ospitato in tempi preistorici la «penitenza» dell’uomo-Adamo, il quale, dopo l’espulsione dal paradiso terrestre, sarebbe rimasto quassù mille anni su un piede solo (vedasi l’unica impronta) pensando al da farsi. Detto altrimenti: quando le catastrofi postglaciali distrussero il mondo (spirituale) delle grandi civiltà un abisso di senso si aprì tra il «prima» e il «dopo», quindi lo Spirito s’incarnò nella Materia, la sapienza del Serpente Antico fece un passo indietro, il Falco Solare dispiegò le ali e volò via.
Un’epoca finiva e l’«annuncio» di quella successiva, ovvero la venuta dell’uomo fisico terrestre, fu dato a Ceylon dove le ricerche dell’antropo-archeologo Thor Heyerdahl collocano i redin, esseri antidiluviani con «capacità superiori a quelle umane» (T. Heyerdahl, Il mistero delle Maldive, Milano, CDE, 1989).
Incorporato nelle narrazioni tradizionali come molte altre antiche memorie, questo racconto potrebbe risalire alla reale presenza nella regione di una remota civiltà altamente evoluta; oppure, all’approdo sulla punta meridionale dell’India di navigatori d’alto mare capaci di muoversi a grande velocità sull’oceano grazie all’uso sapiente dei remi e della vela.
Se oggi i geologi riconducono l’enorme depressione situata nei pressi degli atolli delle Maldive al forte campo gravitazionale prodotto da una massa consistente di montagne sommerse, significa che violentissime inondazioni seppellirono sotto chilometri quadrati di acqua intere regioni nell’estremità meridionale dell’India.
Kumari Kandam
Il grande viaggiatore Marco Polo scrisse in un diario di avere visionato una carta nautica risalente a «prima del Diluvio» nella quale l’estensione dell’area geografica situata a sud dell’attuale Capo Comorin era di gran lunga superiore rispetto a quella da lui veduta con i suoi occhi. Altri mercanti europei in viaggio nelle Indie riportarono notizie analoghe, ma anche i miti del diluvio presenti nel patrimonio culturale di tutto il mondo fanno riferimento a un territorio dravidico molto più vasto di quello attualmente conosciuto (N. Mahalingam, Kumari Kandam. The Lost Continent, Proceedings of the Fifth International Conference/Seminar of Tamil Studies, Mandurai, 1981).
Dal canto suo la cultura Tamil (sud-est dell’India) colloca qui la culla della propria civiltà, specificando come nel periodo che precedette il suo parziale sprofondamento Ceylon fosse stato un rinomato crocevia marittimo di popoli e culture.
La sola posizione geo-strategica tuttavia non sarebbe bastata a produrre una risonanza mondiale, né avrebbe spinto culture tra loro differenti e lontane a collocarvi nientedimeno che la culla dell’Adamo-primordiale, o uomo ri-nato. Qualcosa di unico e speciale doveva annidarsi laggiù, dove, infatti, si trovavano le preistoriche scuole di saggezza di Kumarikkandam, o Kumari Nadu, la mitica terra inghiottita dal rialzo delle acque oceaniche.

In genere questo nome evoca l’immagine di un «continente» più o meno esteso, ma chissà se tale corrispondenza è vera, dato che la tragedia di Kumari Kandam fu «tramandata oralmente per generazioni» prima di essere messa per iscritto nel poema epico Manimekalai, una raccolta di racconti orali vecchi di svariate migliaia di anni, come precisato in una glossa dotta all’Iriyanar Agapporul del noto commentatore medioevale Nakirar (G. Hancock, Civiltà sommerse, Corbaccio, 2002).
Nella letteratura tradizionale si parla dell’inabissamento di Quarantanove Territori avvenuta a più riprese, tesi confermata dalla moderna oceanografia: nel 16.000 a.C. circa una prima grande inondazione erose ampie porzioni di fascia costiera; nel 14.058 a.C. circa finirono sott’acqua intere pianure; infine, nel 9.564, tutta la regione di Kumari Kandam sparì dalla faccia della Terra insieme alla sua cultura.
Come si può notare l’ultima data combacia con il famoso 9.600 a.C. indicato da Platone nel Crizia in riferimento alla fine di Atlantide, il che significa che l’inabissamento del «sapere precedente» fu una tragedia globale, o semi-globale, nella quale perirono numerose «atlantidi», tutte regolarmente archiviate nella sezione «miti e leggende» da un’umanità sprovvista delle capacità spirituali e intellettuali necessarie a comprendere la reale portata di una perdita del genere.
Dopo l’inabissamento di parte del promontorio meridionale dell’India i superstiti fuggirono nella direzione opposta, ossia verso le vaste regioni costiere e le ampie pianure irrigue del golfo di Kutch, dove fiorì la «tradizione dell’Indo-Sarasvati» successivamente sfociata nell’integrazione di diverse comunità non soltanto nella valle dell’Indo ma anche nelle regioni adiacenti, fino all’Egitto (tra il 10.000 e il 2000 a.C.).
Finché il progressivo rialzo delle acque (quantificato in 60 metri) raggiunse anche il Gujarat indiano, e allora Sette Saggi (7×7=49) si misero alla guida dei popoli conducendoli fin sulle montagne dell’Himalaya, dove il sapere degli avi venne messo al sicuro nei Veda, destinati ad attecchire nelle terre comprese fra l’Indo e il Gange.
Lo Skanda Purana assegna il medesimo ruolo salvifico al meridionale monte Arunachela protetto da Shiva, l’ascetico «signore dello yoga», associato comunque dai testi vedici alle alte vette dell’Himalaya, cioè alla fascia sub-artica (M. Macchioni, Skanda Purana, Enea Edizioni, 2024). Nord o Sud, insomma, la sostanza del racconto è la stessa: il rialzo vertiginoso delle acque spinse intere popolazioni a migrare dal mare alla montagna.
Il lungo viaggio degli dèi-netjeru
Il processo geologico che chiude ogni Era Glaciale, oggi chiamato «rimbalzo post-glaciale», o «isostasia post-glaciale», non produce soltanto inondazioni apocalittiche ma scatena anche un’intensa attività vulcanica, tettonica e sismica che impregnando l’aria di ceneri oscura il sole per lunghi periodi.
A farne le spese sono in primo luogo le regioni geologicamente innervate di reti vulcaniche sotterranee, come ad esempio il Giappone, a quei tempi abitato dagli Jomon. Non se la passarono meglio le coste orientali del Pacifico, dove terremoti di eccezionale intensità risvegliarono la potenza distruttiva della «fascia infuocata» comprendente gli attuali Messico, Bolivia, Perù e Cile, che nel periodo glaciale ospitarono le civiltà fondate dai viracochas, esseri dotati di straordinarie capacità.
Gli invasori europei sbarcati nel Nuovo Mondo vennero a conoscenza dell’opera di questi civilizzatori dall’aspetto così simile al loro dai racconti dei popoli precolombiani, quasi subito derubricati a «storie mitologiche»; cosa che di lì a qualche secolo avrebbero fatto anche gli archeologi alle prese con i geroglifici che narravano le origini degli dèi-fondatori dell’Egitto.
Il confronto per chi si crede chissacché, o pensa di avere fatto chissà cosa, non è mai facile. Ma si dà il caso che «oltre i limiti del mondo» (oltreoceano) nel periodo glaciale fosse davvero esistita l’antichissima e mai decifrata civiltà marinara di Tiahuanaco (Bolivia), o Tiwanaku, così chiamata dal nome dell’omonimo impero che occupò per ultimo quell’area geografica (dal 600 al 1000 d.C. circa). Un fatto testimoniato dal ritrovamento di numerosi moli e banchine sollevati a un’altitudine di 3.900 metri, non si sa come, né spinti da quale forza poiché nessuno ha mai portato a termine una seria esplorazione scientifica.

Manteniamoci dunque nel campo della logica supponendo che il perdurare dell’attività sismica e vulcanica connessa ai processi di deglaciazione abbia spinto coloro i quali avevano dimestichezza con l’arte marinaresca a prendere la via del mare. Tracce di questi transiti sono tuttora visibili in alcuni caratteri calligrafici (corrosi dal tempo ma leggibili) rilevati sull’Isola di Pasqua e a Mohenjo-daro [immagine 2], nonché in duecentocinquanta geroglifici ritrovati sulle rocce del Parco Nazionale della Hunter Valley, cento chilometri a nord di Sydney.
Quali mani incisero sulla pietra questi segni anomali, cioè diversi dai graffiti di animali tracciati dagli aborigeni? E come si spiega la loro somiglianza con lo stile arcaico e poco conosciuto delle prime dinastie egiziane?
Due pareti della grotta australiana decifrate dall’egittologo Raymond Johnson, già direttore dell’Epigraphic Survey di Luxor, hanno riportato alla luce la saga di antichi navigatori approdati sulle coste australiane in tempi remoti. Qui sarebbe morto prematuramente «il Signore Djes–eb», capo di una stirpe regale, ucciso mentre «trasportava alto il vessillo del Dio Falco». E guarda caso lo Zep Tepi, cioè la promettente epoca dell’incivilimento egiziano, iniziò proprio con la costruzione di un tempio dedicato al Grande Falco (il dio Horus).
Telepatia intercontinentale, o fisiologica esportazione di idee, simboli e cultura? Oltre ad adorare il Falco, sovrano del mondo, gli artefici del nuovo ordine praticavano le arti dell’imbalsamazione diffuse in linea trasversale, dal bacino del Tarim alle culture preincaiche.
I professionisti del dubbio diranno a questo punto che i due indizi citati formano una semplice coincidenza, perciò non significano nulla. Ecco allora il fatidico terzo segnale che fa la prova: come si spiega la fondazione dell’Egitto, in cui qualsiasi conoscenza si presenta come già formata e giunta all’apice?
Una dottrina così elaborata, con tutto il suo ricco patrimonio simbolico e l’ancora più complicata visione cosmologica, non sbuca fuori dall’oggi al domani come per magia ma è il risultato di un lungo affinamento di idee religiose e di conoscenze tecniche maturate nel tempo (R.A. Schwaller de Lubicz, La teocrazia faraonica, Edizioni Mediterranee, 1994).
In fondo la storia dell’uomo è essenzialmente una storia di migrazioni, non c’è nulla di stravagante nella fuga dai vapori tossici della «fascia infuocata» sudamericana di gruppi di navigatori, né tanto meno nella scoperta dell’Egitto, dove prima dell’inaridimento progressivo del Sahara (cominciato nel III millennio a.C.) si stendevano sterminate praterie percorse dai venti monsonici.
A sud la savana verdeggiante era strapiena di animali selvatici, mentre a nord la vasta regione paludosa offriva numerose isole fertili; c’era forse un posto migliore in cui dare l’avvio a una nuova società, edificare nuove case e nuove città, progettare nuovi templi, elaborare nuovi concetti scientifici e religiosi?
Incredibile ma (forse) vero
Il gioco delle correnti oceaniche di decine di migliaia di anni fa non rientra nelle attuali conoscenze. Sappiamo tuttavia che durante la massima espansione glaciale del Würm (tra i 31.000 e i 18.000 anni fa) la navigazione si svolse senza particolari problemi dall’Asia verso le Americhe; l’alto tasso di sollevamento del mare ne causò il rallentamento (tra i 15.000 e gli 11.000 anni fa); finché il livello delle acque si portò alla posizione attuale e i collegamenti s’interruppero (intorno a 5000-6000 anni fa).
L’esperienza (mai smentita) di Thor Heyerdahl ha dimostrato inoltre come salpare dal Sudamerica per raggiungere l’Eurasia sia stato più agevole che affrontare il percorso inverso durante la fase di alleggerimento dei carichi sulle regioni prima gravate dal peso dei ghiacciai würmiani, grosso modo tra i 17.000 e i 7.000 anni fa. Ergo: «navigatori sudamericani» in fuga dalle devastazioni dei territori di origine potrebbero avere sfruttato la corrente per spostarsi da est a ovest.
È un’ipotesi, chiaro; ma poniamo il caso che nell’età precessionale della Bilancia (15.180 – 13.020 a.C. circa) il primo capitano coraggioso giunto in terra d’Egitto sia stato Atum (il dio che «nacque per primo»), descritto come la «forza primigenia» che prese forma nella terra attraversata dal Nilo.
Curiosamente il geroglifico di questo neter mostra una slitta vuota interpretata dagli egittologi come un’allusione all’impossibilità di antropomorfizzare il non essere. Può darsi; ma perché proprio una slitta? A chi può essere venuto in mente un «carrettino» senza ruote arrancante sull’erbetta umida che stava spuntando al posto delle paludi bonificate?
A meno di considerare la versatilità della slitta, che non scivola soltanto sulla neve ma fila come una scheggia sulla lava solidificata presente in grandi quantità sulle isole dell’Oceano Pacifico, ciclicamente stravolte dai riassestamenti crostali.
Fino all’arrivo dei colonizzatori europei nel XVIII secolo, una delle attività praticate dai nativi delle Hawaii era per l’appunto trascinare su e giù lo slittino dai pendii ricoperti di magma vulcanico solidificato (he’e holua). Pare che questo antichissimo rito risalisse agli antenati, spesso impegnati a scivolare lungo le piste (kahua holua) formate da lastre di roccia lavica e pietre ricoperte di erbe spontanee per ingraziarsi Pele, la furibonda dea dei vulcani e madrina del fuoco.
Ancora una volta potrebbe trattarsi di coincidenze; ma chi persevera nella ricerca della luna nel pozzo al minimo trova dell’acqua (Confucio), e, nella fattispecie, già qualche secchio è stato riempito: 1) salpate dalla fascia infuocata posta «oltre i limiti del mondo» flotte preistoriche provenienti dalla regione di Tiahuanaco fecero scalo in Polinesia, tuttora dotata di uno tra i più antichi e mai del tutto compresi sistemi di navigazione; 2) procedendo fra le sempre più rare terre emerse i navigatori raggiunsero Ceylon, l’«isola dell’annuncio»; 3) dopo un lungo soggiorno meditativo essi ripartirono quindi alla volta del Golfo di Aden, inoltrandosi nel Mar Rosso.
Grandi navi giacciono oggi sepolte lungo il lato meridionale della Grande Piramide mentre da scavi effettuati a tredici chilometri dal Nilo, nei dintorni di Abydos, sono spuntati dalla sabbia dodici navigli d’alto mare dalle prue affusolate. Se la cosa serve a tranquillizzare gli animi si può anche continuare a credere che tra un’aratura dei campi e una semina i contadini egiziani si siano dati la pena di costruire imbarcazioni capaci di solcare gli oceani. Oppure, che i Faraoni abbiano circumnavigato l’Africa prima dei Fenici. Oppure, che le navi fossero dei «simboli del vascello spirituale che trasportava l’anima del re defunto in cielo»; come se dei modellini più leggeri e meno costosi non avessero potuto rappresentare con identica efficacia la «barca del Nu», o Nun, personificazione dell’«Abisso liquido primordiale in cui erano contenute in germe tutte le cose esistenti».
E comunque, se anche tutto questo fosse vero, rimarrebbero altre questioni aperte. Per esempio: perché le navi di Giza sono identiche, sia nel metodo di costruzione che nell’aspetto esteriore, alle imbarcazioni di canne di totora ritrovate a Suriqui, nel Lago Titicaca? Come si spiega il ritrovamento in nove mummie egizie di coca e tabacco, piante indigene dell’America, che, stando alle affermazioni scientifiche, non avrebbero dovuto esistere nel Vecchio Mondo prima di Colombo? E via dicendo.
Le fosse egiziane in cui riposavano le imbarcazioni sono due: dalla prima è uscito un vascello lungo quarantatré metri, attualmente conservato nel Museo delle Navi del Cairo, mentre l’altra è ancora sigillata. Le camere a fibre ottiche hanno tuttavia rivelato la presenza di un’altra nave, alta più di trenta metri, che, a conti fatti, è meglio lasciare sotto la sabbia in attesa di tempi (e uomini) che non temendo il confronto con il proprio passato trovino il coraggio di riscrivere la Storia.