Avvertenza: il presente articolo tratta di un tema delicato e se ne sconsiglia la lettura alle persone particolarmente impressionabili. La seguente trattazione è una analisi sulla storia della religione e non vuole in nessun caso rappresentare dei consigli medici e/o dei suggerimenti a compiere le pratiche descritte che, anzi, vengono assolutamente sconsigliate.
Riguardo alle discipline orientali l’uomo comune della nostra società ha una visione assolutamente deformata e superficiale, ne conserva dei luoghi comuni e degli stereotipi assolutamente ridicoli se confrontati con i testi originali della Tradizione religiosa orientale. È il caso dello Yoga che spesso e volentieri viene ridotto ad una pratica assimilabile a una semplice
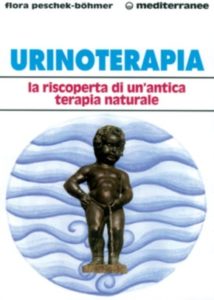
ginnastica, o del Tantra, volgarizzato a una pratica di sesso mistico da attuare col partner. Purtroppo in occidente si conserva solo quello che può essere utile, o vantaggioso, per il praticante, e soprattutto socialmente corretto. Il più delle volte quello che arriva è mosso solo da un interesse privato ed egoistico dello stare meglio in salute, tralasciando invece millenni di trattazioni teologiche dei mistici Indiani. Egualmente la pratica della urino terapia, ovvero di bere dell’urina, è sì presente nei testi del tantrismo Sivaita e anche buddista, ma in tutt’altra forma da come di consueto viene presentata. Vi è da dire che i testi che ne parlano erano riservati a caste sacerdotali o altrimenti ad adepti di scuole mistiche e segrete, pertanto non erano assolutamente pratiche destinate alla diffusione popolare. Per “terapia” poi non si intende certo la cura delle malattie o il miglioramento della propria salute, ma la cura dell’unica e della sola malattia: l’ignoranza. In questo senso la pratica era compendio, assieme ad altre, per giungere all’Assoluto. Al solito in occidente ci si è fermati al solo aspetto fisico e deformato di simili pratiche e si è escluso tutto l’aspetto cerimoniale, liturgico, e psicologico che assumeva in passato. Senza contare che la pratica non era assolutamente fine a sé stessa ma accompagnata sempre da un percorso di disciplina e di trascesi che chiamava a sé soltanto un numero ristrettissimo di persone che decidevano di compiere un percorso monacale.
Il disgusto volontario
Nell’Hevajra-tantra al capitolo cinque si indica che lo yogin: “Non dovrebbe attaccarsi per nulla alle nozioni di piacevole e non piacevole. Il praticante del mantra non dovrebbe concepire il pensiero di ciò che è mangiabile e non mangiabile, così come di bevibile e non bevibile”. Più avanti nel capitolo undici è scritto che il discepolo deve cibarsi di cinque sostanze dette cinque ambrosie: escrementi, sangue, sperma, chimo e urina. “Ugualmente, per conseguire la realizzazione nello yoga, dovrebbe consumare i cinque nettari” La pratica è vista come una necessaria prassi per giungere all’eguaglianza di tutti i fenomeni, declamata tanto dallo Sivaismo che dal buddismo. Si legge ancora: “Tutte le cose, inferiori o inferiori, sono considerate uguali da coloro che meditano sulla vera realtà. (…) coloro che meditano sulla vera realtà e gustano l’identico sapore accettano egualmente ogni cosa in quanto identica”.
Si capisce in questo caso che lo yogin doveva raggiungere uno stato di superamento delle consuete categorie di puro e impuro attraverso una pratica che gli avesse volontariamente suscitato del disgusto o del disagio. Nel Pusapata Sutra, fra i più antichi dello Sivaismo Khasmiro, si insiste sulla necessità che l’adepto si comporti volutamente in modo da essere dagli altri disistimato, vilipeso, insultato e deriso. “Disprezzato infatti il saggio raggiunge la perfezione dell’ascesi” si legge. Il medesimo concetto verrà poi ripreso nel Kularnava Tantra della scuola Sivaita del Kula, quando si dice, capitolo 9.73, che: “Questi yogi vivono in maniera che gli uomini del mondo possano ridere di loro e nel vederli provare disgusto, insultarli e passare lontano”
D’altra parte fu il grande mistico Somananda ad affermare che: “Śiva risplende anche nel dolore” Sono pratiche che in occidente verranno riprese dalla mistica cristiana medioevale. Ad esempio in S. Maria Margherita di Alacoque, Santa, com’è noto, che fu l’iniziatrice del culto del Sacro Cuore di Gesù. Ella, per fugare le tentazioni, si infliggeva penitenze sempre più atroci. Si legge nel suo Diario (pubblicato nel 1915 con una prefazione del papa dell’epoca, Benedetto XV, che additava in Margherita «un modello per tutti i cristiani») che, trovandosi ad assistere una donna malata di dissenteria e provando un senso di disgusto, s’impose d’inghiottirne le urine per compiacere a Dio.
Nel capitolo 8 del Guhyasamaja-tantra c’è un versetto in cui si afferma che lo yogi dovrebbe spalmarsi di feci e urina di una ragazza in segno di adorazione e sottomissione verso il trascendente. Ciò è tipico delle tecniche tantriche del provocarsi volontariamente del disgusto in segno di devozione verso l’Assoluto e comunque di mortificazione dell’ego per scopi spirituali.
“colui che desidera il frutto del siddhi (il potere spirituale) dovrebbe fare degli escrementi e dell’urina il suo cibo, raggiungerà così la verità più alta”. Guhyasamaja-tantra 6.19/25 Il monaco buddista Nagarjuna, patriarca delle scuole Mahāyāna, scrive a proposito della pratica del Panchakarma (purificazione) che l’adepto deve trascendere la dualità e immaginare: “sé stesso come un nemico/ una madre come una prostituta/ come l’urina, così il vino/ come il cibo, così gli escrementi/ come odore dolce il puzzo/ come parole di lode gli insulti/ come piacere il dolore e così via”.
Vi è da dire che i concetti di puro e impuro sono spesso e volentieri sovvertiti anche dal punto di vista linguistico nei testi religiosi indiani. Così non è mai l’azione in sé ad essere impura, ma soltanto l’intenzione di chi la compie. Puro è ciò che viene prodotto da un essere puro, e impuro ciò che viene prodotto da un essere impuro. Ad esempio la vacca è un animale sacro per l’induismo e tutti i prodotti della mucca come lo sterco, l’urina e la polvere sollevata dagli zoccoli sono considerati agenti purificatori e medicinali nella medicina ayurvedica. Il testo indiano Bahagavad Gita, in alcuni passi (3-10) relativi alla vacca santa, la “grande madre” accenna all’utilizzazione, tra l’altro, della sua urina fini purificatori e terapeutici. Allo stesso modo negli inni del RgVeda I.43.4; II.35.7 e VII.35.6, Siva è definito jalasa-bhesaja ovvero colui la quale urina è medicina. Il concetto è ripreso poi anche nell’AtharvaVeda; II.27.6, dove Rudra (Siva) è evocato come: “Oh Rudra, il cui farmaco è l’urina”. In altri passi dei Veda Samhita l’urina è accostata al Soma tanto da far supporre ad alcuni studiosi che in essa potesse identificarsi la leggendaria amrita, la bevanda dell’immortalità, l’acqua della vita eterna. Evidentemente ciò che viene prodotto da ciò che è Sacro è sacro a sua volta. Nello Jnanarnava-tantra 22.30-32 si recita: “Come possono gli escrementi e l’urina essere impuri? Il corpo per mezzo del quale si può ottenere il Supremo è prodotto dal sangue mestruale e dallo sperma, perciò come può essere impuro?” Ancora nel Kaulajnananirnaya-tantra 11.11 Bhairava dice alla Devi: ‘‘Nei testi kaula cinque sostanze miscelate sono dette eternamente pure: gli escrementi, le secrezioni sessuali femminili, lo sperma, il sangue mestruale e il muco”.
L’adorazione della donna
Un’altra delle motivazioni della pratica del bere l’urina, e di tutt’altro ordine, è l’adorazione, portata all’estremo, del principio cosmico femminile rappresentato dalla donna, che, in quanto donna, incarna la Devi, la Shakti, frutto non solo di adorazione, ma anche di sottomissione a Essa. Piena di connotati trascendentali questa prospettiva di sottomissione e adorazione del principio femminile comprendeva la messa in gioco della potenza, anche distruttrice, della Dea. La donna, selezionata e purificata appositamente per il rito, diventava una Ḍākinī, consorte divina. Inghiottire la secrezione della Dea, la sua urina, era un rituale di Teofagia, ovvero del fare entrare dentro sé stessi la divinità. Pertanto nel rito iniziatico una ragazza si identifica con la Dea e nella sua urina si connatura la sua stessa divinità che l’adepto fa entrare dentro il suo corpo. Nel Candamaharosana-tantra si afferma che  nel corso della cerimonia di iniziazione (karmamudra) l’adepto (sadhaka) deve consumare l’urina e gli escrementi della donna e di praticare la devozione (bhakti) per le donne fino all’illuminazione. Ciò nel buddismo tantrico della scuola Vajrayana.
nel corso della cerimonia di iniziazione (karmamudra) l’adepto (sadhaka) deve consumare l’urina e gli escrementi della donna e di praticare la devozione (bhakti) per le donne fino all’illuminazione. Ciò nel buddismo tantrico della scuola Vajrayana.
L’adorazione della donna è così totale da identificarla con ogni donna, poiché il principio divino femminile abbraccia tutte le forme, e la sua adorazione implica una fusione totale (samaya), come si legge: “Tu sei mio figlio e mio marito, sei mio fratello e mio padre. Io sono tua madre, moglie, sorella e nipote. Per sette generazioni sei stato il mio schiavo, il mio umile servitore, ti ho comprato con conchiglie di ciprea; io sono chiamata la tua padrona.” Fino a giungere all’accettazione e assimilazione totale del suo corpo e del suo prodotto: “Puoi tu sopportare di mangiare la mia sporcizia, le mie feci e la mia urina? -Perché non dovrei oh madre? Io devo praticare la devozione della donna fino all’illuminazione”. Candamaharosana-tantra III-12 Innumerevoli sono i richiami all’adorazione della donna come Shakti anche nel Kulārṇava Tantra dove si insiste nella necessità dell’adepto di adorare la donna come Dea, offrendole doni, incensi, fiori, e anche mangiare i suoi avanzi, bere dalla sua bocca ecc. Dice Siva al versetto 107 del capitolo 8: “Senza il nettare che trasuda dalla yoni (vagina) e dal Lingam (pene) io non sono soddisfatto nemmeno da migliaia di calici di vino”.
L’animismo dei Tantra
Il fatto che il prodotto di un’anima pura sia anch’esso puro, ivi comprese le sue secrezioni, e che le virtù di un essere si estrinsechino nei suoi umori, è un concetto tipico dell’animismo. Una visione che non è solamente propria del mondo orientale ma che si sviluppa anche in altre religioni e mitologie. Un esempio di animismo nel politeismo è il mito di Cassandra. Questa riceve il dono della veggenza da Apollo facendosi sputare in bocca. In questa immagine c’è tutto il simbolismo animista poiché le virtù di Apollo e i suoi poteri si identificavano nella sua secrezione salivare. Maometto sputò nella bocca di suo nipote Ha-san alla sua nascita. In modo simile, nell’antica Babilonia, il sacerdote o l’esorcista acquistava i suoi poteri durante la consacrazione ricevendo lo sputo altrui, simbolicamente lo sputo del Dio, in bocca. Alla stessa stregua era animista l’usanza rituale greco-romana di bere l’urina delle vergini per cacciare il male poiché la purezza della fanciulla si trasmetteva nella sua stessa secrezione. È da sottolineare che l’urina, in alcuni riti, era una bevanda rituale che metteva in contatto l’adepto con lo spirito, tramite il principio del fuoco. Ur, in caldeo, significa appunto fuoco. Per gli alchimisti l’acqua permanens, elemento indispensabile alla trasmutazione dei metalli nella grande Opera, era identificata con l’urina dei fanciulli. Nel Vangelo dell’infanzia di Gesù si racconta come l’acqua che era servita alla madre per lavare il piccolo Gesù ed i suoi panni sporchi, se bevuta dai fedeli poteva fare miracoli, guarire dalla lebbra, allontanare i demoni, offrendo con questo un ennesimo esempio di come le virtù dell’anima si trasmettano attraverso i liquidi e gli umori.
L’umore era al tempo, per il greco antico, sia lo stato dell’animo, sia la secrezione del corpo. La saliva, il flemma, la bile e l’urina erano pertanto condizioni dell’anima, non semplici escrezioni. Chi dunque sugge il flemma, la saliva di una donna o la sua urina, traendone piaceri infiniti, riscoprendo in essa la sua anima, è di fatto, per certe scuole esoteriche, non un perverso, ma un iniziato ad una più alta visione del mondo. L’urina da bere è quella della Devi, la Dea Madre, incarnata nella donna amata, e attraverso questa identificazione della donna con la Dea, assimilare tramite il suo miele il Principio della Shakti stessa, inglobarlo in sé, poiché il frutto del corpo è divino e, come recitano i Tantra: “il corpo è il Tempio di Siva”. (Kulārṇava Tantra IX.41)
Emanuele Franz
Bibliografia di riferimento:
– Kularnava Tantra. La via dell’estasi. Edizioni Vidyananda 2005
– Testi dello Sivaismo. (Pasupata Sutra; Siva Sutra; Spanda Karika)
a cura di Raniero Gnoli. Editore Boringhieri 1962
– RgVeda. Le strofe della sapienza. A cura di Saverio Sani. Marsilio Editore 2000
– AtharvaVeda. Il veda delle formule magiche. A cura di Paolo Rossi. Mimesis 1994
– The Rig-Veda, a cura di Ralph T.H. Griffith; Evinity Publishing 2009
– Hevajra Tantra. Il risveglio di Vajragarbha. Ubaldini Editore 2004
– Cattive tradizioni. Estratti dalla Via della mano sinistra. I testi più trasgressivi della tradizione
tantrica. A cura di F. Zanello; Coniglio Editore 2008
– Il Fenomeno Tantrico di Davide Tomba. 2017 https://archive.org
– Candamaharosana tantra a cura di Christopher Starr George; University of Pennsilvania 1971
– Making Sense of Tantric Buddhism; di Christian K. Wedemeyer; Columbia University Press 2013
– La Tradizione Ermetica, di Julius Evola; Edizioni Mediterranee 1971
– A Critical Study of the Guhyasamaja tantra, di Francesca Fremantle;
University of London Library 1983
– Vijnana bhairava tantra; Edizioni Adelphi 1989
– Bahagavad Gita; Edizioni Adelphi 1976



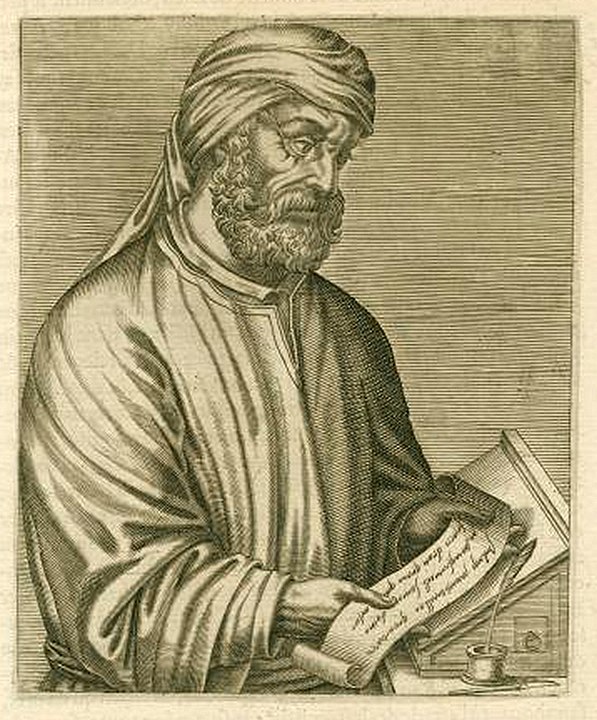


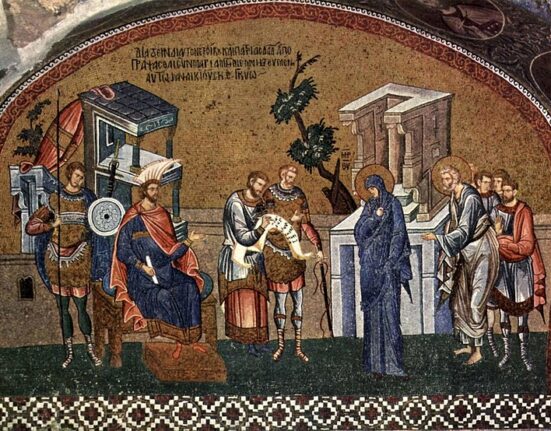

2 Comments