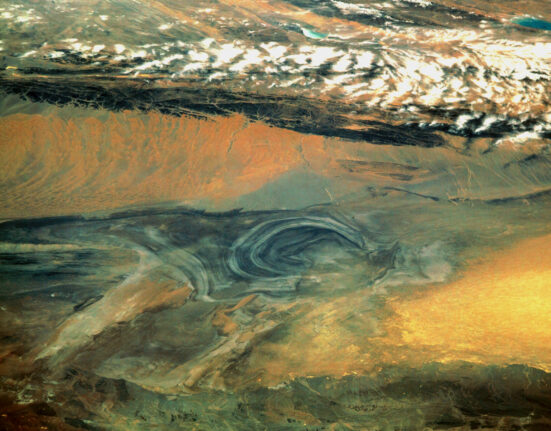Giorgio de Santillana e Hertha von Dechend sono noti al grande pubblico per essere gli autori de, Il mulino di Amleto. Saggio sul mito e la struttura del tempo (Adelphi, 1983). Un libro imprescindibile che cambiò, alla sua uscita, il modo di guardare al mondo antico e, più in particolare, al pensiero arcaico. La sagace azione intellettuale ed esegetica esercitata sui testi antichi dai due studiosi, è destrutturante delle false certezze sulle quali la ratio moderna ha costruito il suo arrogante dominio: il logos, infatti, per i due pensatori, non è affatto contrapposto al mythos, anzi, si è sviluppato dal suo humus. A confermare tale tesi, con una documentazione assai ampia, è la recente pubblicazione di un volume, finora inedito in Italia, di de Santillana e Von Dechend, Sirio. Tre seminari sulla cosmologia arcaica, nelle librerie per i tipi di Adelphi (pp. 171, euro 13,00). Il libro è curato da Svevo D’Onofrio e Mauro Sellitto. A quest’ultimo si deve il saggio, La scienza prima del mito (e dopo), che chiude l’opera.  Hertha von Dechend nacque, poco dopo l’esplosione della Prima guerra mondiale, nel 1915, ad Heidelberg. Nel 1934 ottenne, con difficoltà, a causa della sua opposizione al nazismo, il diploma ginnasiale e, nel 1936, risultò tra gli immatricolati dell’Università di Francoforte. Intelletto dagli interessi disparati, fu, tra le altre cose, una virtuosa del violino, pose comunque al centro delle sue ricerche il mito. Nel 1940 fu a Parigi, in qualità di addetto stampa della Luftwaffe. Entrò in contatto con i membri del museo antropologico de l’Homme, vicini ai gruppi della Resistenza francese. Dal 1941 frequentò a Francoforte l’Istituto Frobenius e si dedicò ad approfondire la straordinaria figura dello scienziato Justus von Liebig, di cui Walter Benjamin tracciò un ritratto esemplare in Uomini tedeschi, includendolo tra quegli uomini di scienza nella cui visione delle cose mito e poesia ancora: «aleggiavano come fantasmi nella nebbia» (p. 156).
Hertha von Dechend nacque, poco dopo l’esplosione della Prima guerra mondiale, nel 1915, ad Heidelberg. Nel 1934 ottenne, con difficoltà, a causa della sua opposizione al nazismo, il diploma ginnasiale e, nel 1936, risultò tra gli immatricolati dell’Università di Francoforte. Intelletto dagli interessi disparati, fu, tra le altre cose, una virtuosa del violino, pose comunque al centro delle sue ricerche il mito. Nel 1940 fu a Parigi, in qualità di addetto stampa della Luftwaffe. Entrò in contatto con i membri del museo antropologico de l’Homme, vicini ai gruppi della Resistenza francese. Dal 1941 frequentò a Francoforte l’Istituto Frobenius e si dedicò ad approfondire la straordinaria figura dello scienziato Justus von Liebig, di cui Walter Benjamin tracciò un ritratto esemplare in Uomini tedeschi, includendolo tra quegli uomini di scienza nella cui visione delle cose mito e poesia ancora: «aleggiavano come fantasmi nella nebbia» (p. 156).
Giorgio de Santilliana nacque a Roma nel 1900 e nella città eterna si laureò in Fisica: fu collaboratore di Federigo Enriques e con lui attivamente si prodigò per costituire una Scuola di Storia della Scienza. Dal 1941 si stabilì a Boston: qui lavorò al MIT, centro universitario connotato, in quel frangente, da: «un’atmosfera goliardica e quasi pervasa da un’aura presocratica altamente congeniale al (suo) spirito» (p. 158). Si dedicò così allo studio del pensiero filosofico-scientifico del Rinascimento e, in particolare, alla storia della scienza greca ed antica. Nel 1958 incontrò, per la prima volta, la Von Dechend ad un convegno francofortese. Tra i due nacque un sodalizio intellettuale assai intenso, fondato sui medesimi interessi di ricerca, che si evincono dalla lettura di Sirio. I tre saggi qui raccolti consentono al lettore, di entrare nell’officina teorica che preparò il loro scritto maggiore, Il mulino di Amleto.
Il primo di essi è di de Santillana, Sulle fonti dimenticate nella storia della scienza. Nelle sue pagine l’autore, sulla scorta dell’intuizione di Giordano Bruno, che disse essere l’antica filosofia egizia di fatto riducibile a visione astronomica e a cosmologia, e servendosi, inoltre, delle ricerche di uno studioso che la storiografica contemporanea ha di fatto silenziato, Charles-François Dupis, ribadisce la centralità della Precessione degli Equinozi nella nascita dei miti. Recupera, allo scopo, il ruolo svolto da Eudosso nella trasmissione in Grecia della sapienza egizia. Il secondo saggio della silloge fu scritto a due mani dai nostri autori. Dalla lettura emerge la centralità, al fine della comprensione dei legami vincolanti in cui erano stretti scienza arcaica e mito, di Sirio, la più luminosa delle stelle fisse che, per oltre tremila anni, si pensò, come attestano i racconti tradizionali delle più diverse civiltà, non fosse soggetta alla Precessione equinoziale.
Centro vitale del libro è il terzo scritto, Il concetto di simmetria nelle culture arcaiche, firmato dalla Von Dechend. La studiosa sostiene che, la cultura superiore arcaica, aveva quale fondamento intellettuale un «sistema di misure normate» nel quale lunghezza, capacità e peso, collegati tra loro, rappresentavano il corrispettivo delle misure «assolute» esistenti nella physis, in natura. Misura, come ben sapeva Pitagora, memore degli insegnamenti della scienza orientale, è numero. Tale insegnamento è presente ancora nel Timeo platonico. Ricorda, infatti, Plutarco, che l’azione demiurgica, fondata su numeri e proporzioni, mirava, agendo sulla materia primordiale, a circoscriverla con linee, superfici e profondità. Ciò rese l’originario indeterminato: «armonioso in tutte le sue parti, e limitato e mescolato in modo eccellente» (p. 93). La tendenza entropica continuò, nonostante tale intervento, ad animare la materia «regolata» numericamente. Gli stessi stoikeia, gli elementi, vennero così pensati, come mostrano, in modo emblematico, la tradizione greca e quella taoista, quali «processi fondamentali» in fieri.  Centrale, nel contesto di un cosmo pensato come numerus, pondus, mensura, risulta il concetto di Dike. Esso indica, al medesimo tempo: «il cammino della vita di ciascun essere naturale […] e anche il corso regolare […] dell’universo» (p. 95). Proprio per questo, il primo riferimento di misura per i popoli arcaici fu il corso del Sole, con le scansioni temporali che determina. I pianeti divennero, come colse Proclo, rappresentazione delle uniche cose reali, i numeri-misure. Non è casuale che la dea egizia Maat sia rappresentata con il cubito (o canna di misura) tra le mani e che Pthat, il «il Signore di Matt», venisse assimilato al pianeta Saturno, «Signore del periodo di Trenta anni». Per le ragioni ora indicate, nel pitagorismo emerse una valorizzazione del ruolo svolto dai nomi: «il nous aveva i numeri […] ma l’anima imitava il nous assegnando i nomi» (p. 99). I nomi quali immagini di forme puramente intellettuali. Tale visione cosmologica influenzava anche l’etica. In questo ambito, l’uomo avrebbe dovuto prodigarsi affinché l’Identico, cosmicamente manifestato dalle stelle fisse, diventasse il regolatore della propria anima e, conseguentemente, della propria presenza nel mondo. Un chiaro riferimento all’egemonikon della tradizione stoica. La lettura di questa silloge è ricca di altri spunti assai interessanti. Qui basti ribadire che la scienza antica parlava ancora il linguaggio immaginifico del mito, con il quale non era affatto in conflitto.
Centrale, nel contesto di un cosmo pensato come numerus, pondus, mensura, risulta il concetto di Dike. Esso indica, al medesimo tempo: «il cammino della vita di ciascun essere naturale […] e anche il corso regolare […] dell’universo» (p. 95). Proprio per questo, il primo riferimento di misura per i popoli arcaici fu il corso del Sole, con le scansioni temporali che determina. I pianeti divennero, come colse Proclo, rappresentazione delle uniche cose reali, i numeri-misure. Non è casuale che la dea egizia Maat sia rappresentata con il cubito (o canna di misura) tra le mani e che Pthat, il «il Signore di Matt», venisse assimilato al pianeta Saturno, «Signore del periodo di Trenta anni». Per le ragioni ora indicate, nel pitagorismo emerse una valorizzazione del ruolo svolto dai nomi: «il nous aveva i numeri […] ma l’anima imitava il nous assegnando i nomi» (p. 99). I nomi quali immagini di forme puramente intellettuali. Tale visione cosmologica influenzava anche l’etica. In questo ambito, l’uomo avrebbe dovuto prodigarsi affinché l’Identico, cosmicamente manifestato dalle stelle fisse, diventasse il regolatore della propria anima e, conseguentemente, della propria presenza nel mondo. Un chiaro riferimento all’egemonikon della tradizione stoica. La lettura di questa silloge è ricca di altri spunti assai interessanti. Qui basti ribadire che la scienza antica parlava ancora il linguaggio immaginifico del mito, con il quale non era affatto in conflitto.
Giovanni Sessa