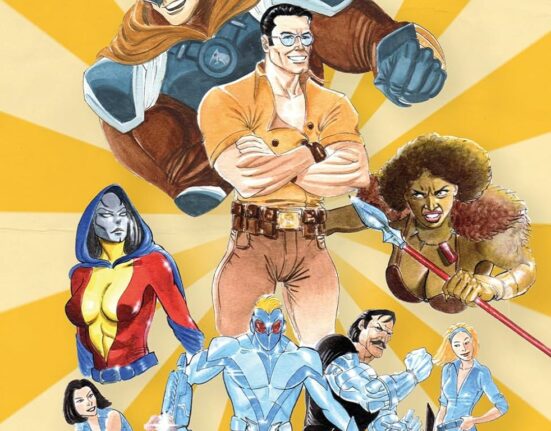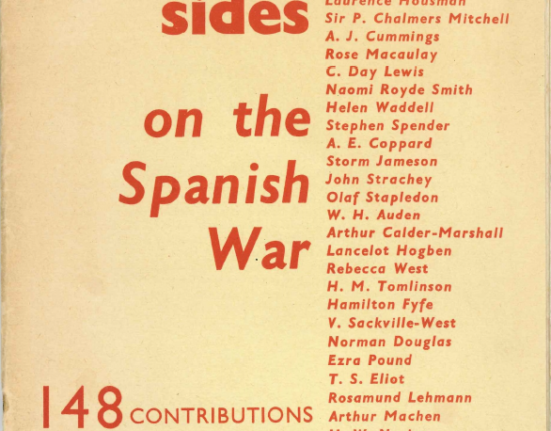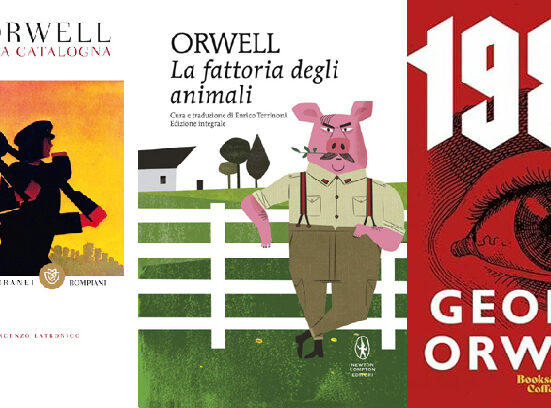Come era probabilmente ovvio che fosse, anche questa serie di articoli (vogliamo dire “rubrica”?) che sto tenendo in piedi da anni sulle pagine di “Ereticamente”, ha subito nel tempo importanti cambiamenti di impostazione e tematiche. Iniziata e proseguita fino alla diciannovesima parte come un esame della letteratura fantastica per generi, dalla ventesima in poi, si è proposta una finalità diversa.
Ora, io vorrei osservare che il lavoro che ho fatto non è una semplice catalogazione, ma risponde ad alcune precise scelte ideologiche che forse qualcuno può trovare discutibili, ad esempio ho dato poco spazio alla fantascienza “classica”, che ho trattato nella terza parte in condominio con la narrativa di horror, e ho incluso la futurologia fra i generi letterari fantastici (fosse o meno, anzi con tutta probabilità non era, questa l’intenzione degli autori che si sono cimentati in questo campo).
Il motivo di queste scelte è semplice: io non credo nel mito del progresso, che è forse una delle più tenaci illusioni dell’uomo contemporaneo, ma adesso vorrei evitare di ripetere un discorso che ho già svolto parecchie volte su queste pagine, tranne forse evidenziare il fatto che I limiti dello sviluppo di cui parlava il Club di Roma nel 1970 (oltre mezzo secolo fa) sono stati raggiunti da un pezzo. Oggi si parla molto di sviluppo sostenibile, che è come dire acqua asciutta.
Dalla ventesima alla ventiquattresima parte, vi ho presentato in pratica una monografia sul fantastico di matrice tedesca, e questo per un motivo non solo preciso, ma politicamente rilevante: mi premeva dimostrarvi che la preminenza oggi assunta a livello mondiale dal fantastico di lingua inglese, dalla fantascienza alla fantasy (quest’ultima da Tolkien alla Rowlings) non dipende dal fatto che gli anglosassoni siano più inclinati di altri per questo genere di narrativa, ma unicamente dal predominio politico assunto a livello planetario da una potenza di lingua inglese, gli Stati Uniti d’America, e che altri avevano forse maggiori potenzialità che sono rimaste soffocate.
Si tratta però di un discorso che non riguarda solo la Germania, ma anche il nostro mondo latino, ma prima di addentrarci nel nostro argomento, c’è una questione alla quale vorrei dare una risposta: e il fantastico dei Paesi dell’est, del mondo slavo, Russia compresa, non hanno anch’essi una tradizione fantascientifica notevole, con qualche autore che è riuscito a “sfondare il muro” del predominio anglosassone, come il polacco Stanislaw Lem?
Vi racconterò un episodio che mi ha riguardato personalmente, e poi giudicate voi. Nel 1969, “Foundation”, prestigiosa rivista britannica, tramite Gianfranco Viviani, allora non solo editore delle Edizioni Nord, ma presidente della sezione italiana della World SF (l’associazione che riunisce i professionisti della fantascienza), richiese un articolo sulla fantascienza italiana. Io lo stesi e fu accettato. Qualche tempo dopo, sempre tramite la WSF Italia, la rivista polacca “Fantaztyka” mi richiese di pubblicare l’articolo sulle sue pagine, cosa che non ebbi difficoltà a concedere.
Quando ebbi modo di vedere il mio articolo tradotto in polacco e pubblicato, rimasi parecchio stupito, (io non conosco il polacco, ma dato che conoscevo bene il contenuto dell’articolo, riuscii a esaminarlo senza troppe difficoltà), “fantascienza” era stato tradotto come “fantaztyka literatura”, ebbi l’occasione di parlarne con Viviani che mi confermò che proprio quello era il termine corrente per fantascienza nei Paesi dell’est. Gli chiesi allora come veniva chiamato il fantastico non fantascientifico, fantasy e horror oltre la Cortina di Ferro, e la sua risposta mi lasciò basito: all’est quel genere di fantastico non esisteva, non era ammesso, era proibito, non solo non c’era una produzione locale, ma gli autori occidentali erano banditi. Né Conan né Dracula trovavano spazio sotto la bandiera rossa.
Che dire? Il comunismo è stato una cappa plumbea che ha soffocato non solo la libertà d’espressione, ma anche la fantasia e la creatività.
Oggi, lo sappiamo, la Cina sta imitando tutto quello che è occidentale, nella speranza di surclassarci, dai grattacieli ultramoderni che restano perlopiù disabitati perché la gente continua a preferire le abitazioni tradizionali, ai lanci spaziali, e non poteva mancare neppure una fantascienza cinese, ma quel che si è visto finora non mi sembra molto incoraggiate. Il caposcuola della fantascienza cinese sembra essere Cixin Liu, il cui romanzo, Il problema dei tre corpi ha avuto una grossa e probabilmente immeritata promozione pubblicitaria anche da noi. A me è sembrato un testo farraginoso, di lettura non certo agevole.
Ma, vi dicevo, parliamo del fantastico latino che oltre all’Italia riguarda Francia, Penisola Iberica e America Latina, a proposito della quale non si può non fare subito il nome del grande, grandissimo Jorge Luis Borges. (Io però ora, se mi permettete, non tornerò sul grande autore argentino, cui ho già dedicato la diciottesima parte di questa trattazione).
Però, sorge subito un problema di metodo: se andiamo a prendere ad esempio un volume come Maestri della letteratura fantastica a cura di Edy Minguzzi (Edipem 1983), troviamo nominati i seguenti autori fantastici italiani: Dante Alighieri, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Collodi, Gabriele D’Annunzio, Dino Buzzati. Si tratta di personaggi notissimi della nostra letteratura di cui non ha molto senso fare qui un’esposizione (tranne forse Dino Buzzati o Collodi, da sempre relegato nel dominio della letteratura infantile, mentre secondo alcuni, il suo Pinocchio avrebbe significati più profondi, anche esoterici, illustrando il difficile percorso per diventare “persone vere”). E non consideriamo poi il fatto che a padre Dante ho appena dedicato due articoli (Un druido di nome Dante Alighieri, prima e seconda parte).
Nel 1978 la casa editrice Garzanti pubblicò Universo e dintorni, un’antologia a cura di Inisero Cremaschi che in un certo senso poneva fine a un decennio nel quale la fantascienza italiana era stata piuttosto latitante.
Questa antologia aveva diversi meriti, a cominciare da quello di presentare sullo stesso piano autori già affermati come Roberto Vacca e Gilda Musa (autrice della sceneggiatura del telefilm RAI La traccia verde) assieme ad autori allora esordienti (tra cui il sottoscritto).
Il racconto di Gilda Musa Visto dall’alto, visto da lontano fu all’origine di un caso piuttosto curioso.
Gilda Musa ha raccontato che il racconto le sarebbe stato ispirato dalla visione di “un bellissimo volto di donna, apparso per pochi secondi scolpito sulla superficie marziana, durante l’atterraggio sul Pianeta Rosso della sonda Viking 1 il 20 giugno 1976. Questo ha dato luogo a discussioni che sono durate anni e ogni tanto rispuntano, perché questo “bellissimo volto di donna”, a parte la Musa, nessuno l’ha mai visto, a meno che l’autrice non intendesse riferirsi alla celebre e discussa “sfinge marziana” di Cydonia, ma ci vorrebbe una fantasia davvero sfrenata per vedervi “un bellissimo volto di donna”.

Tuttavia, la cosa più notevole dell’antologia non è probabilmente questa, ma l’introduzione di Inisero Cremaschi, in cui lo stesso è riuscito con una buona dose di dialettica a presentare la fantascienza nostrana come direttamente nascente dal tronco del fantastico italiano, escludendo qualsiasi apporto degli USA e della fantascienza americana su quella di casa nostra. E’ un discorso esagerato perché gli scrittori di fantascienza americani hanno avuto sui nostri autori un’influenza almeno pari a quella dei classici della letteratura, ma era un’esagerazione che perlomeno controbilanciava quella di chi ha voluto vedere nella fantascienza italiana un fenomeno piattamente imitativo, fra questi Carlo Fruttero e Franco Lucentini, che finché sono stati curatori di “Urania”, l’hanno tenuta decisamente chiusa agli autori italiani (ma Fruttero si autopubblicava con lo pseudonimo di Apfelbaum) e la critica e traduttrice Roberta Rambelli (che però pubblicava di nascosto con lo pseudonimo di Robert Rainbell), ma soprattutto è una testimonianza dello spirito vivacemente antiamericano di Cremaschi, che da comunista vecchia maniera, detestava tutto ciò che fosse yankee.
L’antiamericanismo è proprio uno dei pochi, pochissimi lati positivi che possiamo riconoscere al comunismo dei tempi che furono, ed è proprio una di quelle cose di cui la sinistra di oggi si è del tutto sbarazzata, ha buttato via il bambino assieme all’acqua sporca, anche se si trattava di un bambino particolarmente gracile e malaticcio.
C’è sempre qualcuno che crede di poter speculare sul fanatismo della gente, che poi talvolta, ma non sempre, si rivela meno stupida di quel che costoro avevano creduto. Proprio in quel periodo, l’ho ricordato nelle parti della notta “rilettura” dedicata alla critica, eravamo verso la fine degli anni ’70 del XX secolo, per chi non l’ha vissuto, un periodo molto “caldo” e violento, il giornalista Remo Guerrini pubblicò un articolo su Fantascienza e politica sulla rivista “Robot” dell’editore Armenia diretta da Vittorio Curtoni, che conteneva un attacco contro Gianfranco De Turris e Sebastiano Fusco, che erano allora curatori delle edizioni Fanucci, e nulla avevano fatto per meritarselo.
L’accusa di fascismo fa parte, per così dire, del repertorio standard dei “compagni” verso chiunque non la pensi come loro, si sono inventati pure l’ossimorico termine di fascio-leghisti, ma a quei tempi, usarla significava additare qualcuno alla violenza dei “compagni” più estremisti, o addirittura metterlo nel mirino delle Brigate Rosse.
Il clamore suscitato dall’articolo convinse Armenia e Curtoni che buttandosi sull’estremismo di sinistra avrebbero incentivato le vendite e le tirature, ma il risultato fu esattamente opposto: provocarono una disaffezione dei lettori che pose fine a quello che fin allora era stato uno dei più interessanti esperimenti della fantascienza italiana.
Una decina di anni or sono, in un clima fortunatamente molto più svelenito, la webzine “Continuum” fece il tentativo di riprendere il discorso su fantascienza e politica, in un numero che intendeva presentare sia il punto di vista “di destra” che quello “di sinistra”. A rappresentare “la sinistra” era Vittorio Catani (da non confondere assolutamente con Curtoni), e a rappresentare “la destra”, ovviamente ero io. Non ne nacque alcuna frizione, ma bisogna dire che Vittorio Catani, recentemente scomparso, a prescindere dalle idee, oltre che un eccellente scrittore e saggista, era un autentico gentiluomo.
Torniamo all’introduzione di Cremaschi. Come curiosità, si può citare il fatto che l’ultimo della lunga fila di precursori che cita, di opere ed autori che da Dante in poi, avrebbero accompagnato la lunga gestazione della fantascienza italiana, o il suo germogliare sul tronco del fantastico italiano, è Il paese senza sole di Giorgio Scerbanenco. Io non posso dire di conoscere a fondo Scerbanenco, ma mi pare che fosse soprattutto un giallista. Molti anni fa lessi un suo romanzo, Ladro contro assassino, pubblicato a puntate su “La Domenica del Corriere”, lo trovai ben scritto e piacevole, ma, in tutta sincerità, non è che la narrativa gialla sia la mia preferita.
In ogni caso, è innegabile che, se non proprio una scuola, è esistito un interessante gruppo di autori fantastici italiani pre-fantascientifici del novecento: accanto a quello di Dino Buzzati, si possono fare i nomi di Italo Calvino, di Giovanni Arpino, e soprattutto del grandemente sottovalutato Tommaso Landolfi, per non parlare di Italo Svevo e della “fantascientifica” conclusione de La coscienza di Zeno, che si chiude preconizzando l’apocalisse nucleare, cosa tanto più notevole se pensiamo che lo scrittore triestino è morto nel 1928.
Dino Buzzati, bellunese, nato nel 1906, morto nel 1972, è stato scrittore, giornalista, pittore (ricordiamo tra l’altro un suo romanzo, L’invasione degli orsi in Sicilia, un suo romanzo da lui stesso illustrato con una serie di vignette che ne fanno una sorta di fumetto), è stato autore di un gran numero di romanzi di tematica prevalentemente fantastica, il più noto dei quali, considerato il suo capolavoro, è con ogni probabilità Il deserto dei tartari. Qualcuno l’ha considerato il Kafka italiano. Finché era in vita, è stato considerato una figura anomala nel panorama letterario italiano, gli è stato rimproverato di essere “poco italiano”, di non presentare traccia di quella “solarità mediterranea” che ci dovrebbe caratterizzare.
Lo stesso tipo di critiche è stato rivolto a un autore di fantascienza che a me sembra, con Buzzati avesse delle affinità, il trentino Riccardo Leveghi, nato nel 1941, morto nel 1985, con in più un’aggravante. Leveghi non ha mai nascosto le sue convinzioni di destra. Ricordo che presentando un suo racconto in un’antologia, il curatore (mi pare fosse l’ex partigiano Lino Aldani, ma non posso giurarci), si premurava di scusarsi di dette convinzioni e di assicurare che nel racconto non ne traspariva traccia, tanto per capire cosa significa opporsi all’egemonia gramsciana che la sinistra ha imposto in ogni ambito culturale.
Simili problemi non li ha certamente avuti Italo Calvino (1923 – 1985), uomo notoriamente di sinistra ed ex partigiano, scrittore di una grande varietà di tematiche fra le quali si possono riconoscere alcune di carattere fantastico: la trilogia I nostri antenati (Il barone rampante, Il visconte dimezzato, Il cavaliere inesistente) e il romanzo Le città invisibili. Al contrario, direi, proprio perché di sinistra la sua opera è stata oggetto di una sproporzionata sopravvalutazione.
Di Giovanni Arpino (1927 – 1987), noto soprattutto per il romanzo La suora giovane e per la raccolta di racconti La babbuina, mi pare sia sopravvalutata soprattutto la componente fantastica, ragion per cui lascerei perdere.
Di sicuro maggiormente fantastico è stato Tommaso Landolfi (1908 – 1979), poco noto al grosso pubblico e autore di inquietanti storie a cavallo tra il surrealismo e l’esistenzialismo, di cui si possono ricordare La pietra lunare, Il principe infelice, Il mar delle blatte, Le labrene.
Resterebbero, impresa quasi impossibile, da raccontare nel dettaglio la storia della fantascienza italiana, e quella del fantastico francofono, iberico e latino-americano, ma per ora rimandiamo.
NOTA: Nell’illustrazione, un panorama fantascientifico.