La figura di Ulisse offre a Dante il pretesto per intavolare un importante discorso morale sulla sete di Conoscenza. Già trattato nel Canto XX dell’Inferno dedicato agli indovini il peccato intellettuale coinvolge in prima persona il poeta, che infligge una pena lieve ai fraudolenti che mal consigliarono quanti si affidavano al loro ingegno.
Le anime confinate nell’VIII Bolgia dell’VIII Cerchio non soffrono, né si lamentano. Ridotte a vagare nell’aria infernale come uno sciame di lucciole sotto forma di biforcute fiamme mobili, cioè di puro spirito, esse non vedono né possono essere viste. In compenso, parlano.
Brilla nel nugolo delle brillanti luci l’intrepido Ulisse, dal quale Dante prende subito le distanze filosofando sulla sete di Conoscenza che non è tutta uguale, essendoci modo e modo di praticarla. Tanto per fare un esempio lui è un buon cristiano che viaggia dietro autorizzazione divina, cercando di stare al suo posto, mentre il re di Itaca è un pagano che esaltò la curiosità umana senza limiti, infischiandosene degli dèi.
Per Dante la sete di Conoscenza non vale da sé qualsiasi prezzo, va preso dunque con cautela il famoso passo: “Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza” (If XXVI 118-120). Essendo lui per primo un «peccatore intellettuale» il poeta non può condannare in toto la Conoscenza, che vincola però alla Virtù senza la quale si disperde ogni bene concesso dalla Grazia divina. “Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio / quando drizzo la mente a ciò ch’io vidi, / e più lo ’ngegno affreno ch’i’ non soglio, / perché non corra che virtù nol guidi; / sì che, se stella bona o miglior cosa / m’ha dato ’l ben, ch’io stessi nol m’invidi” (If XXVI 19-24).
Davanti a Ulisse e Diomede, avvolti nella stessa fiamma poiché insieme ordirono l’inganno di Troia e parteciparono al furto sacrilego del Palladio, il poeta arretra con rispetto. Manda avanti il Maestro, al quale fa dire: parlo io, tu pensa a tenere a freno la lingua (ma fa che la tua lingua si sostegna). Anche Virgilio però è parte in causa, prova ne è la disinvoltura con cui ricorre al proprio ingegno per circuire l’interlocutore e farlo parlare.
Sfruttando la condizione d’«invisibilità» egli si rivolge ai due tirando in ballo presunti meriti acquisiti nei loro confronti. Non è chiaro in quale lingua stia parlando (in greco?), né dove voglia arrivare il suo discorso, dal momento che nell’Eneide la coppia è citata solo di sfuggita.
Alcuni dantisti hanno insinuato che il mantovano in questo frangente si spacci per Omero allo scopo di estorcere ai penitenti le informazioni che interessano al suo pupillo. La subdola mossa deriverebbe da certe dicerie medioevali sul pessimo carattere degli antichi Greci, il cui pelo andava opportunamente lisciato prima di instaurare qualsiasi trattativa.
In particolare Dante vuole sapere tramite Virgilio dov’è stato il re di Itaca in quel lungo viaggio senza ritorno, e perché ha fatto perdere le sue tracce. Con in tasca la vittoria su Troia e reduce da una lunga guerra, non sarebbe stato più saggio tornare a casa? Inaspettatamente, l’interpellato risponde. Il tono della sua voce è pacato. Nulla trapela del filibustiere di un tempo, se si esclude l’arte con cui egli maneggia il potere delfico della parola.
L’eroe dice e non dice. Grosso modo si capisce che l’idea di tuffarsi nell’ignoto era maturata durante il soggiorno presso Circe, diventando poco alla volta una specie di ossessione. Né la tenerezza per il figlio, né la devozione per l’anziano padre, né i doveri verso Penelope riuscirono a vincere il desiderio irrefrenabile di conoscere il mondo insieme a tutte le virtù e i vizi degli uomini. Quindi, fece i bagagli e partì.
Non soltanto nell’Inferno ma anche nell’Odissea la storia di Ulisse ruota attorno a Circe. Allo stesso modo il perno del viaggio di Dante è Beatrice, che probabilmente non è mai esistita in quanto tale ma ben rappresenta il lato femminile dell’umana ragione. Può capitare che il ricorso a questa parte sia più frequente “nel mezzo del cammin” della vita, quando le paturnie aumentano e risorge dalle ceneri la fastidiosa domanda: e adesso, che si fa? Condurre una vita di pura sopravvivenza per poi scomparire nel nulla, o spingere lo Spirito oltre le apparenze? Stare fermi, o lanciarsi verso l’ignoto e «navigare a vista»?
Risponde Cicerone: errare per mare, cioè vivere in libertà, è sempre meglio di “regnare et Ithacae vivere otiose cum parentibus, cum uxore, cum filio” (De officiis, Paragrafo 97, Libro 3). Fu proprio per combattere l’ordinarietà del quotidiano, prima causa della morte spirituale dell’umano, che Ulisse partì alla ventura ben sapendo che la nave su cui cavalcava le onde poteva essere allo stesso tempo la sua bara e la sua Arca di Resurrezione, ossia lo scrigno che si sarebbe dischiuso al termine del viaggio per offrirgli un trono divino al posto del trono terreno che già possedeva.
Simbolo della ratio umana con tutti i suoi limiti, Circe è dunque il simbolo della «spinta materiale» necessaria all’eroe, come a chiunque altro, per passare dal pensiero all’azione. Non stupisce affatto trovare la sua mano dietro la dichiarata «follia» del volo di Ulisse, essendo arcinota l’incidenza statistica nel Poema dell’Uomo del Folle Consiglio di una donna.
Nel bene come nel male, funziona così: l’insorgere di un’idea esplode con la spavalderia del carattere maschile, ma la sua realizzazione richiede il senso pratico del lato femminile. Ulisse, ad esempio, sarebbe finito in fondo al mare senza le precauzioni suggerite da Circe per far fronte al canto delle Sirene.
Può darsi, tuttavia, che Dante non ne fosse al corrente. Il poeta apprende l’episodio attraverso la narrazione ovidiana (Met. XIV 254-319) cui fa esplicito riferimento, ma ignora i testi omerici e probabilmente non ne conosce nemmeno i tardi compendi medievali. Nel Purgatorio confonderà infatti la maga con una sirena, impantanandosi nell’improbabile figura di una donna-pesce in grado di elaborare filtri che trasformano gli uomini in bestie (Pg XIV 42).
Un ripensamento sarebbe opportuno anche a proposito della cattiva fama che ormai da secoli circonda la figura di Circe, e più in generale qualsiasi approccio femminile (irrazionale) alla realtà. Un pregiudizio che vede Dante in prima linea: “Quando mi diparti’ da Circe, che sottrasse / me più d’un anno …” (If XXVI 91-92). Ma se davvero la maliarda avesse «sottratto», cioè rapito, l’eroe per più d’un anno, a quale scopo allestire con ogni ben di dio la sua nave e farla salpare dall’isola? Perché fornirgli le coordinate necessarie a raggiungere l’Ade da vivo, in modo da consultare l’indovino Tiresia prima di decidere il da farsi?
C’è infine quella stonatura di fondo: Circe ne sa una più del diavolo però il fenomeno è lui, Ulisse, alias «Odisseo dai molti accorgimenti» (πολιμετις Οδυσσεύς, Iliade, III, 200), per usare uno degli epiteti più ricorrenti nell’epica omerica. Mentre Circe sta a Ulisse come Beatrice sta a Dante. In entrambi i casi il protagonista sarebbe andato gambe all’aria senza la «spalla». Altro che memorabile abbandono della vita terrena (il quotidiano) e accesso a una vita superiore (lo straordinario)!
Il proposito di portare rapidamente il nocchiero nell’orbita dell’emisfero australe confonde Dante. “Cinque volte racceso e tante casso / lo lume era di sotto da la luna, / poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo, /quando n’apparve una montagna, bruna / per la distanza, e parvemi alta tanto / quanto veduta non avea alcuna” (If XXVI 130-35).
Il motivo della fretta è presto detto: al Polo Sud c’è la montagna del Purgatorio, cioè il luogo di purificazione e redenzione dove il poeta, fosse stato per lui, avrebbe mandato volentieri Ulisse, non potendolo fare per ovvie ragioni di fede, moralità e convenienza politica. La vicinanza di Dante all’eroe emerge comunque dalla presenza di questi in tutti i regni della Commedia: qui all’Inferno lo avvolge in una fiamma biforcuta nella bolgia riservata agli astuti fraudolenti (If XXVI 55 ss.), nel Purgatorio indurrà la sirena che imbambolava i naviganti a rimembrare le sue gesta (Pg XIX 22-23), in Paradiso troverà il modo per tornare sulla folle impresa (Pd XXVII 83).
Nonostante il poeta non lesini i distinguo, è chiara la somiglianza del vagare di Ulisse per mare e per terra (simboli della materia) con il percorso «iniziatico» da lui intrapreso attraverso i tre regni (simboli dello spirito). Cambia la meta: il cammino del poeta conduce in Paradiso, il viaggio dell’eroe mira al ritrovamento di quella «Patria» che è in primo luogo «Origine», centro del mondo, e in quanto tale prossima al Sacro. A tale proposito Heidegger, nel suo studio su Hölderlin, immaginerà il ritorno verso l’Origine come un’impresa esistenziale sofferta ma necessaria, una continua lotta attraverso il mare in tempesta: “l’andare alla fonte è, in quanto navigazione, un conflitto” (Hölderlin. Viaggi in Grecia, 2012).
Inevitabilmente tempi e mentalità diverse differenziano la poetica di Omero da quella di Dante. Dopo il “folle volo” il primo riporta a casa Ulisse come un eroe, mentre il secondo scatena una tempesta punitiva che colpisce la nave a prua. Il gorgo fatale (del maelström?) fa girare l’imbarcazione su se stessa tre volte, succhiandola in un vortice. La quarta volta il vascello leva in alto la poppa e in prossimità della Montagna del Purgatorio la prua s’inabissa “com’altrui piacque” (v.141), cioè secondo il volere degli dèi, prima che il mare si chiuda come una lapide sopra il natante e il suo equipaggio.
Il rimaneggiamento dantesco del mitico viaggio fa dell’episodio una storia a parte, non soltanto estranea alla tradizione omerica ma addirittura a quella geografica, come si evince da quel “tutte le stelle” in posizione dominante nella terzina. Dalla bocca del vero Ulisse non sarebbe mai uscito niente del genere poiché innumerevoli volte cavalcando le onde il marinaio avrà visto il progressivo sparire delle stelle del «nostro polo» e il progressivo apparire delle “stelle de l’altro polo”.
Rappresentazione plastica del tipico «spirito fenicio», come si diceva nell’antichità per definire un uomo d’ingegno che non disdegnando l’astuzia fraudolenta era in grado di gestire spericolate imprese navali, il re di Itaca è un provetto pilota. Da perfetto uomo di terra Dante invece non sa che in un qualsiasi momento all’equatore non si vedono tutte le stelle di un polo bensì metà stelle sia dell’uno che dell’altro polo, per questo fa vedere all’eroe il «nostro» polo sotto l’orizzonte marino.
Passando l’equatore la visuale non cambia di colpo, è graduale, quasi si stenta ad accorgersene. Ma ciò non distolga l’attenzione del lettore dal nocciolo del discorso: il viaggio. Nulla a che vedere con gli odierni spostamenti di massa, nati a fini esclusivamente commerciali.
Il vero viaggio è un’esperienza unica che implica la spaesatezza, l’oblio, la dimenticanza del proprio essere originario. Contemplando talvolta, perché no, lo scivolamento nella dismisura in quanto l’essere umano è un’opera incompiuta, cioè una creatura fragile che senza il sostegno della rettitudine si rompe e va in mille pezzi.
Proprio per schivare le sabbie mobili generate dagli eccessi il Medioevo europeo pose il limite a fondamento della propria concezione antropologica, interpretando il confine non più come punto mediano tra forze contrarie (antichi greci) bensì come riconoscimento del posto che l’uomo (essere parziale) aveva il dovere di mantenere all’interno della natura e rispetto alla divinità.
All’opposto l’Età Oscura ha fatto dell’esagerazione in tutti i campi il suo cavallo di battaglia, incoraggiando ogni sorta di eccesso, di sregolatezza, di manifestazione pacchiana e raccapricciante. E’ chiaro l’intento di portare tutto alle estreme conseguenze al fine di suscitare nella moltitudine l’esigenza di ordine e disciplina che i soliti noti coglieranno al volo per imporre il loro totale dominio.
Stando sul filo della disparità di vedute, ne emerge un’altra: se per Omero seguire la propria curiositas è una «virtù», Dante relega questa motivazione umana alla sfera del sensibile e del puramente razionale, considerandola una «caduta». Per questa ragione chiude all’interno di una fiamma semovente uno dei grandi eroi positivi della tradizione culturale europea, abbandonandolo alla mercé dei venti infernali.
Il dispotico XXI secolo ha fatto di più, abolendo per legge la stirpe dei «curiosi» e abituando l’umanità tecnologica a prendere quel che passa il convento. Amazon recapita a domicilio i suoi oggetti, dalle capsule per il caffè alle emozioni. Netflix riempie il tempo libero. Facebook permette d’intrattenere rapporti sociali senza spostarsi dal divano mentre il lavoro si è fatto talmente intelligente (smart) dall’avere dimezzato i contatti umani. Ed è solo l’inizio.
Tradizionalmente basato sulla critica, il dubbio e la ricerca, persino il sapere scientifico dipende dagli interessi economici. Davanti ai soldi non c’è santo che tenga, né etica e morale capaci di prevalere. L’uomo come lo abbiamo conosciuto appartiene al passato; ancora non s’è capito chi gli succederà, ma è chiara l’ambizione di superare i decreti divini (naturali) che all’epoca di Dante costituivano invece barriere invalicabili, pena la dannazione eterna.
Omero non visse abbastanza a lungo per vedere la prigione in cui sarebbe finita la decantata libertà umana di fare, dire e pensare, né Dante assistette agli orrori perpetrati dagli uomini «in nome di dio». Nessuno di questi due Grandi Antenati poteva inoltre prevedere la scomparsa degli eroi disposti a fare dei remi le ali di un folle volo, così come la fine delle lunghe navigazioni pervase dal timore di un Fato incerto, dalla sensazione di essere continuamente sospesi tra una meta e l’altra, tra un destino e l’altro.
Morto lo «spirito audace» e sepolta l’avventura, l’esempio di Ulisse rimane comunque scolpito nella Storia: “… venimmo a quella foce stretta / dov’Ercule segnò li suoi riguardi, / acciò che l’uom più oltre non si metta …” (If XXVI 107-109). Questa non è semplice letteratura, né si tratta di generica cultura generale, tanto meno di una cosa carina da conservare nel cassetto perché manca il coraggio di gettarla via. Qui c’è un uomo che si ribella al prepotente di turno (Ercole), il quale si è preso la libertà di sbarrare il passaggio nello stretto (di Gibilterra) alle navi altrui per il proprio tornaconto.
Nel mondo parallelo di Dante le mitiche Colonne rappresentano senza dubbio un potente precetto morale, e almeno su questo punto sembrano essere tutti d’accordo, esse sono altresì un monumento al coraggio umano, il simbolo della forza reattiva dell’uomo che ciascuno possiede in potenza ma non esercita per paura di ritorsioni.
La demonologia medioevale è completamente calata nel conflitto dei buoni «sostenuti da dio» che combattono i cattivi «incarnazione del demonio», difatti Dante chiude l’eroe in una prigione di fuoco. Fino a quando continueremo su questa strada? Ancora non siamo stanchi della claustrofobica visione dualistica, che affligge l’umanità da millenni? Fermiamo un momento il pensiero sulla scelta di Ulisse e rispondiamo (senza il sostegno di Cicerone) alla fatidica domanda: meglio seguire le cose morte che vanno con la corrente o partecipare al flusso di quelle vive che andandovi contro si rigenerano, trasformandosi?
(il viaggio continua)



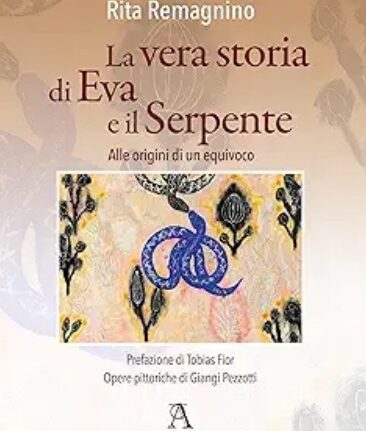



18 Comments