Ho preso un bidone…
Tempo fa ho qui raccontato la vera storia del torinese Dante Di Nanni, basandomi sulla ricostruzione che Nicola Adducci ne fece su “Studi storici”, l’insospettabile rivista dell’Istituto Gramsci. Emergeva che il giovane partigiano, icona delle Resistenza ancora ai giorni nostri, al momento della morte non: “(in piedi sul balcone) si appoggia in avanti, premendo il ventre alla ringhiera e saluta col pugno chiuso, poi si getta di schianto”, come ci avevano raccontato, ma, molto più banalmente viene colpito da una raffica “precauzionale” sparata nel condotto della spazzatura dove si è nascosto (e, forse, grida addirittura: “Non sparate, mi arrendo!”)
Poco prima c’era stato Sergio Luzzatto (altro insospettabile) che, in “Partigia” ci aveva svelato non solo che Primo Levi nella sua brevissima stagione partigiana aveva fatto in tempo ad improvvisarsi fucilatore alle spalle di due giovani compagni di lotta, colpevoli di non meglio precisate colpe, ma soprattutto che i due continuavano (e continuano, temo) ad essere considerati – a dispetto della verità che era peraltro nota negli ambienti resistenziali, così come quella di Di Nanni– vittime dei nazifascisti, con scuole e piazze a loro intitolate
Insomma, nonostante la documentata realtà, la forza della menzogna (e del mito connesso) sembra destinata a durare. E’ per questo che credo non avrà nessun seguito questa affermazione di Santo Peli, nel recentissimo “Storie di GAP” (che pure è un libro esaltativo di quella discutibile esperienza):
“La guerra partigiana è in buona parte, forse nella sua gran parte, una guerra di difesa… Nonostante si rischi di urtare la sensibilità di alcuni ambienti affezionati ad una visione un po’ mitica dei combattenti partigiani, va detto che….è facilmente verificabile che, fatte salve alcune notevoli eccezioni, gli scontri tra truppe regolari tedesche e bande partigiane mettono in evidenza l’incapacità di compiere manovre complesse e l’impossibilità di sostenere validamente l’urto di truppe regolari, da parte di civili malamente armati e privi di ogni addestramento militare, quali sono in maggioranza i partigiani”
Minuscole (faticose) ammissioni che restano limitate, però, alla cerchia degli specialisti, o dei “curiosi”, quale io sono, con una spiccata passione per la storia minore, quella dei piccoli uomini e delle piccole donne, terze e quarte file di vicende che passano ai libri di scuola.
È per questo che ho preso un volume (Livio Isaak Sirovich, “Non era una donna era un bandito”, Sommacampagna 2014) che narra la storia di Rita Rosani, ragazza triestina di origine ebrea, unica medaglia d’oro concessa ad una donna “morta in combattimento” durante la Resistenza
Mi incuriosiva il titolo (che “dovrebbe” essere la frase detta da un Ufficiale della GNR dopo la morte della Rosani) e certi accenni a un che di “poco chiaro” che avevo trovato nelle recensioni. Recensioni compilate però – a questo punto lo devo credere –, sulla base delle ”schede” preparate dalla Casa Editrice, perché pochi sono disposti a sobbarcarsi la fatica di 540 pagine di lettura.
E questo è stato per me il grosso bidone: su 540 pagine, quelle dedicate alla vicenda partigiana della protagonista, e al seguito processuale che vi fu (che poi è ciò che veramente mi interessava e di cui parlerò qui), sono non più di una settantina; le rimanenti trattano, su svariati piani, la storia d’amore con il fidanzato – ebreo anche lui e internato prima in Calabria e poi in Abruzzo –, la vita della comunità ebraica triestina, la ricerca del carteggio relativo a questa storia d’amore (in certi periodi quasi una lettera al giorno) che l’autore ha fatto girovagando per l’Italia
Comunque, si tratta di un bidone “parziale”, perché nel libro ci sono anche delle grosse sorprese rispetto alle aspettative create dal titolo. Senza anticipare ciò che poi dirò, credo possiamo partire da questa rivelazione non secondaria, che, in buona sostanza, altro non è che ulteriore conferma di quante falsità siano raccontate su tutto ciò che riguarda la Resistenza:
“Il capitano partigiano Romano Marchi, nome di battaglia “Miro”…sapeva perfettamente che i testimoni dell’avvenimento (si allude allo scontro nel corso del quale morì la Rosani ndr) erano pressoché unanimi nell’attribuire un paio di feriti ai nazifascisti, e forse una mezza dozzina di morti ai partigiani sorpresi nel sonno…
Ciò nonostante, nel suo libro “La Resistenza nel Veronese”, descrisse lo scontro in questi termini: “Un forte attacco di tedeschi e fascisti alla banda “Aquila”, nella zona di Monte Comune, causa fra i nemici una cinquantina fra morti e feriti.”
Il libro uscì nel 1979”
E magari, aggiungo io, fu pure adottato come libro di testo in qualche scuola locale per avallare la tesi dell’eroico, imbattibile partigiano.
Ma sarebbe niente… nella storia dell’unica donna “caduta in combattimento” durante la Resistenza e decorata di medaglia d’oro, è tutto falso, a cominciare dal titolo del libro
I protagonisti
Interprete principale della vicenda che sto narrando, è Rita Rosani (cognome originario Rosenzwig, i genitori provengono dalla Moravia) ragazza della buona borghesia triestina, di religione israelita, travolta dal gorgo degli avvenimenti che interessano la sua città, in particolare tra il 1940 e il 1945.
È proprio a fine giugno del 1940 – dopo che da un paio d’anni, a seguito dell’introduzione delle leggi a difesa della razza la situazione si è fatta difficile – che il suo fidanzato Kubi, anch’egli ebreo di famiglia proveniente dall’Est Europa viene fermato ed avviato al campo di concentramento di Ferramonti in Calabria (da dove sarà poi trasferito a Casoli in Abruzzo)
Rosa – che nel comune giudizio di chi l’ha conosciuta è una ragazza vivace, forse anche troppo (“disinibita come una ragazza di oggi”, dice un testimone), e piena di voglia di vivere – prova a proseguire la sua normale vita in città: inizia una corrispondenza quasi quotidiana con il moroso lontano, (con qualche litigio ed incomprensione dovuti alla distanza), continua gli studi, frequenta gli amici di sempre, coltiva la passione alpinistica, ha forse qualche spasimante
“Vivace”, ho detto, al punto di finire sulla bocca di tutti nella piccola comunità degli ebrei triestini (e non solo) per una lettera pubblicata – sia pure anonima, e firmata “Rosa triestina” – dal settimanale “Grazia” del 29 maggio 1941 in cui si accenna a tormenti e tentazioni di una ragazza separata dal fidanzato.
Tutti credono di riconoscere in lei l’autrice, e ne segue un certo isolamento da parte dei conoscenti “benpensanti”, aggravato da una circostanza che resta un pò misteriosa: lei, e lei sola, il 21 novembre del 1942 riacquista la cittadinanza italiana (della quale era stata privata come tutti gli ebrei) con un provvedimento ad personam le cui origini restano oscure.
Nel libro si parla di un probabile intervento “non disinteressato” di un professore ebreo “discriminato” per i suoi meriti fascisti, più anziano di lei, ma che le si è presentato con un allusivo: “Signorina, le ragazze libere si conquistano, le fidanzate degli altri si rubano”.
In questo contesto, verso la fine del ’43, dopo il voltafaccia dell’8 settembre, si inserisce l’altro personaggio importante della storia, il Tenente Colonnello Umberto Ricca, Capo di Stato Maggiore della Divisione Pasubio in Russia, insignito dell’Ordine Militare dei Savoia e della Croce di Ferro tedesca, aitante e fascinoso nella sua divisa attillata, duellista plurimo e abile, impenitente tombeur de femmes, imparentato con Italo Balbo.
È inevitabile che Rosa – la sua storia con Kubi è, frattanto, praticamente finita – cada nella rete dello spregiudicato Ufficiale (all’epoca è monarchico, poi diventerà comunista e… filosofo), che conosce nelle vicinanze di Portogruaro dove sono entrambi ospiti di famiglie amiche
Non è un incontro fortunato: il Ricca che il libro ci presenta è un uomo che in divisa ha saputo essere anche valoroso, ma, fuori dall’ambiente militare, viene esaltando atteggiamenti da fanfarone, fa grandi progetti e agisce poco, mente anche con se stesso (dei fatti darà, nel tempo versioni contrastanti fra loro), si atteggia a “grande Comandante”, ma è senza seguito e si condanna alla sconfitta
Trascinerà con sé anche l’ingenua ragazza triestina…
Se questi sono partigiani
Dopo qualche mese trascorso in varie case di amici disposti a nasconderli, tra marzo e luglio del ’44 Ricca e Rita decidono di passare in clandestinità: lui prende contatti con un Ufficiale dell’Esercito del Sud paracadutato in Veneto, ne ottiene promesse di armi che mai si concretizzano, e forma la sua “banda” (cui dà nome “Aquila”), con due (dico due!) volontari e tre moschetti 91.
In attesa dei duecento mitra che dovrebbero essere paracadutati, i due se ne vanno in montagna, dove “si sta quasi in pace, c’è anche tempo per le passeggiate” e cercano di incrementare l’organico della formazione partigiana anche a seguito dell’unificazione con altra “banda” (“Medusa”), pure dislocata sul monte Baldo (siamo tra Trento e Verona). In totale, il nucleo partigiano arriva così ad una dozzina di componenti, armati di due mitra, una dozzina di fucili e 500 cartucce.
Naturale che, in queste condizioni, venga evitato ogni “contatto” con le unità repubblicane presenti in zona, mentre, invece, non manca qualche scontro (verbale o poco più) con le agguerrite formazioni garibaldine comandate da Marozin, che non vogliono “concorrenza badogliana” in zona.
Insomma, una formazione partigiana per modo di dire, più che “attendista”: pochissimi uomini, scarsissime armi, e, probabilmente, al fondo, una ridottissima volontà di combattere veramente, magari dietro il paravento di quel “lancio” alleato che deve far fare il salto di qualità e che mai avverrà.
È una realtà che nemmeno la motivazione della medaglia d’oro può nascondere. Costretta, infatti, a rifugiarsi dietro una genericità che nulla dice:
“Perseguitata politica, entrava a far parte di una banda armata partigiana vivendo la dura vita di combattente. Fu compagna, sorella, animatrice di indomito valore e di ardente fede. Mai arretrò innanzi al sicuro pericolo ed alle sofferenze della rude esistenza, pur di portare a compimento le delicate e rischiosissime missioni a lei affidate. Circondata la sua banda da preponderanti forze nazifasciste, impugnava le armi e, ultima a ritirarsi, combatteva strenuamente finché cadeva da valorosa sul campo, immolando alla Patria la sua giovane ed eroica esistenza.
Monte Comun, 17 settembre 1944”.
Una conferma arriva anche dallo svolgimento del prologo dei fatti che porteranno alla morte della Rosani: la sera del 16 settembre Ricca manda tre dei suoi uomini (tre soldati sbandati, di origine meridionale) in paese, a Grezzana, per cercare di recuperare sette fucili che lì dovrebbero esserci, mentre lui con il resto della banda si mette tranquillamente a dormire, senza neppure predisporre un efficace servizio di vigilanza alla baita che è il loro rifugio.
Due imprudenze che saranno fatali
Una battaglia che non ci fu
I tre uomini inviati da Ricca a Grezzana se ne vanno in osteria, a tranquillamente chiacchierare tra loro. L’inconfondibile accento meridionale, però, li tradisce: alcuni militi del locale presidio della GNR, insospettiti, li fermano e li portano in caserma.
Qui giunti, nel giro di un’oretta (quindi, direi, nemmeno il tempo di porre in atto le “efferate torture” care a certa mitologia resistenziale) i tre si pentono, rivelano il nascondiglio dei loro compagni di banda e – probabilmente – si danno disponibili a guidare i militari che organizzano subito una spedizione.
Dico “probabilmente”, perché da qui in avanti tutto diventa incerto, in un susseguirsi di versioni diverse e contraddittorie nei momenti successivi (istruttoria, processo di primo grado, processo di appello, memorialistica) da parte degli stessi protagonisti. Cerco di sintetizzare:
– alle 4 del mattino del 17 settembre 130 uomini (raccolti alla bell’e meglio, e provenienti da vari Reparti, compresi una trentina di tedeschi delle “aggueritissime” Polizia Ferroviaria e Antiaerea) partono da Grezzana per il rastrellamento;
– in un paio d’ore viene raggiunto il rifugio partigiano. Al termine di una scaramuccia (una mezz’oretta di fuoco), che farà solo due feriti tra gli attaccanti fascisti i partigiani provano a defilarsi;
– da qui in poi cala la nebbia assoluta sui fatti:
- nel 1990 (46 anni dopo i fatti, cioè) in un’intervista, il partigiano “Gatto”, che c’era e riuscì a fuggire, racconterà – e il racconto diverrà “verità rivelata” – che, al suo invito a lasciare il campo, la Rosani avrebbe risposto: “Gavè voja de scherzar”, per riaffermare la sua volontà di combattere. Se vero, darebbe una bella verniciata di eroismo ai fatti, ma sta di fatto, invece, che la ragazza si unsce agli altri nella fuga (sarà, infatti, colpita alle spalle);
- Ricca affermerà di aver tenuto per mano la sua compagna, ferita, durante la fuga, ma sarà smentito dagli altri superstiti che la ricordano sola, soccorsa, ad un certo punto, da tale Degani, armato di mitragliatrice, che sarà l’altro morto della giornata;
- sul monumento eretto a ricordo del fatto, si parla di due morti (la Rosani e Degani) e tre “dispersi”, indicati solo col nome di battaglia. Di fatto, i corpi ritrovati furono solo due e non si può escludere addirittura che, somma beffa, i tre “dispersi” siano proprio quelli catturati dalla GNR e offertisi come guide al rastrellamento dei loro compagni
Altri dettagli restano incerti, ma mi fermo qui. Una sola osservazione: assodato che la povera giovane stava cercando di sottrarsi, con la fuga, alla cattura, che la scaramuccia durò una mezz’oretta al massimo, con due feriti fascisti e due morti partigiani “certi”, un po’ esagerato mi sembra quel “combatteva strenuamente” nella concessione della medaglia d’oro….senza dire che, a quanto ne so, sarebbe l’unico caso di medaglia d’oro concessa a un combattente che sta fuggendo e viene colpito alle spalle…
Ora, non ci resta, per concludere, che vedere se quella benedetta frase “Non era una donna, era un bandito” fu mai detta.
Una frase tutta inventata
“Viene fatto venire il parroco di Alcenago: “Nel pomeriggio del 17 (settembre 1944 ndr) – deporrà nel giugno del 1946 in Corte d’Assise (siamo al processo ai protagonisti fascisti dell’episodio che portò alla morte di Rita Rosani ndr) – … stando sulla porta della canonica, ho udito un milite fascista rivolgere queste testuali parole ad un Ufficiale che, a quanto ricordo, era un Tenente o Sottotenente assai giovane: “Adesso, signor Tenente, come farà, che ha ucciso una donna?” Al che, l’Ufficiale, alzando le spalle, rispose: “Era nostro dovere”.
Oggi, il signor Mario (nome fittizio) di Alcenago, dice che suo padre aveva sentito la frase completa: “Non era una donna, era un bandito, era nostro dovere”.
(Livio Isaak Sirovich, “Non era una donna era un bandito”, Sommacampagna 2014)
Ecco svelato l’arcano: un libro titolato ad effetto con una frase che, nel 2014 (settant’anni dopo i fatti!) il figlio (che non rivela il suo nome) di un protagonista dice che suo padre “aveva sentito” (e, presumibilmente, gli aveva raccontato, chissà quando).
Se non è la stessa tecnica della storia di Dante di Nanni, con una ricostruzione fatta a posteriori ad uso e consumo della “narratio”, poco ci manca… Insomma, si tratta di “verità di fede”, in quanto tali indimostrabili, anzi, forse “dimostrabili” solo nella loro falsità.
Resta da dire del – non secondario, ma non voglio ulteriormente tediarvi – particolare secondo il quale l’Ufficiale fascista avrebbe finito con un colpo alla nuca la Rosani che, ferita a terra, invoca pietà (e anche questo dettaglio, riferito dai suoi stessi compagni partigiani “stride” un po’ con la concessione della medaglia d’oro).
L’Ufficiale viene inizialmente individuato nel Sottotenente Mario Scaroni di Brescia, Comandante della “Compagnia Giovanile” della GNR. Al primo processo, egli è, però, assolto per insufficienza di prove dall’accusa di omicidio, da una Corte certo non ben disposta, che gli affibbia 24 anni di carcere per il reato di collaborazionismo militare.
In appello, dopo che i testi di accusa non riconosceranno lo Scaroni (che, latitante al primo processo, sarà ora presente in aula) la sentenza non potrà che essere confermata.
Insomma, “forse” fu sparato un “colpo di grazia”, ma “certamente” non si è mai saputo da chi (eppure, non doveva essere difficile trovare il colpevole, gli Ufficiali presenti erano solo tre).
A questo punto è più probabile dica – per una volta – la verità Ricca, che, nel luglio del ’45, scrive ai genitori della Rosani: “la morte fu istantanea”.
Sirovich però, non si arrende, e postilla: “pietosa bugia”… forse… degna conclusione, comunque, di una storia che di bugie è cosparsa


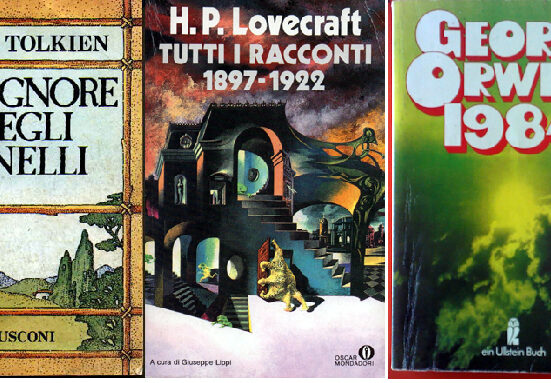





3 Comments