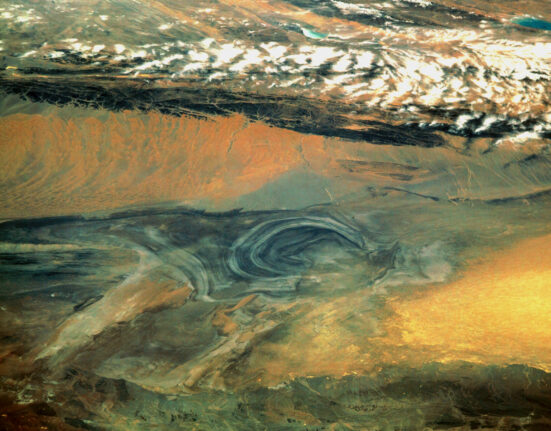La filosofia contemporanea è segnata dalla marcia trionfale degli analitici, che tendono a porre il reale e la vita sotto il dominio della ratio calcolante. Il loro intento originario, ben segnato nel secolo XX dal neopositivismo di Carnap, era individuabile nella volontà di liberare la conoscenza dai falsi problemi della metafisica. Paradossalmente, la loro strumentazione teoretica è la logica identitaria, propria della metafisica a partire da Parmenide. Fortunatamente, nell’attuale contesto speculativo, è possibile porsi all’ascolto di voci differenti: tra esse, in Italia, un ruolo di primo è svolto da Romano Gasparotti. Lo attesta il suo ultimo libro, L’amentale. Arte, danza e ultrafilosofia, comparso nel catalogo della casa editrice Cronopio (per ordini: 081/5518778, cronopio@blu.it, pp. 141, euro 13,00). Il volume è una tappa ulteriore dell’iter filosofico che Gasparotti ha intrapreso nei suoi precedenti lavori.  Sostanzialmente, il pensatore propone una significativa filosofia dell’immagine. Con immagine Aristotele, nel De Anima, riferendosi alla phantasia, dice di pensieri in potenza, che associa all’invisibile e indeterminata dynamis. Per questo l’immagine viene esperita come ciò che può farsi sensibile, essendo la sua natura: «congenere a quella della materia e della potenza, che, in quanto tali, come l’infinito, costituiscono gli invisibili per eccellenza» (p. 133). L’immagine, come rilevò Platone nel Timeo a proposito della chora, non ha alcuna forma determinata. La onto-teo-logia, al contrario, propone da millenni, una diversa concezione della forma, essa: «determina l’identità del differente nella misura in cui esso non è […] tutto ciò che è diverso da esso» (p. 134). Ciò porta all’esclusione, al rigido differenziarsi tra loro degli enti, mentre la vita, ben lo aveva intuito Bergson, è metamorfosi. Non coincide con il bozzolo della crisalide, ossificato nella sua staticità, ma con il volo, imprevedibile della farfalla. Nel processo dell’immaginare, chiosa l’autore, si mostra l’agire in atto che, per definizione, è sempre in fieri.
Sostanzialmente, il pensatore propone una significativa filosofia dell’immagine. Con immagine Aristotele, nel De Anima, riferendosi alla phantasia, dice di pensieri in potenza, che associa all’invisibile e indeterminata dynamis. Per questo l’immagine viene esperita come ciò che può farsi sensibile, essendo la sua natura: «congenere a quella della materia e della potenza, che, in quanto tali, come l’infinito, costituiscono gli invisibili per eccellenza» (p. 133). L’immagine, come rilevò Platone nel Timeo a proposito della chora, non ha alcuna forma determinata. La onto-teo-logia, al contrario, propone da millenni, una diversa concezione della forma, essa: «determina l’identità del differente nella misura in cui esso non è […] tutto ciò che è diverso da esso» (p. 134). Ciò porta all’esclusione, al rigido differenziarsi tra loro degli enti, mentre la vita, ben lo aveva intuito Bergson, è metamorfosi. Non coincide con il bozzolo della crisalide, ossificato nella sua staticità, ma con il volo, imprevedibile della farfalla. Nel processo dell’immaginare, chiosa l’autore, si mostra l’agire in atto che, per definizione, è sempre in fieri.
La naturalità della vita si dà nei processi metamorfici delle immagini. Il concetto, il dominio logico, non fa che staticizzare le immagini: per dirla con Klages, filosofo che Gasparotti in queste pagine ha il merito di valorizzare, non fa che «spiritualizzarle». Il recupero dell’«amentale» di cui il libro si fa latore, è un serio tentativo di uscire dalla dimenticanza della natura, della physis, che ha connotato di sé la storia della filosofia europea. Ci pare di poter rilevare che, in un contesto teorico neo-stoico, il recupero della natura sia stato tentato, oltre i limiti dualistici di Heidegger, da Karl Löwith. Oltre il «fisiocidio» metafisico ed analitico, il pensatore veneziano incontra la physis greca: «la cosmica mescolanza-mixis di ciò che è capace di vita, l’intrascendibile vivente pluralità di ciò che sgorga, sboccia, cresce, si trasforma e si estende» (p. 136). Sulla scorta degli Scritti del pittore René Magritte, egli è convinto che la «cattiva filosofia» prevalsa in Occidente, sia semplicemente un «pensare-che-dice», atto a rimuovere il mistero dal mondo e a rivestirlo, da un lato, di uno scudo composto di parole-oggetto rinvianti ad altri oggetti, in un processo gnoseologico di regressio all’infinito, al termine del quale si manifesta il pieno oblio dell’esistenza, del nudo che della vita, e nel quale si mostra, di contro, il primato dell’essenza, del che cosa, dell’universale trascendente. Il soggetto di tale esperire si conosce come impotente.
Per vitalizzare il pensare centrato sull’«amentale», del quale si può semplicemente dire che «esiste» senza altra predicazione, è necessario guardare, ancora con Magritte, al «pensiero-che- mostra»: la pittura, ma in genere ogni forma d’arte, è di tal fatta. L’artista-filosofo vede e mostra: «non fa che amplificare il ritmo circolare del respiro del mondo nel mondo. E’ come se il pensare pittoricamente mostrante inspirasse mondo per espirare mondo» (p. 19). Egli muove dall’immanenza dell’esistente e ad esso ritorna in forma potenziata, senza scelta volontaristica o finalistica. E’attuazione del pragma del pensare, un pensare-fare custodente il misterium del cosmo. L’opera, il prodotto, si scioglie, si perde nel mondo, fuoriesce perfino dal suo statuto di mero excrementum. L’artista-filosofo, a sua volta, non è un soggetto, è soglia di un’ esperienza compartecipata con i fruitori. Per quanto attiene alla poesia, essa deve essere vissuta non come insieme di parole da leggersi, oltre la mera lettura, che la staticizza: solo la dimensione performativa è in grado, klagesianamente, di liberare il portato delle parole, che altro non sono se non i «corpi sensibili delle immagini» (p. 31). Un’immagine è evocazione di altre immagini: «nella radicale sospensione di ogni identità […] e di ogni rapporto causa-effetto» (p. 32). Ciò vuol dire che il poetare nega la funzione meramente segnica della parola. Per questo, come aveva colto Cicerone, la poesia liberante è sorella della danza, nel suo essere sintonica alla saggezza del cosmo vivente .
Gasparotti mette in discussione il ruolo della scrittura, notando come, all’origine del pensiero filosofico, si fosse colto il senso ambivalente dello scrivere: era considerato pharmakon, medicina e veleno, mentre è consustanziale al pragma del pensiero la dimensione dialogica, il co-filosofare, la conversazione aperta, in quanto il filosofare, ben lo sapeva un grande del Novecento come Emo: «è un esercizio di penombra, il cui fine è quello di coltivare il rispetto per l’inviolabilità e la sacralità dell’invisibile e dell’indicibile» (p. 48). Gasparotti dedica pagine illuminanti a Plotino: questi ebbe contezza che l’immagine non è un dato, ma il puro esistere amentale di un che. Comprese, inoltre, che l’uno determinato, fatto proprio dall’intelletto e dal linguaggio, non è altro che l’ipostatizzazione dell’Uno aplos, indicibile, impensabile, ma sempre manifestato. Esso non è l’ineffabile di Wittgenstein, ma può esser detto nel lasciare agire la parola in modalità illocutoria e performativa, in quanto la potenza del bello è il: «risplendente risuonare e vibrare dell’energia dell’Uno» (p. 81).
La parte più rilevante del volume è, a giudizio di chi scrive, il saggio dedicato a Spinoza. Al filosofo della causa sui, Gasparotti attribuisce il merito di aver colto il tratto corporale di ogni prassi. Uno Spinoza riportato a Bruno e liberato dalla metafisica e dal dualismo cartesiano, il cui cosmo si presenta come rete di relazioni: «tra corpi elastici, porosi e letteralmente de-formabili» (p. 85). Il Deus sive natura è attività sempre all’opera la cui energia si dà modulandosi per gradi nel continuum, senza dar luogo ad alcuna differenziazione, relazionalità pura nella mescolanza. Il «pensiero-che-mostra» mantiene all’opera l’attività relazionante, resta in sintonia con la natura naturans e la sua potenza, mosso da mania erotico-poietica. Si tratta di una filosofia della potenza non cosale, altra rispetto alle filosofie del dominio che appestano la modernità.
Giovanni Sessa