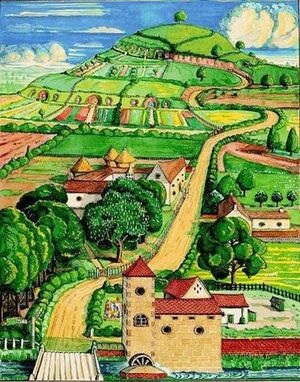Ha compiuto 85 anni e i segni del tempo si vedono tutti. È il PIL, il prodotto interno lordo, quell’indicatore universale in grado di orientare la nostra percezione sulla ricchezza e il potere dei paesi di tutto il mondo, tanto dametterli in ordine e farne una classifica mentale. A proporlo era stato nel 1934 l’economista americano Simon Kuznets al congresso degli Stati Uniti per monitorare lo stato di salute del paese. Certo, il suo fondatore non si sarebbe aspettato un tale e imperituro successo, visto che aveva subito messo in luce i suoi limiti per valutare un fenomeno tanto complesso quale il benessere di un paese. Eppure, complice la propensione innata dell’economia alla matematizzazione, questo numero rappresenta ormai l’

Celebre fu il discorso del senatore americano Bob Kennedy nel marzo 1968 -tre mesi prima di venire assassinato, seguendo la sciagurata sorte del fratello-, che punta il dito proprio sui limiti del Pil. Visionario e appassionante, vale la pena riportarlo:
“Quel PIL – se giudichiamo gli USA in base ad esso – comprende anche l’inquinamento dell’aria, la pubblicità per le sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il Pil mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende il fucile di Whitman e il coltello di Speck, e i programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Comprende le auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Il Pil non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o l’intelligenza del nostro dibattere. Il Pil non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.”
In effetti, le carenze del PIL non sono poche: dall’inclusione di beni nocivi per la salute e la sicurezza dell’uomo alla omissione del valore del patrimonio territoriale, ingenerando il paradosso per cui un cataclisma che devasta una città produce PIL nel momento in cui si procede alla sua ricostruzione. Nel calcolo del suo valore non sono inoltre imputati i danni ambientali legati all’attività di produzione, né vieneconsiderato il lavoro domestico o di volontariato. In generale, omette di valorizzare quanto non attiene alla sfera meramente economica e contabile: non ci fornisce alcun resoconto sul livello di benessere dell’individuo e della società, sul suo grado di sviluppo. Una delle colpe più gravi di questo osannato parametro è il non tenere conto del principale indicatore dello stato di salute di un’economia: la redistribuzione della ricchezza in essa prodotta. A partire dalla caduta del Keynesismo in poi -data ufficiale 1973- il modello economico neoliberista ha barattato la crescita con l’aumento della disuguaglianza. L’indice di Gini che ne è il misuratore ha mostrato un trend crescente negli ultimi decenni, sia tra le economie avanzate che tra quelle emergenti.
Nella sua opera “Mitologie economiche” (2017) l’economista francese E. Laurent denuncia come in un’economia avanzata quale quella statunitense l’aumento del 2% del PIL comporti la decrescita del reddito per il 90% della popolazione. Tale paradosso mette in  luce tutte le contraddizioni dell’attuale sistema economico e l’inadeguatezza del suo indicatore principe a coglierne le disfunzioni. Che futuro può avere una popolazione che si impoverisce all’aumentare del valore della sua ricchezza? Ha senso continuare a misurare il grado di sviluppo di un’economia con un termometro inadeguato? In economia tutti i principali indicatori vengono riportati al PIL, dal deficit al debito, all’avanzo commerciale. Sbagliare unità di misura vuol dire sbagliare strategie e politiche messe in atto da parte di attori pubblici e istituzionali. Rimanere ancorati a un indicatore ottuagenario e per giunta limitato già agli occhi del suo creatore, vuol dire deviare la rotta per uno sviluppo sostenibile e inclusivo che accompagni il nostro futuro.
luce tutte le contraddizioni dell’attuale sistema economico e l’inadeguatezza del suo indicatore principe a coglierne le disfunzioni. Che futuro può avere una popolazione che si impoverisce all’aumentare del valore della sua ricchezza? Ha senso continuare a misurare il grado di sviluppo di un’economia con un termometro inadeguato? In economia tutti i principali indicatori vengono riportati al PIL, dal deficit al debito, all’avanzo commerciale. Sbagliare unità di misura vuol dire sbagliare strategie e politiche messe in atto da parte di attori pubblici e istituzionali. Rimanere ancorati a un indicatore ottuagenario e per giunta limitato già agli occhi del suo creatore, vuol dire deviare la rotta per uno sviluppo sostenibile e inclusivo che accompagni il nostro futuro.
Ilaria Bifarini (http://ilariabifarini.com/)
è nata a Rieti l’1 aprile del 1980 e si è diplomata al Liceo classico “Terenzio Varrone”. Dopo essersi trasferita nel 1999 a Milano, nel 2004 si è laureata col massimo dei voti in Economia della Pubblica amministrazione e delle Organizzazioni internazionali all’Università “Luigi Bocconi” di Milano. In seguito ha frequentato la Scuola Italiana per le Organizzazioni Internazionali di Roma ed il Corso di Liberalismo presso l’Istituto “Luigi Einaudi” di Roma. Ha conseguito inoltre l’abilitazione alla professione di dottoressa commercialista e revisore contabile, oltre al SIOI (master in studi diplomatici). Dopo esperienze professionali nel pubblico e nel privato, attraverso un cammino fatto di studio ed introspezione, si è via via discostata dalla formazione prettamente neoliberista derivante dai suoi studi. Collabora con varie testate giornalistiche in rete e intervengo a convegni e trasmissioni televisive.