Rieccomi. Quanti di voi lettori avete avuto la pazienza di seguirmi sulle pagine elettroniche della nostra “Ereticamente”, avrete certamente notato che negli ultimi tempi, e per buona parte di questo ormai declinante 2023 mi sono dedicato ad articoli della serie L’eredità degli antenati, e questo è avvenuto per un motivo preciso, il fatto che si era creata con l’andare del tempo una “forbice” davvero imponente – siamo arrivati a sfiorare i cinque mesi – tra gli eventi di cui vi narravo e il momento in cui gli articoli a essi relativi potevano comparire sulle nostre pagine. Questo perché, non so se quest’anno le scoperte archeologiche si siano succedute a un ritmo maggiore che nel passato, ma certamente hanno ricevuto una maggiore attenzione da parte dei media, in particolare dopo la scoperta dei bronzetti di San Casciano dei Bagni.
Di passata, si può anche ricordare che la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico ha assegnato l’International Archaeological Discovery Award “Khaled al-Asaad” – giunto alla 9ª edizione a questa scoperta. Ricordiamo che il premio Khaled, assegnato da una giuria internazionale comprendente giurati tedeschi, svizzeri, inglesi e francesi, è una sorta di Oscar o di Nobel dell’archeologia, ed è la prima volta che viene assegnato a una scoperta avvenuta in Italia.
Questa, a mio parere, è ancora una sottovalutazione. L’Italia ha visto succedersi nei secoli sul suo suolo importanti civiltà, da quella etrusca, alla Magna Grecia, a quella romana, a quella comunale nel Medioevo, ed è un autentico scrigno di tesori archeologici non ancora adeguatamente studiati, né tanto meno conosciuti, ma ora ne prescindiamo.
Adesso che questa “forbice” si è considerevolmente ridotta, anche se non sono riuscito a cancellarla del tutto, vi vorrei parlare di qualcosa d’altro, e tanto per cominciare, dirvi qualcosa di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ossia la tematica dell’etica, che poi si traduce in quello che è il comportamento che tutti noi dovremmo tenere.
Io non tenterò ora e nel corso del presente articolo, di dimostrarvi che attualmente viviamo in un mondo dai valori profondamente pervertiti, un mondo al contrario, come ha spiegato, già nel titolo, il fortunato libro del generale Vannacci. Penso che questa sia una considerazione ovvia per chiunque di noi abbia la sensibilità “giusta”.
Né d’altra parte ci sarebbe da aspettarsi nulla di diverso, sapendo che secondo l’insegnamento delle dottrine tradizionali, attualmente stiamo vivendo nel Kali Yuga, l’età oscura che contrassegna la fine di un ciclo cosmico, e di cui il sovvertimento di ogni valore è appunto il sintomo più evidente.
D’altronde le stesse dottrine tradizionali ci dicono che coloro che tengono fermo nel Kali Yuga sono doppiamente meritori. Basta ricordare, per tutte, l’esortazione di Julius Evola a essere uomini che si tengono in piedi in mezzo alle rovine. Quando Evola scrisse queste parole, l’Europa era appena uscita dalla seconda guerra mondiale, ed era coperta da rovine materiali ben visibili, frutto di un conflitto apparentemente insensato, il cui vero scopo che i vincitori avevano abilmente celato, era quello di fiaccare in modo irreversibile le etnie europee.
Oggi le rovine materiali non ci sono più, ma in compenso le rovine morali e spirituali hanno progredito oltre ogni limite che tre quarti di secolo fa sarebbe stato concepibile, e l’insegnamento di Evola rimane quanto mai valido, ma rimane un problema: Dove trovare dei modelli a cui ispirare il nostro comportamento?
Dovremo cercare nella storia, tracce che per loro natura sono esigue, e caratterizzate soprattutto dal fatto di essere in opposizione ai modelli di comportamento della maggior parte dei nostri contemporanei, ma prima ancora c’è una domanda fondamentale a cui occorre rispondere: cosa significa essere liberi, e quindi capaci di autodeterminarsi?
A questo riguardo, diciamo subito che la maggior parte degli uomini contemporanei concepisce l’idea stessa di libertà in termini di libertà esteriore, cioè di assenza di costrizioni esterne, mentre non si ha nessun occhio al fatto che è altrettanto essenziale la libertà interiore, il non essere schiavo di istinti e passioni o addirittura (discorso oggi drammaticamente di attualità), di dipendenze, forse proprio per non rendersi conto che per la maggior parte dei nostri contemporanei, questa libertà interiore non esiste.
È un aspetto del nostro discorso sul quale mi riprometto di tornare, ma prima di scendere nella dimensione privata, sarà bene partire da qualche considerazione riguardante l’etica pubblica.
È chiaro che i nostri modelli li andremo a cercare al di fuori del mondo contemporaneo, o in ciò su cui esso ha avuto un’influenza trascurabile.
Sinceramente, l’ho scoperto quasi per caso, occupandomi della rubrica o serie di articoli L’eredità degli antenati che tengo da parecchio tempo su “Ereticamente”, una delle più celebri statue dell’antichità greca, il leone di Cheronea che ricorda i caduti greci e in particolare la legione tebana, nella battaglia che si svolse in questa località contro i Macedoni di Filippo II padre di Alessandro Magno, fu fatta erigere dallo stesso Filippo II per onorare il valore dei nemici sconfitti, ma del cui valore era rimasto ammirato.
Un esempio non dissimile, sulle soglie del Medio Evo, ce l’ha dato il re longobardo Alboino, figura spesso calunniata dagli storici. Dopo la calata dei Longobardi in Italia, egli scelse come capitale del regno Pavia, precisamente in ragione del fatto che la città non aveva capitolato se non dopo due anni di assedio, ed era rimasto ammirato dal valore dimostrato dai Pavesi.
Questo è un tratto assolutamente tipico dell’uomo tradizionale, anche di un “barbaro” come Alboino, il rispetto per il valore, anche e soprattutto di un nemico sconfitto, siamo proprio all’antitesi della mentalità moderna, per la quale si continuano da ottant’anni a calunniare gli sconfitti nella seconda guerra mondiale anche con le calunnie più invereconde, e in totale spregio della verità storica.
Tutto ciò riguarda la dimensione pubblica, ma ora vediamo di scendere a un livello più personale. Non si conosce veramente sé stessi finché la vita non ci mette alla prova. Nove anni fa, feci una delle esperienze meno augurabili della vita, scoprii di avere un tumore.
Sono stato operato e ogni cosa è andata per il meglio, ma quella circostanza mi ha insegnato qualcosa su me stesso: non avevo paura.
A differenza di quanto avrebbero – suppongo – fatto molti che improvvisamente riscoprono una fede in cui hanno smesso di credere dall’infanzia, io NON pregai, trovai invece forza nelle parole di Virgilio, “Et facere et pati fortiter romanum est” – è da Romani agire e sopportare con fermezza – e nell’insegnamento di Socrate: il saggio non ha nulla da temere né in vita né in morte. Se c’è un aldilà, riceverà la ricompensa della sua rettitudine, se non c’è, condividerà semplicemente il destino di tutti.
 Rievocando tempo fa questa brutta esperienza sulle pagine di Facebook, mi è venuto spontaneo commentare che forse mi sarei trovato meglio a vivere in un’epoca più eroica di quella presente, ma qualcuno mi ha fatto notare che è proprio la nostra “comoda” epoca quella che richiede più forza d’animo per tenere fermo su quei principi che fanno di un uomo realmente un uomo.
Rievocando tempo fa questa brutta esperienza sulle pagine di Facebook, mi è venuto spontaneo commentare che forse mi sarei trovato meglio a vivere in un’epoca più eroica di quella presente, ma qualcuno mi ha fatto notare che è proprio la nostra “comoda” epoca quella che richiede più forza d’animo per tenere fermo su quei principi che fanno di un uomo realmente un uomo.
Ricordo con un certo divertimento una discussione di anni fa con un buon cattolico che mi disse che ho “una mentalità da antico Romano”. Sono sicuro che non intendesse in alcun modo elogiarmi: per lui, gli antichi Romani erano quei cattivoni che perseguitavano “immotivatamente” quei “poveri” cristiani, e non aveva idea del complimento che mi fece.
Come penso ricorderete, ho esordito sulle pagine di “Ereticamente” ormai parecchi anni or sono, con una serie di articoli molto critici verso la religione dominante – anche se oggi in sempre più accentuato declino – nel mondo occidentale, e sono certo che qualcuno non me l’ha ancora perdonato, ma poi ho lasciato perdere, passando piuttosto a tematiche di contenuto positivo, perché, diciamolo, l’insistenza sugli argomenti “mangiapreti” è piuttosto tipica degli atei, specie di sinistra e in particolare della parrocchia radicale, perché sul positivo non hanno nulla da offrire.
Ma mettetevi, per così dire, nei panni della divinità. Come vi sentireste verso un conoscente che vi ha ignorato per moltissimo tempo e si mette a cercarvi solo quando ha bisogno di voi?
Bisogna ammetterlo: per secoli il cristianesimo ha fatto bene o male le veci di quelle tradizioni antiche che ha soppiantato e valendo come simbolo dell’identità europea – da Poitiers a Lepanto – e questo spiega perché esista ancora oggi un filone di tradizionalismo cattolico. In definitiva, quando ci si trova stretti nella stessa trincea, non si dovrebbe guardare in che direzione si rivolgono le preghiere, ma da che parte si punta la canna del fucile.
Io quindi non insisterei nella polemica se non fosse per il fatto che oggi la Chiesa bergogliana è sempre più lontana da quel ruolo che ha di fatto abbandonato con il Concilio Vaticano II.
Una novità solo apparentemente marginale è la modifica che nel rito cattolico ha subito la formula tradizionale del Padre Nostro, dove “Non ci indurre in tentazione” è diventato “Non abbandonarci alla tentazione”. In sostanza con essa si nega che la tentazione possa venire da Dio, avere il valore di una messa alla prova. Si viene cioè a patti con la riconosciuta debolezza caratteriale dell’uomo moderno.
Uno dei pochi, forse l’unico capolavoro letterario della nostra epoca accostabile a quelli della tradizione classica come l’Iliade e l’Odissea è probabilmente Il signore degli anelli dello scrittore inglese John R. R. Tolkien. Sul cristianesimo di Tolkien, che tra l’altro apparteneva a una famiglia di cattolici, frequenti in Inghilterra come i denti di gallina, non vorrei tornare ora ad aprire un contenzioso, sebbene continui a sembrarmi che dal comportamento dei suoi eroi discendano implicazioni etiche tutt’altro che cristiane, essi non porgono l’altra guancia agli emissari del male, e non cercano di convertirli, ma li combattono con le armi in pugno.
In ogni caso, non si può mettere in dubbio che nel Signore degli anelli vi siano insegnamenti etici da tenere in grande considerazione.
Nel momento in cui la Compagnia dell’anello deve decidere se arrischiare o no l’attraversamento delle miniere di Moria, Gandalf osserva:
“Il punto non è se desideriamo andarci, ma se ci andremo”.
Curiosamente, una lezione della stessa natura si può ricavare da un episodio riferito a un eroe della seconda guerra mondiale, il comandante sommergibilista Todaro a cui recentemente è stato dedicato un film. Pare che al momento di intraprendere una missione particolarmente pericolosa, si sia rivolto a un suo sottoposto chiedendogli:
“Hai paura?”
“Si, comandante”, rispose quest’ultimo.
“Anch’io”, concluse Todaro, “Bene, andiamo!”
Sono esempi e sono lezioni che si trovano sull’asse concettuale esattamente opposto a quello dell’uomo moderno. Ci insegnano non soltanto che una persona non va giudicata in base alle sue emozioni, ai suoi sentimenti ai suoi stati d’animo ma in base alle sue azioni, ma soprattutto che emozioni, stati d’animo, soggettività non possono esentare da quello che è il corretto modo di agire, da ciò che con una parola ormai quasi desueta si chiama dovere.
Se noi guardiamo il modo in cui la maggior parte dei nostri contemporanei cerca di giustificare i propri comportamenti, dai tribunali ai talk show televisivi, alle conversazioni da salotto, vediamo che è il trionfo del punto di vista opposto. Da “Non volevo farlo” a “Al cuore non si comanda”, c’è sempre la pretesa che un’emozione, uno stato d’animo soggettivo su cui si presume di non avere alcun controllo, possa giustificare anche il comportamento più indegno o più vile. È il segno di un’umanità ormai regredita a uno stadio infantile, in cui l’intelletto non esercita più alcun dominio sulle emozioni.
Silvano Lorenzoni, di cui mi sono occupato più di una volta sulle nostre pagine elettroniche recensendo i suoi libri, è oggi uno degli intellettuali “pagani” più interessanti. Ha enucleato un concetto importante, con il quale mi trovo del tutto consenziente. L’associazione tra religione ed etica è tipica delle religioni monoteistiche-abramitiche: ebraismo, cristianesimo, islam. Per esse, comportarsi bene significa fare ciò che si suppone essere la volontà di Dio, cosa che può benissimo includere lo sterminio degli infedeli o la persecuzione degli eretici.
Questa concezione, in ultima analisi, riduce l’etica a un basso mercanteggiamento, “si fa il bravo” per evitare le fiamme dell’inferno e per avere la ricompensa paradisiaca nell’aldilà.
Gli abramitici non vedono altra base all’etica se non questa, da qui la famosa domanda provocatoria “ti fidi di un ateo” (“o di chi ha una religione diversa dalla mia”)?, con il sottinteso nemmeno tanto implicito che chi non condivide una religione (la loro religione in realtà) debba essere un individuo privo di etica, moralmente spregevole.
Una morale che in fondo non è che la dilatazione su scala universale del principio del bastone e della carota.
Si ha la spiacevole impressione che costoro sarebbero pronti a compiere le azioni più atroci se avessero la convinzione che Dio in quel momento sta guardando da un’altra parte, e considerando come si sono sempre comportati ebrei, cristiani e islamici nel corso dei secoli, devono aver pensato che Dio guardasse da un’altra parte piuttosto spesso.
L’etica non ha un legame diretto con la religione nella maniera in cui pensano costoro, ha piuttosto fondamento nel senso della dignità, del rispetto per sé stessi, e non scordiamo la lezione socratica: chi compie del male ignora di nuocere prima di tutti a sé stesso, perché non si rende conto in tal modo di abbrutirsi, di svilirsi, quindi, poiché nessuno desidera nuocere a sé stesso, il male è prima di tutto una forma di ignoranza.
Ciò coincide con il detto popolare che “è sempre meglio essere il derubato che il ladro”. Avere un’etica significa, in ultima analisi, rispettare la nostra dignità di uomini.
NOTA: Nell’illustrazione, Atena, dea greca della saggezza.


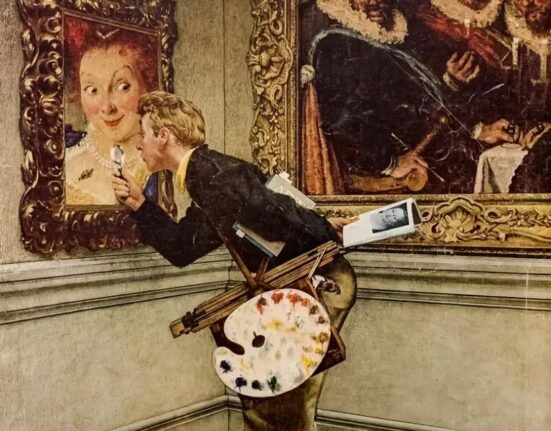
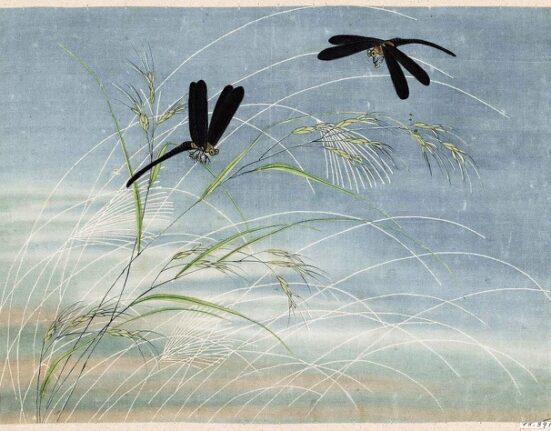

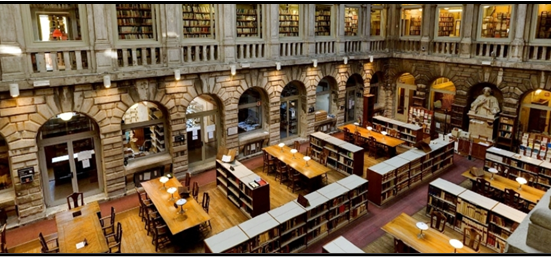

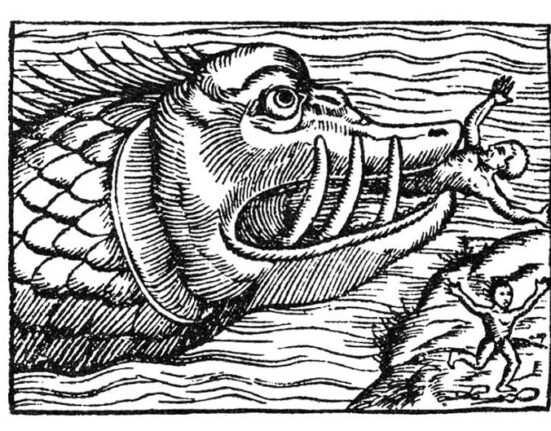
2 Comments