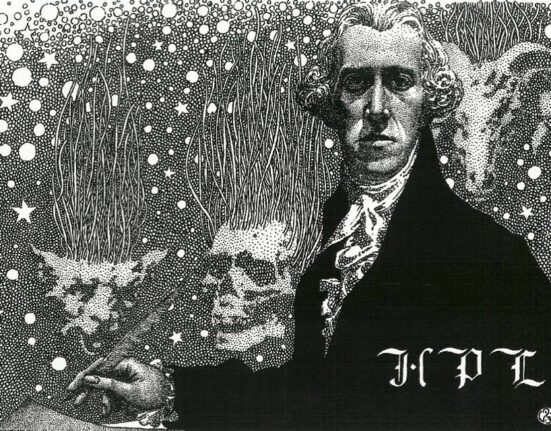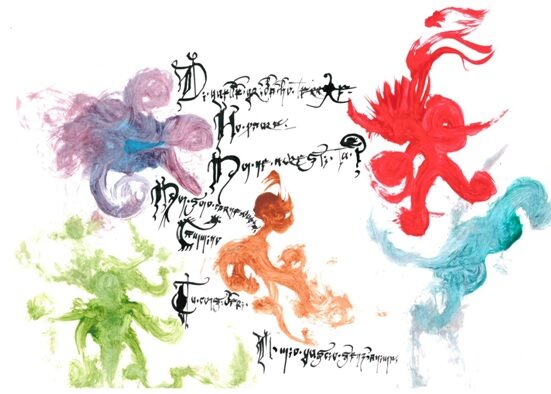Rapsodie di Passaggio, Stefano Eugenio Bona, Edit@ Casa Editrice & Libraria, Collana Orfeo, Taranto 2017, pagine: 72 p., ill, introduzione a cura di Luca Valentini.
Ricondurre la poesia alla sua origine sacra è compito arduo, forse impossibile, ma quanto mai necessario, almeno per avvicinamento. Poesia, innanzitutto, come magia, ri-creazione (che sta nella capacità di ridonare potenza plasmatrice alla parola), impronta del numen, del genio nella sua accezione più profonda e pura, tradizionale, quindi invocazione/evocazione, poi inno, canto. Poesia come ponte e come caverna/varco; infine, illuminazione e rivelazione, nel senso di svelamento e ri-velazione naturale a occhi profani (indispensabile ermetismo, senza alcun riferimento alla corrente letteraria).
“Chi tiene presente quanto siano legati alle prime forme di coscienza sottile l’elemento ritmo e l’elemento imagine, può comprendere come certe esperienze trascendenti possano esprimersi meglio attraverso la poesia, che non attraverso il comune pensiero astratto. […] Vi è un’arte sottile di associare certe parole, che secondo il loro significato solito tratto da corrispondenze nessuno penserebbe a mettere insieme. Chi, invece di sconcertarsi, è capace di affrontare attivamente rapporti del genere, può essere portato a intuizioni che hanno già un certo carattere illuminativo […]”
(Ea, Poesia e realizzazione in Introduzione alla Magia, volume terzo).
Traguardo irraggiungibile, considerato lo stato attuale della poesia: espressione irrilevante, sbiadita, talvolta isterica dei propri sentimenti, i più meschini; morta nel torpore autoreferenziale della confidenza privata: ancor meno che umana, troppo umana. Tripudio di mediocrità, esternazione impudica di una povertà spirituale prima ancora che culturale. In un  tale desolante scenario, anzi, al di fuori di esso, poeti come Stefano Eugenio Bona provano a ripristinare i contatti con la dimensione del sacro, che dovrebbe essere insita nella poesia: il fare/azione magica. Il poeta dovrebbe preliminarmente rievocare tali contatti in sé stesso, per poi manifestarli dietro il velo dei versi. Proprio questa ricerca in sé e al di là del sé/io, questo sconfinare nell’eccesso, nel senso di un graduale oltrepassare, è una costante nell’opera dell’autore di Rapsodie di Passaggio. Rispetto alle precedenti raccolte, a Peregrinazioni in particolar modo, lo stile si fa più asciutto, meno barocco e variopinto. Più vicino stilisticamente il secondo compendio, Carmi ricorsivi, seppure con intenzioni poematiche e dal tono maggiormente “oracolare”; in realtà, un progetto ancora in fase di elaborazione.
tale desolante scenario, anzi, al di fuori di esso, poeti come Stefano Eugenio Bona provano a ripristinare i contatti con la dimensione del sacro, che dovrebbe essere insita nella poesia: il fare/azione magica. Il poeta dovrebbe preliminarmente rievocare tali contatti in sé stesso, per poi manifestarli dietro il velo dei versi. Proprio questa ricerca in sé e al di là del sé/io, questo sconfinare nell’eccesso, nel senso di un graduale oltrepassare, è una costante nell’opera dell’autore di Rapsodie di Passaggio. Rispetto alle precedenti raccolte, a Peregrinazioni in particolar modo, lo stile si fa più asciutto, meno barocco e variopinto. Più vicino stilisticamente il secondo compendio, Carmi ricorsivi, seppure con intenzioni poematiche e dal tono maggiormente “oracolare”; in realtà, un progetto ancora in fase di elaborazione.
In Rapsodie si percepisce subito l’accurata limatura e una maggiore consapevolezza sia nella versificazione che per il contenuto. Eppure, a dispetto di questa relativa e apparente semplificazione, si arricchisce la gamma di tonalità/modulazioni che fluiscono più o meno sotterranee, permeando discretamente i versi. Un sostrato più umano e malinconico, sottofondo musicale più che sinfonia madre, che si scopre trampolino verso mete altre, perché la tessitura di Bona è ermetica, nel doppio significato di impenetrabile e di alchemica. Il titolo è già rivelatore: rapsodie come frammenti di armonie, un flusso musicale continuo con le sue variazioni sul tema. Ed è proprio questa frammentarietà sinfonica (evidenziata anche dal fatto che molte poesie sono semplicemente numerate, senza titolo), che per alcuni componimenti può sembrare una debolezza, il punto di forza della raccolta come insieme organico: una melodia perennemente cangiante ma sempre coerente e uguale sul fondo.
Il Passaggio come sorta di varco dimensionale, vero e proprio leitmotiv nell’opera di Bona, oltrepassamento nell’antro della caverna che conduce al cuore, al centro sconosciuto del proprio essere, un ritrovarsi altrove.
La poesia d’apertura suggerisce gli echi distorti che si stendono tra i mondi:
Le corrispondenze tra cielo e terra…
Come germogli, ritorte consonanze.
I, Seconda litania, vv. 1-2
Solo una visione superiore può cogliere tali corrispondenze, ciò cui allude l’Occhio che osserva e annichilisce chi non è capace di immedesimazione. Un prezioso bozzetto introduttivo in cui sono già presenti alcuni dei temi che vengono sviluppati nei componimenti successivi (nella XXIX la risonanza devia in convergenza). Lieto nel Presente è quasi una dichiarazione di intenti, con categorico verbo all’infinito a inizio verso a dare il tono. Compare per la prima volta il tema del velarsi, del nascondersi: l’ascetico isolarsi, il praticar deserti del poeta, che è un “sabbiarsi”, ma “in alto”, seppellirsi, farsi cadavere, per sovrastare, in “Oasi sconosciute a poppa”, il divenire cosmico, nel silenzio dei pianeti. Per quanto ben filtrata, in questi pochi versi si avverte l’influenza di Arturo Onofri, poeta cui Bona ha dedicato una inestimabile ricerca culminata in quattro saggi pubblicati proprio su Ereticamente.
Con gli ultimi tre versi si sussurra l’approdo e la poesia si fa preghiera, ma a se stesso, affinché il nuovo corpo dei sensi, o meglio, la sua veste purificata, la sorgente e la visione conquistata non naufraghino. Poesia/inno, quindi, come in Prece della Stanza o in Sol 21, in cui diviene “peana onnistellare” nella notte/Lamia, figura femminile mitologica assimilabile alla donna come morte suggente (Meyrink), cui il poeta indica la sua stessa Opera, per non crollare nella sua malia – l’amplesso? – che può condurre alla Follia . Il deserto, il naufragio, l’esilio, la follia sono presupposti indispensabili per l’illuminazione, per la visione di “Un cuore – Tre Rose” (XLVII): l’approdo è naufragio come le tenebre sono saturazione di luce. Un tema, quello del naufragio, che non a caso riappare negli ultimi componimenti, associato a quello della morte/rinascita (XLIV, Oro azzurro, Derive, XLVIII). La struttura comincia già a palesarsi, labirintica: laddove si scorge una via d’uscita si sbatte contro una vetrata o uno specchio, contro il proprio riflesso.
Ricorrente l’immagine nello specchio, in particolare dello specchiarsi nel proprio abisso, sentendo l’interno esterno e viceversa (Il Punto), in una sfilata di attori, di persone (XVI e XXII), che sono l’io stesso del poeta, “giochi della mente e del cuore” (V). La percezione dell’identità – “meta d’attori” (Il Punto) – permette di captare un presente eterno, caleidoscopico per la sovrapposizione e la stratificazione dei piani dell’esistente promanati dall’essere. Alla fine si precipita e ritorna nel grembo, la differenza sta nella consapevolezza, nel saper guardare. Lo scivolare via dal sogno in un sonno senza coscienza: questo è il pericolo che corre il poeta in ogni sua visione e preveggenza (IX), ma anche la sua sfida. Ecco la necessità di “ingemmare i simboli” (VI), “riannodar Bagliori, volte di passaggi aurorali” (VII), di una “Oculata veglia in cammino” (Convergenze e battiti).
Lo specchio rappresenta un altro varco, che, come accade a Narciso, può incantare e incatenare, intralciando il cammino, la cerca di sé oltre il sé dell’immagine riflessa, oltre le persone del gioco. Così la poesia è anche resoconto della caduta nel canto delle sirene sulla vitrea superficie del baratro. Di qui le luci soffuse di quella nostalgia di purezza originaria che assume i contorni della malinconia corazziniana, ma con slancio metafisico:
Il mestiere delle candele
ritorni primitivi e folli,
le parole delle nostre sfere
come esalazioni sottili.
[…]
II
Lampada ad olio di rara bellezza
porta candele in rame, nel dubbio
ritmo tra nevi e fronde ad oltranza.
[…]
XIII, Disgelo nel calore
Nostalgia dell’origine, nostalgia di Roma, canto della sua decadenza, in cui ai languori corazziniani si miscelano i notturni chiaroscurali di Campana; ma sotto le ceneri cova ancora la fiamma, un’opportunità sotto forma di anelito al trapasso:
E se Nero è ‘l dado con streghe puttane
Ottenebra l’entrata, trapasso stamane.
Seduto in Villa Borghese
Una rarefazione in baluginio ascendente può manifestarsi anche dall’efflorescenza musicale nella poesia VIII:
Ad un’anima che si trabocca nel cuore
di coraggio, passione e livore
non si nega il passaggio nel Carme di stupore.
Elato nell’arpeggio, nelle ore sonore
spolpa il saggio sfoglie di candore,
attratto magnete e sfera d’aurore.
Nel fantasma dell’alba prima,
si vince amore dalle cime:
erompe il vantaggio del crepuscolo,
le sinapsi lasciano edere in canti.
Si procede per squarci che vengono opportunamente espansi per poi richiudersi, morire in se stessi (il lucore bianco di Giorni di Neve) o esplodere in armonie di pieno splendore come in questo caso. Altrove squarci si aprono negli squarci, uno strappo nel sipario che mostra prospettive oblique, spiazzanti (come in XXIV o in Iscrizioni del Pentagramma).  Con Il nome si rievoca la potenza creatrice della parola, “notte della terra”, “peso sacrilego” fattosi corpo, attore dell’origine. La notte della terra, l’origine di cui la memoria è immemore, sonnambula: “Cala la palpebra sui sentieri persi” (X). La memoria, perciò il tempo e lo spazio, la morte sono altri temi ricorrenti (XXIV), altri trascendimenti necessari. Non mancano i passaggi più leggeri, quasi dada, i giochi di parole (ovunque), l’ironia, come in Canzone del ballo lunare o in XV, in cui si assiste alla carrellata di alcuni dei poeti più significativi per lo stile e i contenuti della poesia di Bona: Swinburne, Pound, Yeats, Onofri, ai quali sarebbero da aggiungere almeno i nomi di Stefan George, Rilke e Dylan Thomas. Fonti ingombranti che però sono il più delle volte ben amalgamate e filtrate secondo la peculiare sensibilità del poeta. Il poeta stesso, come già accennato, appare non di rado in veste d’attore, maschera, anzi, maschere da risolvere nella forma primigenia (XXXVI), trasfigurando nell’onnipresente, quindi assenza priva di forma, o da sublimare come demoni di un io plurale e beffardo (la “polisemia d’attori”, in Dimora infestata sciolta in “maschere spente”, “Spiritosi osceni avventori morti”). Proprio al processo di trasmutazione allude il “signaculo invitto” di 17 febbraio, il martirio/sacrificio di Giordano Bruno di cui non rimane traccia umana. Una tensione all’oggettività, all’impersonalità, al simbolo, che emerge, in realtà, dal suo opposto, da un’immersione totale nella soggettività, al fondo della quale si trova un’alterità irriducibile all’io, una trascendenza immanente. Da questo punto di vista, La Maschera del Mattino e XXXVI sono componimenti di carattere dichiaratamente alchemico come XXV, Convergenze e battiti e Il Parco Orsini lo sono implicitamente, in profondità. La trasmutazione assume toni di vorace sensualità nella XXIII:
Con Il nome si rievoca la potenza creatrice della parola, “notte della terra”, “peso sacrilego” fattosi corpo, attore dell’origine. La notte della terra, l’origine di cui la memoria è immemore, sonnambula: “Cala la palpebra sui sentieri persi” (X). La memoria, perciò il tempo e lo spazio, la morte sono altri temi ricorrenti (XXIV), altri trascendimenti necessari. Non mancano i passaggi più leggeri, quasi dada, i giochi di parole (ovunque), l’ironia, come in Canzone del ballo lunare o in XV, in cui si assiste alla carrellata di alcuni dei poeti più significativi per lo stile e i contenuti della poesia di Bona: Swinburne, Pound, Yeats, Onofri, ai quali sarebbero da aggiungere almeno i nomi di Stefan George, Rilke e Dylan Thomas. Fonti ingombranti che però sono il più delle volte ben amalgamate e filtrate secondo la peculiare sensibilità del poeta. Il poeta stesso, come già accennato, appare non di rado in veste d’attore, maschera, anzi, maschere da risolvere nella forma primigenia (XXXVI), trasfigurando nell’onnipresente, quindi assenza priva di forma, o da sublimare come demoni di un io plurale e beffardo (la “polisemia d’attori”, in Dimora infestata sciolta in “maschere spente”, “Spiritosi osceni avventori morti”). Proprio al processo di trasmutazione allude il “signaculo invitto” di 17 febbraio, il martirio/sacrificio di Giordano Bruno di cui non rimane traccia umana. Una tensione all’oggettività, all’impersonalità, al simbolo, che emerge, in realtà, dal suo opposto, da un’immersione totale nella soggettività, al fondo della quale si trova un’alterità irriducibile all’io, una trascendenza immanente. Da questo punto di vista, La Maschera del Mattino e XXXVI sono componimenti di carattere dichiaratamente alchemico come XXV, Convergenze e battiti e Il Parco Orsini lo sono implicitamente, in profondità. La trasmutazione assume toni di vorace sensualità nella XXIII:
È ambizione tra le fauci
quel che scintilla chiuso
tra porte d’ambra e bifore,
tra colonne d’amore
sul limite della fine.
[…]
Ora sono sirene di miraggio vicino.
In Londra-Genova si raggiunge il parossismo onirico-alchemico:
[…]
Giano incrocia i volti d’una gioia,
una felicità bambina tesa in piuma
d’amore, vola via il senso che consuma.
E peregrina, perenne ridda ai venti
umani nel prematuro credersi vedenti
mentre mena fissa Sfinge nei momenti.
In Porta elementale ci si perde tra le sonorità del ventre marino; in Dimora infestata si intersecano i piani del reale, passato, presente e futuro collimano, i mondi convergono su di un unico piano, “ubiqui”, l’io “in ripostiglio occulto”, “l’Orfeo in camera”, ancora silente, non colto, osserva il via vai delle sue “maschere spente”, spoglie che s’inoltrano in una misteriosa moglie. Misteriosa come tutte le figure femminili, mitologiche o reali, che appaiono fugaci e potenzialmente pericolose, se non veri e propri fantasmi, segni che il poeta prova a fotografare nei propri precordi. Lo squarcio sull’altra parte si dilata anche dal microcosmo della singola poesia al macrocosmo della raccolta, organicamente, chiudendosi con Frequenze dell’ultima tenebra.
Alla fine appare un’uscita dal labirinto, che ri-vela la porta d’ingresso (un altro specchio?):
Scintilla fine come inizio
di tenebra sottile l’alba
luce più forte la sera.
[…]
XLII, Luce nelle mani
Sulle “frequenze dell’ultima tenebra”, che sono saturazione insostenibile di luce, la morte è presagio di prossima rinascita. Il cerchio si chiude, ma il cammino sbocca in altra Via, “giuoco del Gioco sottile” (Rinnovato d’albe simpatetiche): il labirinto/enigma è insolubile.
[…]
Le vele, le giunte paratie sul mare incombusto!
Pronuncio ancor doppio l’enigma di saperti naufragare
Con me attraverso altro nuotare, nel morire,
Canna al vento, di saette impietro la Torre
In visite nel Matto, il Diavolo, la Morte zingara
Mi placa di motti a spirale in lingua raminga.
XLVIII
Giuseppe Di Rosa