La tragica morte dell’imperatoreFlavio Claudio Giuliano (361-363 d. C.), avvenuta il 26 giugno del 363 d. C., durante la campagna contro i Persiani e dopo appena tre anni di governo, troncò sul nascere il suo tentativo di Restauratioreligiosa, ma ebbe l’effetto di consegnarne la figura e l’opera al “mito”. Dal IV secolo ad oggi, infatti, nonostantel’enorme influenza esercitata dalla Chiesa in ogni ambito della vita associata,è fiorita una mole sterminata di biografie e studi di ogni genere sulla figura dell’imperatore, impropriamente denominato, dai cristiani, l’’“Apostata” (1). Già all’indomani della morte, la persona e l’opera di Giuliano suscitarono reazioni diverse – e spesso contrastanti – tra sostenitori e denigratori. Questi ultimi – ovviamente cristiani – contribuirono anche a diffondere la leggenda di un suo presunto suicidio,sostenendo la tesi che l’Augusto aveva consapevolmente rifiutato di indossare l’armatura, perché intendeva morire in battaglia, demoralizzato dall’esito nefasto della campagna contro i Persiani e dall’insuccesso della sua politica religiosa. Questa versione della morte del princeps, oltre a cozzare contro la fermezza e il coraggio di Giuliano, probabilmentenon ha alcuna validità storica e fu diffusa ad arte da Efrem di Nisibi (†373d. C.), padre della Chiesa d’Oriente e autore di alcuni inni religiosi, redatti in siriano, quattro dei quali diretti proprio contro l’Augusto (2). Comunque, i cristiani – o Galilei, come li denominava, sprezzantemente, Giuliano (3) –  accolsero la morte dell’Augusto con gioia, considerandola la giusta punizione divina inflitta ad un esecrabile personaggio, come già era avvenuto per altri imperatori persecutori e per altri empi sovrani citati nell’Antico Testamento. Tale, ad esempio, fu il giudizio di Gregorio di Nazianzo (†390d. C.) – futuro patriarca di Costantinopoli e, durante la gioventù, compagno di studi di Giuliano ad Atene – il quale, a pochi anni dalla morte del princeps, decise di innalzargli un’autentica “stele di infamia”, dedicandogli due epitaffi molto critici (4). I “pagani”, invece, con la scomparsa dell’imperatore, ritennero perduta l’ultima possibilità di un ritorno al culto dei padri e al mos maiorum, e piansero non solo la fine dell’uomo, ma anche la sconfitta della loro causa: ad esempio, il retore Libanio di Antiochia (†393d. C.) – maestro di Giuliano a Nicomedia e convinto sostenitore della politica di Restauratio religiosa del princeps- quando venne a conoscenza della sua morte fu addirittura sul punto di suicidarsi! Tuttavia, benché ritenesse tutto perduto, compose ben tre Orazioni in cui elogiò l’Augusto per la forza del carattere, l’intelligenza e la determinazione con cui aveva perseguito i suoi obiettivi politici (5). Ancora nel V secolo, in un impero romano formalmente cristiano, c’erano “pagani” disposti ad esaltare la figura dell’Augusto come lo storiografo Eunapio di Sardi (†420d. C.) (6).
accolsero la morte dell’Augusto con gioia, considerandola la giusta punizione divina inflitta ad un esecrabile personaggio, come già era avvenuto per altri imperatori persecutori e per altri empi sovrani citati nell’Antico Testamento. Tale, ad esempio, fu il giudizio di Gregorio di Nazianzo (†390d. C.) – futuro patriarca di Costantinopoli e, durante la gioventù, compagno di studi di Giuliano ad Atene – il quale, a pochi anni dalla morte del princeps, decise di innalzargli un’autentica “stele di infamia”, dedicandogli due epitaffi molto critici (4). I “pagani”, invece, con la scomparsa dell’imperatore, ritennero perduta l’ultima possibilità di un ritorno al culto dei padri e al mos maiorum, e piansero non solo la fine dell’uomo, ma anche la sconfitta della loro causa: ad esempio, il retore Libanio di Antiochia (†393d. C.) – maestro di Giuliano a Nicomedia e convinto sostenitore della politica di Restauratio religiosa del princeps- quando venne a conoscenza della sua morte fu addirittura sul punto di suicidarsi! Tuttavia, benché ritenesse tutto perduto, compose ben tre Orazioni in cui elogiò l’Augusto per la forza del carattere, l’intelligenza e la determinazione con cui aveva perseguito i suoi obiettivi politici (5). Ancora nel V secolo, in un impero romano formalmente cristiano, c’erano “pagani” disposti ad esaltare la figura dell’Augusto come lo storiografo Eunapio di Sardi (†420d. C.) (6).
Durante il Medioevo, Giuliano fu oggetto di insindacabile condanna e non pochi lo considerarono una prefigurazione dell’Anticristo apocalittico (7). Ad esempio, si diffuse la leggenda agiografica secondo la quale l’imperatore sarebbe stato ucciso in Persia non da un comune soldato sassanide, ma dall’intervento miracoloso di s. Mercurio di Cappadocia e su ordine della Vergine. L’uccisione di Giuliano ricalcava quella dell’Anticristo – cui Giuliano era assimilato, nella propaganda cristiana – ad opera dell’Arcangelo Michele e il miracolo sarebbe avvenuto grazie alle preghiere di s. Basilio, vescovo di Cesarea (370-379d. C.), amico del già citato Gregorio di Nazianzo oltre che, in gioventù, compagno di studi dell’imperatore. Nella cultura bizantina, la figura di Giuliano fu totalmente cancellata o, al massimo, vituperata, eccetto rari casi, perché l’impero d’Oriente, anche se formalmente erede di quello romano, sul piano istituzionale e culturale era uno stato totalmente cristianizzato e basato su una forte compenetrazione tra potere temporale e spirituale, non a caso ricordata con la dizione, storicamente impropria, di “cesaropapismo” (8). La scarsa considerazione di cui godé Giuliano, nella cultura bizantina, è dimostrata anche dall’incerta memoria della sua sepoltura che, probabilmente, non avvenne mai a Costantinopoli, nel mausoleo costantiniano annesso alla chiesa dei SS. Apostoli, dove riposava anche il cugino, Costanzo II (337-361d. C.), e gli altri imperatori che lo avevano preceduto (9).
Durante l’Umanesimo e il Rinascimento con il recupero, in chiave attualizzante, della “classicità” greco-romana, Giuliano tornò ad essere “di moda”, anche in seguito alla riscoperta dei manoscritti della sua vasta produzione letteraria e filosofica, di cui iniziarono ad essere diffuse le prime edizioni a stampa, la prima delle quali nel 1566 (10). Infatti, durante il Medioevo – a causa della “pessima fama” di cui l’imperatore godeva negli ambienti ecclesiastici – la tradizione manoscritta delle sue opere fu pressoché nulla: d’altronde, la gran parte degli scriptoria era posta sotto l’attenta vigilanza delle istituzioni ecclesiastiche. Nel clima razionalista e anticlericale del XVIII secolo, l’Augusto tornò a godere di enorme considerazione presso gli illuministi come Voltaire (†1778), che lo giudicò uno dei più grandi imperatori, pari solo a Marco Aurelio (†180 d. C.), con cui Giuliano condivideva la passione per gli studi filosofici (11). Anche lo storico illuminista Edward Gibbon (†1794) – autore della monumentale “Storia della decadenza e caduta dell’impero romano” (1776-1788) – ebbe parole di elogio per il princeps che considerò uno dei migliori imperatori romani (12). Tuttavia, proprio durante il ‘700, iniziò quel fenomeno storiografico – destinato a protrarsi a lungo – per cui ogni epoca cominciò a forgiarsi il “suo” Giuliano, a causa del ricorso a criteri interpretativi e valutativi attualizzanti che ne decontestualizzarono la figura. Ad esempio, l’anticlericalismo illuminista vide in Giuliano un anticipatore della lotta all’oscurantismo religioso cristiano, un esempio di tolleranza religiosa, una prefigurazione del principe filosofo settecentesco ostacolando, così, la reale comprensione del tentativo di Restauratio spirituale dell’imperatore che era uomo sommamente pius (13).
Durante il Romanticismo , il princeps fu in parte dimenticato, e alcuni scrittori del tempo – ad esempio, François-Auguste-RenédeChateaubriand (†1848) – ne condannarono il fanatismo anticristiano, equiparato all’anticlericalismo e al materialismo settecentesco, rispetto al quale le correnti filosofiche dell’epoca si ponevano in antitesi (14). Nella seconda metà dell’800 – in pieno positivismo storiografico e nazionalismo – la figura di Giuliano fu rivalutata in chiave patriottica, come esempio di geniale uomo d’armi, difensore di Roma e della sua cultura, garantiti da un ordine politico opposto al mondo “barbaro”, combattendo il quale l’Augusto aveva trovato la morte. Solo nel XX secolo, grazie alla biografia del filologo e studioso delle religioni di origine belga, Joseph Marie Auguste Bidez (†1945), la figura di Giuliano cominciò ad essere inquadrata, scientificamente, nelle dinamiche culturali e politiche del contesto storico che lo aveva espresso: la Tarda Antichità (15). Tuttavia, anche La vie de l’Empereur Julien di Bidez, col tempo, iniziò a subire delle critiche, e l’autore fu accusato di aver giudicato troppo positivamente l’Augusto e di essersi servito, per lo più, di fonti letterarie e documentali a lui favorevoli, come l’opera dello storiografo “pagano” Ammiano Marcellino (†397 d. C.).
, il princeps fu in parte dimenticato, e alcuni scrittori del tempo – ad esempio, François-Auguste-RenédeChateaubriand (†1848) – ne condannarono il fanatismo anticristiano, equiparato all’anticlericalismo e al materialismo settecentesco, rispetto al quale le correnti filosofiche dell’epoca si ponevano in antitesi (14). Nella seconda metà dell’800 – in pieno positivismo storiografico e nazionalismo – la figura di Giuliano fu rivalutata in chiave patriottica, come esempio di geniale uomo d’armi, difensore di Roma e della sua cultura, garantiti da un ordine politico opposto al mondo “barbaro”, combattendo il quale l’Augusto aveva trovato la morte. Solo nel XX secolo, grazie alla biografia del filologo e studioso delle religioni di origine belga, Joseph Marie Auguste Bidez (†1945), la figura di Giuliano cominciò ad essere inquadrata, scientificamente, nelle dinamiche culturali e politiche del contesto storico che lo aveva espresso: la Tarda Antichità (15). Tuttavia, anche La vie de l’Empereur Julien di Bidez, col tempo, iniziò a subire delle critiche, e l’autore fu accusato di aver giudicato troppo positivamente l’Augusto e di essersi servito, per lo più, di fonti letterarie e documentali a lui favorevoli, come l’opera dello storiografo “pagano” Ammiano Marcellino (†397 d. C.).
Dopo la seconda guerra mondiale, l’opera di Bidez fu sottoposta a revisione e iniziarono ad essere pubblicate nuove biografie. Un’inversione di tendenza, rispetto all’opera di Bidez, si ebbe con la pubblicazione, nel 1956, de L’imperatore Giuliano l’Apostata, biografia scritta da Giuseppe Ricciotti (†1964), sacerdote, storico e biblista, ma l’opera di Ricciotti risentiva, inevitabilmente, dell’estrazione sociale e culturale dell’autore e il giudizio sull’imperatore fu, pertanto, totalmente negativo (16). Grande novità, invece, furono le biografie pubblicate a cavallo degli anni ’70 e ’80 dallo storico statunitense, Glen Warren Bowersock, e dalla studiosa greca, Polymnia Athanassiadi-Fowden. In Julian the Apostate – pubblicato nel 1978 -Bowersock ricostruì la figura di Giuliano, analizzando meticolosamente le fonti ostili all’imperatore, soprattutto cristiane, e, per la prima volta, approfondì lo studio del rapporto tra l’Augusto e gli apparati della Res publicacome l’esercito, il senato e la burocrazia. In base alle sue ricerche, lo storico americano imputò il fallimento della Restauratiogiulianea e, più in generale, di tutta la politica legislativa, economica, fiscale e militare dell’imperatore, ad un vero e proprio “sabotaggio” ordito dal senato e dai ceti dirigenti dell’impero ormai ampiamente cristianizzati (17) Invece, il libro della Athanassiadi-Fowden – Julian and Hellenism. An Intellectual Biography – pubblicato nel 1981, si collocava sul piano della storia delle idee e della cultura, concentrandosi soprattutto sulla ricostruzione degli aspetti intellettuali della personalità di Giuliano, attraverso l’analisi della sua sterminata produzione letteraria, senza considerare, però, gli elementi propagandistici ed apologetici delle sue pagine autobiografiche che – secondo la storica – risentivano di un tentativo di autorappresentazione, inevitabilmente unilaterale e poco obiettivo (18). Nel corso del XX secolo, il risveglio di un interesse filologicamente più corretto e severo per Giuliano non ha impedito che anche storici non professionisti ne riscoprissero la figura e ne restassero affascinati, come lo scrittore statunitense Gore Vidal (†2012) che, nel 1964, pubblicò uno dei suoi romanzi storici più famosi – Julian – dedicato proprio alla figura e all’opera dell’imperatore (19). Nell’opera, Vidal ripercorreva tutta la vita di Giuliano, dal massacro della sua famiglia – dopo la morte di Costantino I (306-337 d. C.), nel 337 d. C. – fino alla campagna contro i Persiani, ricostruendone la tormentata e complessa personalità, il tutto in una cornice narrativa d’invenzione, incentrata sullo scambio epistolare tra il retore Libanio di Antiochia e il filosofo Prisco (†398 d. C.), entrambi amici e maestri di Giuliano. Infine, non si può non constatare come l’immagine dell’imperatore abbia risentito anche dei mutamenti della nostra epoca, dominata dalla rivoluzione tecnologica, mediatica e computeristica, che ha influenzato anche la didattica e la ricerca storiografica. Grande, infatti, è la diffusione di materiale di ogni tipo – più o meno scientifico –  su Giuliano, reperibile su Internet, basti pensare all’enciclopedia telematica Wikipedia che ospita alcuni profili biografici dell’Augusto, in ben 52 lingue diverse. Anche su Internet, però, l’imperatore non cessa di suscitare polemiche, con una presenza di contributi fortemente critici, reperibili soprattutto sui siti di ispirazione “cattolica” (20).
su Giuliano, reperibile su Internet, basti pensare all’enciclopedia telematica Wikipedia che ospita alcuni profili biografici dell’Augusto, in ben 52 lingue diverse. Anche su Internet, però, l’imperatore non cessa di suscitare polemiche, con una presenza di contributi fortemente critici, reperibili soprattutto sui siti di ispirazione “cattolica” (20).
Note:
1 – Ossia il “Rinnegato”, per aver violato – con la sua adesione al “paganesimo” – il sigillo sacramentale del battesimo cristiano, ricevuto in gioventù.
2 – Efrem Siro, Jul., II, 16. Per il testo dell’inno, R. Contini, Ancora su Giuliano imperatore nella letteratura siriaca, in A. Marcone (a cura di), L’imperatore Giuliano. Realtà storica e rappresentazione, Milano 2015.
3 – Così, Giuliano chiamava, sprezzantemente, i cristiani, perché la famiglia di Gesù – nato a Betlemme, in Giudea – era originaria di Nazareth, in Galilea.
4 – Gregorio di Nazianzo, Contro Giuliano l’Apostata, a cura di L. Lugaresi, Firenze 1997.
5 – U. Criscuolo, Libanio. Sulla vendetta di Giuliano. Testo, introduzione, traduzione, commentario e appendice, Napoli 1994.
6 – A. Baldini, Ricerche sulla storia di Eunapio di Sardi. Problemi di storiografia tardopagana, Bologna 1984.
7 – S. Conti, La fortuna di un imperatore pagano negli autori cristiani dell’Italia medievale, in M. P. Peri (ed.), Percorsi della memoria, 2, Firenze 2004.
8 – S. Trovato, Antieroe dai molti volti: Giuliano l’Apostata nel Medioevo bizantino, Udine2014, pp. 250 ss.
9 – Giuliano, come’è noto, fu sepolto a Tarso, in Cilicia. Sulla questione, J. Arce, La tumba del EmperadorJuliano, in «Lucentum», 3, (1984), pp. 181 ss., M. Johnson, Observations on the Burial of the Emperor Julian in Constantinople, in «Byzantion», 77, (2008), pp. 254 ss.
10 – E’ del 1566 la prima stampa del manoscritto del “Misopogon” – “L’Odiatore della Barba” – ad opera dello studioso e ugonotto francese Pierre Martini, noto anche come Martinius. Com’è noto, Giuliano fu prolifico scrittore. Tra le sue opere, si ricordino Il “Misopogon”, “Contro i Galilei”, “I Cesari”, le Epistole e le Orazioni.
11 – Voltaire, Dizionario filosofico. Tutte le voci del “Dizionario filosofico” e delle “Domande sull’Enciclopedia”, testo francese a fronte, a cura di D. Felice – R. Campi, Milano, Milano 2013.
12 – E. Gibbon, Storia della decadenza e caduta dell’Impero romano, introduzione di A. Momigliano, traduzione di G. Frizzi, Torino, 1967.
13 – O. Andrei, Giuliano. Da apostata a l’Apostata (sul buon uso dell’apostasia), in A. Marcone (a cura di), L’imperatore Giuliano. Realtà storica e rappresentazione, Milano 2015.
14 – F. R. de Chateaubriand, La chute de l’empire romain, la naissance et lesprogrèsduchristianisme et l’invasiondesbarbares, De Julien à ThéodoseIer, II, 2, Bruxelles 1832.
15 – J. Bidez, Vie de l’Empéreur Julien, Paris 1930, Per l’edizione critica dell’opera di Giuliano, Julian Empereur, Epistulae, leges, poematia, fragmenta, ed. J. Bidez et F. Cumont, Paris 1922.
16 – G. Ricciotti, L’imperatore Giuliano l’Apostata, Milano 1956.
17 – G. Bowersock, Julian the Apostate, London 1978.
18 – P. Athanassiadi-Fowden, Giuliano. Ultimo degli imperatori pagani, Genova 1994.
19 – G. Vidal, Giuliano, traduzione di I. Omboni, Milano 1969.
20 – Sul punto, M. C. De Vita, Un imperatore “con le dita macchiate d’inchiostro”. A proposito di Flavio Claudio Giuliano, in «Intersezioni», 35, (2015).
Tommaso Indelli (Salerno, 1977) è Assegnista di Ricerca in Storia Medievale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno. Ha conseguito, a Pavia, il Dottorato di Ricerca in Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea (XVIII ciclo). Si occupa, prevalentemente, di Storia del Mezzogiorno medievale, longobardo e normanno (VI-XII sec.). Di formazione storico-giuridica, i suoi campi di ricerca sono le problematiche inerenti le strutture e le forme di organizzazione del potere pubblico e statale. Per le Edizioni di Ar ha già pubblicato, Langobardìa. I Longobardi in Italia (VI-XI sec.) (2013), Odoacre. L’irruzione tribale di un uomo di guerra nel paesaggio dell’Impero (2018). Collabora con alcune riviste di settore – come il mensile “Medioevo” – ed è socio della SISMED (Società Italiana degli Storici Medievisti).


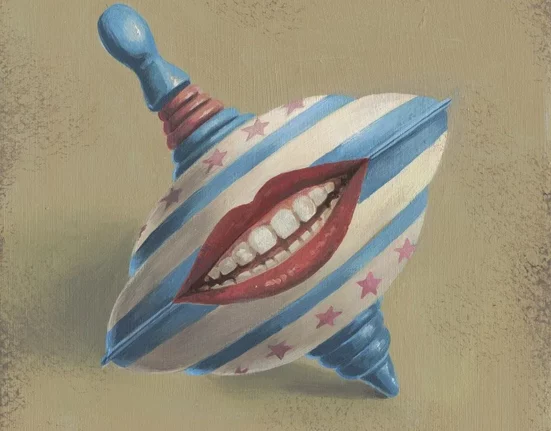
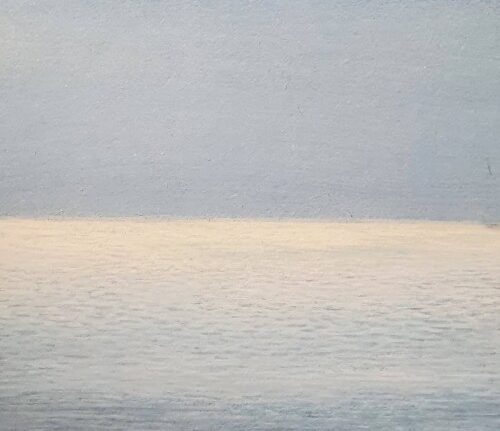
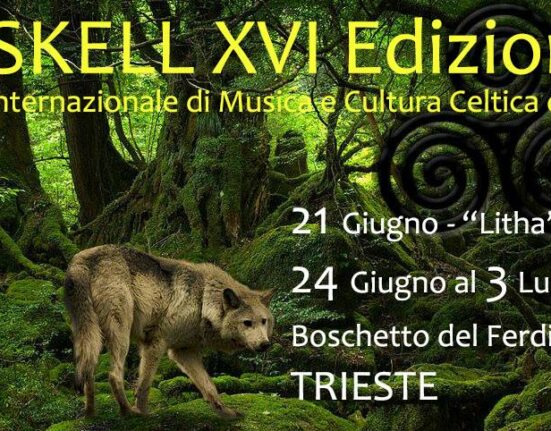



1 Comment