È recente notizia la pubblicazione del libro “Alla ricerca delle origini” di Fabio Calabrese (Edizioni Ritter) nel quale il nostro caro amico, ben conosciuto dai lettori di Ereticamente e da questi molto apprezzato, finalmente consegna alle stampe un sunto dei tanti ed interessanti scritti che nel corso degli anni ha proposto su questo sito. Un evento davvero di grande rilevanza ed un testo assolutamente da consigliare a tutti coloro che hanno il desiderio di approfondire il tema delle nostre origini secondo una chiave di lettura distante dal consueto “politicamente corretto”, purtroppo ormai imperante ovunque. Con grande piacere, quindi, raccolgo il suo gentile invito per una breve recensione del libro, che oltre a riassumere davvero per sommi capi (e nemmeno tutti, visto l’ampissimo ventaglio degli argomenti affrontati) integrerò con qualche riflessione a margine, dal momento che una mera ripetizione dei temi toccati da Fabio Calabrese sarebbe ben poca cosa rispetto alla lettura diretta del suo libro che, ripeto, è assolutamente da consigliare.
L’idea fondamentale attorno alla quale ruota questo ponderoso lavoro è un tema che dovrebbe stare a cuore un po’ a tutti noi: la centralità e l’originalità creatrice della nostra Europa e delle Stirpi che l’abitarono fin dai suoi albori preistorici. Ciò, in opposizione a coloro che invece vorrebbero farne un angolo di mondo sempre in debito culturale e “al traino” di influenze esterne, soprattutto meridionali ed orientali. È dunque un filo che ripercorrerò in ordine cronologico partendo dai primi ritrovamenti di Homo Sapiens, che secondo la parte maggioritaria dell’attuale ricerca accademica si sarebbe originato in Africa e da lì poi diffuso negli altri continenti – da cui il nome “Out of Africa” che è stato attribuito a quest’ipotesi – venendo così a differenziarsi nelle sue varietà locali. Calabrese giustamente contesta la teoria afrocentrica sulla base di una molteplicità di elementi che, per non dilungarci troppo, non possiamo riprendere in questa sede, sottolineando la sua netta preferenza per un quadro evolutivo “multiregionale” (Carleton Coon) che invece attribuisce buona parte dei meccanismi di “razziogenesi” umana alle varie popolazioni non-Sapiens già disseminate sul pianeta (Neanderthal, Denisova, Erectus vari…). La questione toccata dal Nostro è di fondamentale importanza, perché il lettore attento non potrà evitare di porsi la domanda se Homo Sapiens può aver presentato inizialmente una forma unitaria, poi modificatasi a seguito di semplici eventi meticciatori con i ceppi non-Sapiens, o se invece da ciascuno di questi può essersi separatamente originata secondo processi più lenti, profondi ed “evolutivi”: quindi anche presentando delle sensibili differenze razziali fin dal primo apparire e, praticamente, in contemporanea con il fenomeno della sua speciazione biologica. Se vogliamo, è la querelle, molto antica, tra “monogenesi” e “poligenesi” o piuttosto, come personalmente preferisco (per evitare l’ingenua rappresentazione di una, o più, coppie di capostipiti) tra idea “monofiletica” e idea “polifiletica” di origine Sapiens. E’ interessante rilevare come la prima impostazione sembri trovare il consenso di un autore giustamente citato da Calabrese, ovvero Silvano Lorenzoni, ad esempio secondo il quale anche i ceppi australi che sembrano più distanti dallo standard morfologico comune (come i Pigmoidi della fascia tropicale) potrebbero, in ultima analisi, essere riconducibili allo stesso tronco ancestrale di tutte le altre popolazioni mondiali (idea che invece, per inciso, non pare condivisa da pensatori come Julius Evola o Herman Wirth). Inoltre, la scelta tra visuale monofiletica e polifiletica delle origini umane, a mio avviso si collega a un’altra questione, tutt’altro che secondaria, ovvero quella della reale antichità di Homo Sapiens. Perché abbracciare la seconda opzione, ovvero l’origine Sapiens “per evoluzione” dai ceppi considerati “pre-Sapiens”, implica necessariamente che i primi debbano essere meno antichi dei secondi, almeno in larga parte e con l’eccezione di qualche arcaico ramo collaterale prolungatosi fino a tempi relativamente recenti. Un assunto che in genere viene dato per scontato, ma che ritengo andrebbe sottoposto ad una più attenta verifica in relazione a tutti quei reperti (rif. Cremo / Thompson) di antichità talmente elevata da lasciare perplessi i ricercatori più conformisti, visto l’aspetto cosiddetto “moderno” e ben poco grossolano che, al contrario, indicherebbe proprio la forma Sapiens come quella più archetipica dell’intera famiglia ominide (rif. Giuseppe Sermonti).
In merito, poi, alla definizione dell’area geografica dove sarebbe sorto il primo ceppo Sapiens, Calabrese ricorda giustamente l’assenza nei Miti mondiali di qualsivoglia ricordo ancestrale che menzioni una provenienza africana, mentre invece non sono rari quelli che indicano a una direzione ben diversa: il Nord del mondo. Questo è un altro punto fondamentale sul quale credo valga la pena soffermarsi. Il nostro amico sottolinea infatti come siano state proprio le difficili condizioni boreali a forgiare almeno un particolare ramo umano, cioè quello “europide” – ovvero noi “bianchi” ed Europei nell’accezione più ristretta di quella attribuita al più ampio concetto di “caucasoidi” – confermandone quindi l’impostazione tendenzialmente polifiletica/multiregionale: e dunque presupponendo un Nord dalle condizioni climatiche difficili e non molto dissimili da quelle odierne. Un’idea certamente interessante e che giustificherebbe l’insorgenza, ad esempio, di importanti fenomeni di depigmentazione, ma che ritengo potrebbe essere utilmente, e non contraddittoriamente, integrata in un quadro ancora più profondo, dove vi sarebbe posto anche per “un altro Nord”: quello che, prima ancora, godette di una situazione climatica ben più favorevole. Se infatti i miti di una primordiale “Età dell’Oro” e di una “Eterna primavera” degli albori sono riusciti a giungere fino a noi, forse ciò potrebbe alludere ad una fase nella quale i primi ceppi Sapiens furono in grado di condurre un’esistenza non precaria anche in aree ad altissima latitudine: ad esempio la Beringia (tra Siberia orientale ed Alaska) o l’enorme piattaforma continentale nordeurasiatica, ora sommersa dal Mar Glaciale Artico, che studi recenti indicherebbero aver ospitato, con la Siberia settentrionale, una biomassa quantitativamente paragonabile addirittura a quella della savana africana. Tale contesto bio-climatico avrebbe quindi visto il primigenio ceppo Sapiens prosperare in condizioni letteralmente “edeniche”, oltretutto in una posizione “polare” o “circum-polare” – non scissa da una controparte di carattere spirituale (rif. René Guenon) come ad esempio la Tradizione indù ricorda per il Krita Yuga – e senza ancora l’affanno di una pressione selettiva con la quale dover drammaticamente fare i conti. Quest’ultima potrebbe essere entrata in gioco più pesantemente in un momento successivo, quando la Prima Età fini fra 35 e 40.000 anni fa (rif. Gaston Georgel) in concomitanza con alcuni eventi geofisici di dimensione planetaria confermati anche dalla ricerca attuale (eruzione dei Campi Flegrei, crollo del 75% del campo magnetico terrestre) che, tra l’altro, dovettero assestare un colpo fatale ai coevi ceppi neandertaliani, infatti estintisi di lì a qualche millennio. Una selezione che quindi appare soprattutto implacabile – e necessaria! – sentinella nei confronti di rami deviati e fenotipi aberranti, evidenziandone dunque una funzione soprattutto “conservativa” più che “migliorativa” per “lento accumulo” secondo la prospettiva materialistico-darwiniana (rif. Giuseppe Sermonti): con la conseguenza, in questa prospettiva, di svincolare in parte l’uomo dalla sua dimensione naturalistico-grossolana e di lasciare una certa libertà di azione anche a fattori formativi di ordine più sottile. Una tale impostazione risponde quindi a un’idea più larga del concetto di Razza, dispiegata in Corpo-Anima-Spirito come elaborata da Julius Evola, anche se, per inciso, la stessa andrebbe a mio parere sottoposta a una certa riflessione nelle sue influenze bachofeniane e nel ruolo attribuito all’ultimo elemento del ternario, lo Spirito: il quale, assolutamente incondizionato, dovrebbe trascendere i meccanismi “razziogenetici” in senso stretto, forse più pertinenti all’ambito mediano (psichico-animico-elementale) – e, a caduta, a quello corporeo – come giustamente ebbe a rilevare anche Adriano Romualdi.

Se dunque l’Uomo sorse nell’ecumene artico, da cui i rimandi delle molteplici Tradizioni mondiali (un ottimo riassunto in tal senso è costituito dal classico “Paradise found” di William Fairfield Warren), è il soprattutto il settore nordeurasiatico quello dove probabilmente si enucleò la Razza Bianca. Questa poi si divise in ulteriori sottogruppi sviluppando diverse famiglie etno-linguistiche, passaggio che ci porta a un altro tema fondamentale toccato da Calabrese: quello degli Indoeuropei – o Ariani, secondo l’antica denominazione poi caduta in discredito – la cui genesi, tra parentesi, in questo quadro si trova in buon accordo con le note ipotesi “nordiche” di Bal Gangadhar Tilak o le più recenti di Felice Vinci (“Omero nel Baltico”). Ma, come ben sappiamo, l’attuale ricerca accademica considera l’opera tilakiana solo una mera bizzarra curiosità, anche se d’altro canto non si può dire sia stata ancora data una risposta definitiva al tema della localizzazione dell’area d’origine (l’Urheimat), delle direttrici migratorie e della profondità temporale da attribuire ai nostri Avi più diretti. Una delle ipotesi più discusse è quella che fu formulata negli anni ’80 del secolo scorso dall’archeologo britannico Colin Renfrew, secondo la quale gli Indoeuropei corrisponderebbero ai primi agricoltori provenienti dall’Anatolia nel Neolitico: zona che peraltro dovette rappresentare solo la porzione occidentale di un territorio più esteso, comprendente anche il Levante (Siria-Libano-Palestina) e i Monti Zagros (tra Iran e Iraq), dove sarebbe iniziata la transizione da un’economia di caccia-raccolta (paleo-mesolitica) a una agricola (neolitica). A ciascuna di queste altre due sotto-zone, secondo l’ipotesi di Renfrew, sarebbe riconducibile l’origine di altrettante famiglie linguistiche, ovvero l’afroasiatica (o “camito-semitica” secondo la denominazione più datata) nel Levante, e l’elamo-dravidica tra i Monti Zagros: ma lo stretto contatto fra le tre sub-aree presupporrebbe per tutte, a livello globale, un proto-linguaggio ancora più arcaico e antenato diretto delle tre famiglie “sorelle”, che potrebbe essere individuato nell’antico “Nostratico” già a suo tempo ipotizzato dai linguisti più innovativi. Credo che le perplessità di Calabrese sull’identificazione dei primi Indoeuropei con gli agricoltori anatolici siano senz’altro condivisibili, mentre mi riservo qualche riflessione aggiuntiva sul discorso del Nostratico, perché ritengo che la correlazione di quest’ultimo con la teoria dell’origine mediorientale degli Indoeuropei non rappresenti l’unica opzione possibile.
Va infatti detto che un primo abbozzo dell’idea di collegamento filogenetico tra indoeuropeo ed altre famiglie linguistiche – in particolare il camito-semitico, l’uralico e l’altaico – in effetti è molto precedente all’ipotesi di Renfrew degli anni ‘80, in quanto venne formulata già ai primi del ‘900 dal danese Holger Pedersen; come segnala Fabio Calabrese, quest’ipotesi venne poi sviluppata soprattutto dai due linguisti russi Vladimir Illič-Svityč e Aharon Dolgopolskij, ma comunque negli anni ’60 dello scorso secolo. Peraltro, proprio Renfrew valutò che la macro-famiglia nostratica si sarebbe formata già circa 27.000 anni fa (rif. Riccardo Ambrosini), quindi in tempi molto precedenti al momento d’inizio dell’agricoltura in Anatolia, che giunse in Europa solo 8-9.000 anni fa: il che dovrebbe rendere l’idea di un netto scollamento tra i due eventi. Credo inoltre sia piuttosto interessante sottolineare che l’idea del Nostratico fu successivamente sottoposta ad una serie di revisioni soprattutto ad opera di Joseph Greenberg, in quanto si rilevò come l’Indoeuropeo appaia morfologicamente molto più vicino alle famiglie ciukcio-camciadali (estremo oriente siberiano) ed eschimo-aleutina (Alaska ed America artica) rispetto alle più meridionali camito-semitica ed elamo-dravidica, il che condusse ad un proposta di ridefinizione del macro-aggregato linguistico di partenza con la sostituzione delle ultime due famiglie con le prime due: il nuovo raggruppamento venne così definito “Eurasiatico”, dalla connotazione nettamente più nordica e linguisticamente molto più convincente, anche a parere del nostraticista russo Sergei Anatolievič Starostin. È peraltro di rilievo anche il fatto che lo stesso Dolgopolskij invece di utilizzare il termine “Nostratico” preferì usare quello di “Boreale”. Il tutto, in definitiva, per collocare l’Indoeuropeo nell’ambito di un insieme di più vasta scala che – a prescindere se definito “Nostratico”, “Eurasiatico”, “Paleoboreale” o quant’altro – non è comunque incompatibile con l’ipotesi di una nostra remota origine nordica. Aggiungerei anche che la famiglia linguistica che, tra tutte queste, sembra in assoluto più vicina alla nostra è quella uralica, per cui pare plausibile che nell’ambito del “Paleoboreale” (o “Eurasiatico”, che dir si voglia) si possa ipotizzare un ramo più occidentale, inizialmente indiviso, che è stato definito come “Indo-Uralico” e dalle caratteristiche agglutinanti, come vedremo in seguito; solo successivamente, nella diramazione indoeuropea, questi dialetti vennero a modificarsi in senso flessivo (rif. Herman Wirth). Il quadro delle origini ario-europee, quindi, potrebbe benissimo rimanere saldamente ancorato al Nord o al Nord-Est anche nel contesto di una macro-famiglia di più ampia dimensione. E ciò, respingendo chiaramente la teoria anatolica di Colin Renfrew, ma non per questo accettando quella “kurganica” di Marija Gimbutas, che è rifiutata da Adriano Romualdi e anche da un altro valido studioso menzionato da Calabrese, ovvero Ernesto Roli: quella della Gimbutas è infatti un’ipotesi ancora troppo poco nordica (steppe della Russia meridionale) e, aggiungo io, collegata a un quadro cronologico ancora troppo recente (Calcolitico, quindi addirittura meno profondo di quello neolitico di Renfrew). Perché, a mio avviso, lo spostamento dell’etnogenesi indoeuropea in tempi molto più remoti, cioè a livello praticamente paleolitico – come proposto, seppure con modalità e percorsi non identici, da un ventaglio comunque non trascurabile di ricercatori (ad esempio: Alinei, Costa, Dolgopolskij, Durante, Georgiev , Kruskal, Kuhn, Sera, Obermaier, Otte) – potrebbe forse contribuire ad inquadrare sotto una diversa luce un altro tema essenziale sul quale Fabio Calabrese opportunamente si sofferma, ovvero quello delle popolazioni “mediterranee” o “preindoeuropee” di substrato (Pitti, Iberi, Acquitani, Liguri, Etruschi, Pelasgi, Minoici…) che popolarono il nostro continente prima degli Indoeuropei “storici” (Italici, Celti, Germani, Elleni, Illiri, ecc…). I cosiddetti “preindoeuropei”, cioè, invece di appartenere ad un raggruppamento etnico completamente estraneo al nostro, in una diversa ottica interpretativa potrebbero invece rappresentare gli eredi di una stratificazione verificatasi in tempi più antichi della nostra stessa famiglia etnolinguistica (rif. Hans Krahe e le analisi in tal senso della scuola di Tubinga sui substrati e sull’idronimia europea): una stratificazione che, magari, potrebbe essersi dispiegata in più scansioni.
Provo a spiegarmi meglio. Herman Wirth, e per certi versi anche Julius Evola, utilizza il termine “ariano” in un’accezione un po’ diversa rispetto a quella di “indoeuropeo”, ovvero secondo una connotazione di carattere più razziale che etnolinguistica, ma soprattutto in una prospettiva più antica: considerando cioè la compagine indoeuropea in senso stretto come una sua più tarda derivazione, glottologicamente in direzione flessiva a partire da una struttura paleo-artica che presentava una tipologia agglutinante. Ebbene, prendendo spunto dalle idee di Herman Wirth, credo si potrebbe sintetizzare il quadro generale in un’ottica – mi si passi il termine – di “arianità estesa”, o anche “giapetica” considerando l’indubbia sovrapponibilità fra il Giapeto del Mito ellenico, padre di Atlante, e lo Jafet del testo biblico. Al quale, non a caso, per dimora era stata donata l’immensità (Georges Vacher de Lapouge) – tanto che il suo stesso nome allude al concetto di “espansione, diffusione” – oltre ad evidenziare un maggior numero di figli rispetto ai due fratelli citati nelle scritture veterotestamentarie. Sem e Cam, oltretutto, appaiono tra loro chiaramente più vicini sia da un punto di vista glottologico (la famiglia “camito-semitica” o, come oggi è stata ridenominata, “afroasiatica” è un’unità linguistica acclarata) che geografico (condividono entrambi la costa meridionale del Mediterraneo, lasciando al solo Jafet/Giapeto quella settentrionale e tutto l’entroterra europeo). Senza comunque dimenticare, come opportunamente ricorda Felice Vinci, che il padre comune dei tre fratelli, Noè, presenta delle caratteristiche fenotipiche chiaramente nordiche. Per cui ecco di seguito un piccolo sunto di questa visuale, che gli argomenti toccati in questa recensione mi offrono l’occasione di anticipare brevemente e forse in futuro potrò esporre in modo più esteso con una serie di articoli.
In estrema sintesi: a partire da una meta-popolazione nordeurasiatica (denominazione che può assumere il doppio significato della componente autosomica “ANE” presente in larga parte del genoma europeo, ma anche della superfamiglia linguistica boreale, nettamente preferibile a quella “nostratica” vista sopra), già sensibilmente depigmentata ma forse non ancora “nordico-leptomorfa” in senso stretto (Biasutti), il ramo più occidentale, “Indo-Uralico”, può aver sostato in area euro-nordorientale, ad esempio tra le penisole di Kola e di Jamal, fino all’Ultimo Massimo Glaciale wurmiano di circa 20.000 anni fa (acronimo “LGM”). A mio avviso, questa fase potrebbe essere definita come “giapetico-unitaria” o anche come “Ario-Uralica”. Gli eventi dell’LGM avrebbero però incrinato tale unità, separando i gruppi rimasti in sito (Uralici) da quelli migrati verso sud e sud-ovest (Paleo-Indoeuropei) sia per via scandinavo-costiera (a ovest della calotta wurmiana) ma soprattutto, in questa prima fase, per via baltico-continentale (a est della stessa), portando nel cuore del nostro continente un linguaggio ancora a livello “pre-flessivo” (Adrados), tracce linguistiche nell’arcaicità del sotto-gruppo baltico rispetto agli altri, e residui cultuali di tipo sciamanico (Benozzo, Colli, Corradi-Musi, Eliade, Ginzburg…). Incontri-scontri in varie aree ed alterni esiti con popolazioni occidentali “rosse”, meno depigmentate, cromagnoidi (“Fomori” del Mito celtico), ed autosomicamente in prevalenza “WHG” (“cacciatori-raccoglitori occidentali”) ricordati nell’epopea del sesto Avatara di Vishnu, Parashu-Rama, e nella saga norrena del problematico rapporto tra Asi (boreali) e Vani (occidentali). Concentrazione di larga parte delle popolazioni paleo-indoeuropee di traiettoria baltico-continentale nel refugium franco-cantabrico, quindi lungo un gradiente genetico nordest-sudovest forse riconoscibile oggi nella “seconda componente principale europea” (Cavalli Sforza). Enucleazione in sito della cultura solutreana (Gioacchino Sera) ed “esplosione” della stessa, con riflessi fino alla cultura Clovis nordamericana (Facchini, Greenman) e, attraverso Gibilterra, verso il nord-Africa (Guanci, Iberomaurusiani), con ingresso “imponente” (Biasutti) del carattere del biondismo tra Berberi, Libi e Cabili (Frobenius, Parenti). Conseguente enucleazione atlantico-nordafricana del gruppo linguistico camito-semitico unitario e migrazione verso il (non “dal”) Medio Oriente (Ehret, Greenberg), con separazione del ramo semitico di provenienza occidentale – anche dal punto di vista della tradizione di riferimento (Guénon) – ma non senza probabili episodi di meticciamento anche con elementi boscimanoidi al tempo ancora stanziati fino alla bassa valle del Nilo (Acerbi, Coon). Nel frattempo, in area franco-cantabrica e pirenaica, il contatto dei Paleo-Indoeuropei di provenienza baltico-continentale con gli autoctoni “WHG” etnicamente dene-caucasici (i “Vasconici”, residuanti oggi nei Baschi: ovvero, una stratificazione artica ancora precedente a quella nordeurasiatica e, a oriente, originante i Sumeri – rif. Wirth e Dugin) induce alcune rilevanti modifiche linguistiche tali da marcare una certa discontinuità con le precedenti popolazioni “Ario-Uraliche”, quindi avviando una seconda fase definibile come “Ario-Atlantica” che ne rappresenterebbe una sorta di “filiazione” (ricordavo infatti che Atlante è figlio di Giapeto): fase che appunto corrisponde alla ramificazione “mediterranea” e a tutte quelle popolazioni ritenute “preindoeuropee”, opportunamente ricordate da Fabio Calabrese, che poi si sarebbero espanse soprattutto lungo la direzione “orizzontale” ovest-est (Evola) probabilmente in connessione con la cultura tardo-paleolitica del Maddaleniano (Kozlowski). Infine, come ultima scansione, movimenti residuali nel quadrante soprattutto scandinavo-costiero – area dove nel frattempo si sarebbero verificati anche importanti eventi di carattere “fusionale” tra Boreali ed Occidentali (con consolidamento di vari sotto-tipi razziali, tra i quali Nordici-leptomorfi e i Falici più massicci) – ed interessamento di settori nord-atlantici al tempo emersi (Hapgood, Maltesta) con ingresso di popolazioni ricordate come “Tuatha Dé Danann” nel Mito celtico. Ma i tempi ormai tardo-pleistocenici e di fusione glaciale, con il conseguente inabissamento di tali settori sia a causa di fenomeni traumatici (la “frana di Storegga”) che più lenti e graduali (progressiva sommersione del Doggerland, attuale Mare del Nord), spingono queste popolazioni a migrare, ora, soprattutto lungo la direttrice “trasversale” (Evola) nordovest-sudest, inaugurando quindi la terza fase del ciclo giapetico – dopo l’iniziale “Ario-Uralica” e l’intermedia “Ario-Atlantica” – e che definirei “Ario-Europea”: portando quindi nel nostro continente linguaggi ormai definitivamente flessivi, “indoeuropei” in senso stretto e che da questo specifico, e più recente, punto di vista, incontrano popolazioni considerabili, sì, come “preindoeuropee”, ma che in effetti non sono altro che stirpi “diversamente derivate dallo stesso ceppo” (Evola). Quest’ultima migrazione da nordovest a sudest, probabilmente la più cospicua in termini demografici, sembra ben sovrapponibile alla “prima componente principale europea” (Cavalli Sforza) letta però in chiave diametralmente opposta rispetto alla ricerca accademica (e la cosa non sorprende…) secondo la quale, invece, essa rappresenterebbe il movimento da sudest verso nordovest dei contadini anatolici nel Neolitico: sennonché tale interpretazione non pare molto coerente né con l’ipotetica area di partenza del movimento, che dalle rilevazioni sembrerebbe più mesopotamica che anatolica (Villar), né con la stima di derivazione del genoma europeo, che in larghissima parte non deriverebbe dal Neolitico ma dal Paleolitico (Alinei, Cavalli Sforza, Olson, Sykes, Wells). Senza considerare, oltretutto, che l’introduzione delle tecniche agricole forse non si verificò nemmeno in maniera così massicciamente demica, come inizialmente ipotizzato dal modello “ad onda di avanzamento” (Ammerman / Cavalli Sforza), ma che vi fu ampio spazio a una trasmissione di tipo culturale delle stesse (Zvelebil), se mai queste, come accenna anche Fabio Calabrese, addirittura non furono in buona parte perfezionate proprio nella nostra Europa.
Ma è sempre il solito concetto: “ex Oriente lux” dev’essere, e così la cultura, la ricerca, l’informazione, la divulgazione “mainstream” spingono in quella direzione, come giustamente denuncia il nostro amico nel suo bel libro. E quindi si dimenticano elementi di significativa importanza, come ad esempio la totale originalità del megalitismo europeo (forse, aggiungo io, originato proprio dal movimento nordatlantico “trasversale”) che la cosiddetta “rivoluzione del radiocarbonio” ha assolutamente isolato da ogni influenza mediorientale, regalandoci siti di una forza e di una magnificenza – quali Stonehenge, Newgrange, Externsteine, ma non solo – che ben poco hanno da invidiare alla savana o al deserto. E su questa linea Calabrese giustamente prosegue, ricordandoci anche altri elementi per nulla trascurabili, come ad esempio la probabile primarietà delle popolazioni centro-nordeuropee nella domesticazione degli animali da pascolo e nell’impiego del latte come alimento anche per gli adulti (confermato dall’alta tollerabilità al lattosio che il nostro continente evidenzia in rapporto alle altre aree del pianeta). Analoghi elementi di innovazione nelle attività economiche potrebbero essere ravvisabili anche nel primo utilizzo dei metalli, dal momento che quello più anticamente usato è il rame, e non sfuggirà l’importanza del fatto che le più antiche miniere al mondo di rame si trovano a Rudna Glava nella ex Jugoslavia. Ma – mi si conceda il gioco di parole – “dall’estrazione (dei metalli) all’astrazione (dei concetti)” il passo è davvero breve. Infatti, non è solo nell’ambito delle attività meramente produttive che il nostro continente può vantare una funzione di chiara originalità creativa, ma anche in quelle artistiche ed intellettuali, come ci ricorda Calabrese che menziona la sorprendente scoperta delle tavolette di argilla rinvenute a Turda, in Romania, i cui segni incisi forse rappresentano la primissima traccia, in assoluto, di una proto-scrittura. O l’enigmatico “disco di Nebra” rinvenuto in Germania e datato a circa 3600 anni fa, che è riconosciuto essere la più antica rappresentazione del cielo archeologicamente attestata. E questi sono solo alcuni degli elementi che Calabrese ha raccolto e ben descritto.
Sono tutti prodotti della creatività e dell’ingegno europeo, dei suoi popoli, in larga parte indoeuropei e dei quali il ricordo più nitido è ovviamente quello relativo ai gruppi collegati all’ondata migratoria più recente, ovvero la “trasversale” di direzione nordovest-sudest, che avrebbe portato nelle sedi storiche i vari Italici, Germani, Illiri, Traci, Elleni, Celti (molto ampio lo spazio che Fabio Calabrese dedica a questi ultimi), ecc…
Varie ondate, varie migrazioni, varie genti, ma tutte in fondo appartenenti allo stesso ceppo razziale: quello europide. Ed è attorno a questo punto che mi avvio alla conclusione con una riflessione finale.
È indubbio che gli altri continenti presentano al loro interno fenotipi estremamente eterogenei, molto più del nostro. Tuttavia l’Europa non è esteticamente uniforme, ma è arricchita da una piacevole varietà di tipi lievemente diversificati (nordici, falici, atlantici, mediterranei, alpini, adriatici, baltici…), anche nella pigmentazione di occhi e capelli, che però non intaccano l’impressione di fondo di una stretta vicinanza di base. Una compattezza bio-antropologica che si accompagna anche ad un’analoga, straordinaria, omogeneità linguistica. Infatti, circa il 97% di noi parla lingue appartenenti alla famiglia indoeuropea, a sua volta suddivisa in diversi sottogruppi (neolatino, celtico, germanico, baltico, slavo…), mentre solo il rimanente 3% si divide tra idiomi caucasici, il basco e lingue ugro-finniche (queste ultime, peraltro, forse nostre “cugine” non troppo lontane, come abbiamo visto). È uno sbilanciamento non riscontrabile in altri continenti, molto più frammentati del nostro pure sotto questo aspetto. La stessa area formativa primordiale delle lingue indoeuropee – la nostra “Urheimat” – anticamente si enucleò in queste terre, anche se come detto la sua collocazione è ancora oggetto di discussione: ma che sia stata in qualche zona dell’Europa centrale o orientale, nelle steppe tra Mar Nero e Mar Caspio (la “teoria kurganica” di Marija Gimbutas), nella penisola balcanica, o in settori più nordici (avrete capito che io propendo per quest’ultima ipotesi), è tuttavia abbastanza sicuro che la Patria dei nostri Avi abbia trovato posto al di qua degli Urali. E i dati genetici sembrerebbero andare in questa stessa direzione. Come detto più sopra, vari ricercatori hanno infatti stimato che proprio dai tempi paleolitici deriverebbe la maggior parte del nostro patrimonio genetico: per alcuni fino al 90%, comunque non meno del 65% per altri. Quindi la maggior parte delle nostre radici sono ben piantate, profonde e non derivano, se non forse in minima misura, da qualche rapida “spazzata” nomadica di pochi millenni fa. E, dato forse ancora più importante, in rapporto al genoma degli altri continenti, Cavalli Sforza ci segnala che quello europeo è il più omogeneo di tutti.
È, questo, un elemento molto significativo che, assieme alle altre considerazioni di carattere linguistico e razziale, io credo possa farci concludere che se al mondo vi è una terra con una sua ben precisa specificità, quella è l’Europa. E se vi è una Stirpe con una sua ben definita identità la risposta è altrettanto chiara: siamo noi Europei.
E l’ottimo libro del nostro Fabio Calabrese ha il grande pregio di non farcelo dimenticare.






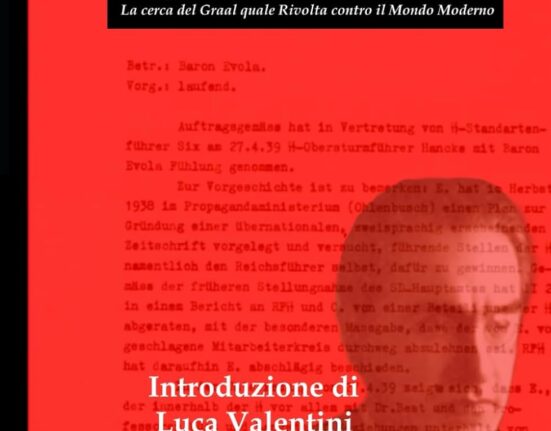
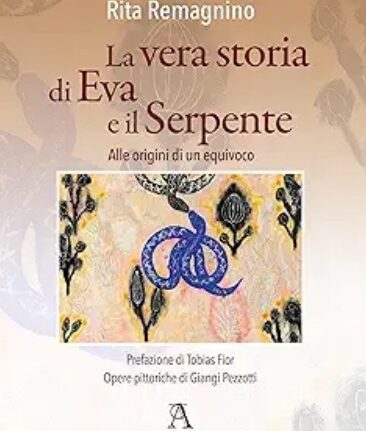
15 Comments