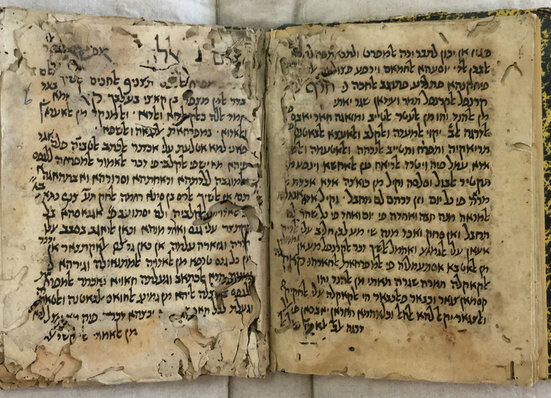di Nicola Spanu
Oggi ricorre il Natale di Roma, ovvero la data che commemora la fondazione dell’Urbe, avvenuta, secondo la datazione tradizionale, proprio il 21 d’Aprile. Leggiamo infatti nella Vita di Romolo 12.1 di Plutarco (ed. Bernadotte-Perrin):
ὅτι μὲν οὖν ἡ κτίσις ἡμέρᾳ γένοιτο τῇ πρὸ ἕνδεκα καλανδῶνΜαΐων, ὁμολογεῖται, καὶ τὴν ἡμέραν ταύτην ἑορτάζουσι Ῥωμαῖοι, γενέθλιον τῆς πατρίδος ὀνομάζοντες. (E’ un fatto universalmente accettato che la fondazione [di Roma] avvenne il 21 d’Aprile, e questo giorno i romani celebrano con una festa chiamandolo Natale della propria Patria).
Anche oggi la nascita di Roma verrà celebrata nei modi più diversi da chi ritiene di poter trovare in essa le radici ultime della propria identità, come se Roma rappresentasse un porto sicuro per chi, volente o nolente, si trovi a navigare nel mare tempestoso di una società che sembra aver smarrito, non tanto e non solo la coscienza delle proprie radici (e quindi del legame con Roma quale culla della cività occidentale), ma anche il concetto stesso di identità nelle sue disparate declinazioni: etnica, oggi che l’immigrazione di massa di disperati (divenuti strumento inconsapevole di decisioni prese altrove, e non certo nel loro interesse) viene usata come grimaldello per scardinare la coesione sociale di una società, quella italiana ed europea, devastata da una crisi economica senza precedenti, e quindi priva degli strumenti economici e politici per affrontare nel modo migliore un fenomeno di tale portata; linguistica, oggi che l’inglese sembra erodere la coesione interna di lingue, come l’italiano, non totalmente asservibili all’utilitarismo, praticismo ed anti-intellettualismo di matrice anglosassone; economica, oggi che gli Stati, in virtù del vincolo di subordinazione che li lega ad organismi sovranazionali privi di qualsiasi connessione con i popoli su cui esercitano il loro illimitato potere decisionale, sono stati privati della facoltà di gestire la propria economia in vista del bene supremo della nazione; culturale, oggi che la cultura – nel senso etimologico del termine, che rimanda alla parola latina colere ovvero “coltivare” se stessi al fine di diventare non tanto, kantianamente, un “uomo buono”, ma, prima di tutto, un buon padre di famiglia ed un buon cittadino, responsabile per sé e per gli altri – sembra si sia ridotta a mero entertainment ovvero intrattenimento che ottunde la facoltà critica dell’uomo e semplicemente gli è utile per evadere per qualche ora dal senso di alienazione derivante dalla società disumana in cui è costretto a vivere e lavorare; ed infine religiosa, oggi che non la religione in senso generale (le cui ultime ma vitali manifestazioni sono tenute in vita, nonostante tutto e tutti, da pochi uomini coraggiosi), ma il vero e proprio senso del sacro sembra scomparso dall’orizzonte dei moderni, la cui ὔβρις non accetta quel Limite (πέρας) che il sacro pone ai desideri smodati dell’uomo, stabilendo ciò che, appunto, è sacro ed inviolabile e ciò che è profano, ciò che ha fondamento nella legge divina (fas) e ciò che di essa è la negazione (nefas).
coesione sociale di una società, quella italiana ed europea, devastata da una crisi economica senza precedenti, e quindi priva degli strumenti economici e politici per affrontare nel modo migliore un fenomeno di tale portata; linguistica, oggi che l’inglese sembra erodere la coesione interna di lingue, come l’italiano, non totalmente asservibili all’utilitarismo, praticismo ed anti-intellettualismo di matrice anglosassone; economica, oggi che gli Stati, in virtù del vincolo di subordinazione che li lega ad organismi sovranazionali privi di qualsiasi connessione con i popoli su cui esercitano il loro illimitato potere decisionale, sono stati privati della facoltà di gestire la propria economia in vista del bene supremo della nazione; culturale, oggi che la cultura – nel senso etimologico del termine, che rimanda alla parola latina colere ovvero “coltivare” se stessi al fine di diventare non tanto, kantianamente, un “uomo buono”, ma, prima di tutto, un buon padre di famiglia ed un buon cittadino, responsabile per sé e per gli altri – sembra si sia ridotta a mero entertainment ovvero intrattenimento che ottunde la facoltà critica dell’uomo e semplicemente gli è utile per evadere per qualche ora dal senso di alienazione derivante dalla società disumana in cui è costretto a vivere e lavorare; ed infine religiosa, oggi che non la religione in senso generale (le cui ultime ma vitali manifestazioni sono tenute in vita, nonostante tutto e tutti, da pochi uomini coraggiosi), ma il vero e proprio senso del sacro sembra scomparso dall’orizzonte dei moderni, la cui ὔβρις non accetta quel Limite (πέρας) che il sacro pone ai desideri smodati dell’uomo, stabilendo ciò che, appunto, è sacro ed inviolabile e ciò che è profano, ciò che ha fondamento nella legge divina (fas) e ciò che di essa è la negazione (nefas).
Anche oggi, giorno del suo Natale, Roma eserciterà con forza il suo potere di attrazione sugli uomini che ad essa guardano, qualunque sia la loro identità etnica, linguistica, economica, culturale e religiosa, in quanto essa è la forza che ha il potere di ricondurre a sé le differenze valorizzandole senza annullarle o livellarle, come ha dimostrato nel corso della sua storia.
Sebbene infatti sia innegabile che l’espansionismo romano abbia avuto anche una dimensione meramente economica e politica, legata alla brama di potere e ricchezze delle sue classi dominanti, spesso manifestantesi nello sfruttamento economico delle popolazioni vinte (pensiamo per es. ai soprusi commessi dal pretore Verre contro i cittadini siciliani, dei quali Cicerone prenderà con successo le difese nelle sue celebri orazioni intitolate In Verrem), è altresì innegabile che Roma fu anche in grado di trasmettere valori di civiltà ai popoli con cui entrava in contatto e di elevarne la condizione economica e spirituale grazie alla sua difesa delle vie commerciali terrestri e marittime, le quali facilitavano non solo gli scambi di merci, ma anche quelli di idee. Un discorso analogo si potrebbe fare in riferimento all’atteggiamento di Roma nei confronti delle religioni dei popoli da essa conquistati. Sebbene Roma, contrariamente a quanto sostenuto dalla storiografia di matrice illuminista, non fu affatto sempre tollerante nei confronti delle religioni dei popoli da essa sottomessi (pensiamo, a titolo esemplificativo, al massacro dei druidi compiuto nell’odierna isola di Anglesey da Gaio Svetonio Paolino nel 60 o 61 d.C. e di cui parla Tacito nei suoi Annales 14.30 [ed. Fisher]: posthac impositum victis excisique luci saevis superstitionibus sacri [e dopo fu imposto ai vinti che venissero fatti a pezzi i boschetti consacrati a selvagge superstizioni]) o con cui entrò in contatto (pensiamo alla repressione violenta del culto di origine greca di Dioniso sancita dal senatus consultum de Bacchanalibus del 186 a.C. o ai provvedimenti senatorii contro la diffusione del culto di Iside ed Osiride degli anni ’50 del I secolo a.C. o la feroce opposizione ad esso da parte di Tiberio, di cui ci parla Flavio Giuseppe nelle sue Antiquitates Judaicae 18.3.4 [ed. Niese], o l’uccisione degli imperatori che volevano istituire il culto del monarca quale dio già in vita [come, per es., Caligola, Domiziano, Commodo] o modificare in senso ellenistico-orientale i mores [come Eliogabalo]), tuttavia essa fu anche in grado di elevarsi al concetto di religio universalis, della quale le differenti religioni dell’impero si manifestavano come espressione particolare.
Esempio di ciò è, per esempio, l’editto di Costantino e Licinio del 313 d.C., nel cui prologo è scritto (in Lattanzio, De mortibus persecutorum, XVIII, 2 [ed. Fritzsche]): “… ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset, quod quicquid <est> divinitatis in sede caelesti, nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere” ([…] e daremo ai cristiani e a tutti la libera facoltà di seguire la religione che ognuno preferisca, poiché, qualunque sia la divinità che è nei cieli, verso di noi e quanti sono posti sotto la nostra egida essa possa essere pacifica e propizia) oppure quanto riportato dal filosofo romano Macrobio, il quale afferma che tutti gli dei possono essere di fatto ricondotti al sole, simbolo visibile dell’Uno, di cui gli dei della tradizione sono manifestazione; in Saturnalia 1.17.2 (ed. Von Jan) egli fa affermare a Pretestato: Nam quod omnes paene deos, dumtaxat qui sub caelo sunt, ad solem referunt,non vana superstitio sed ratio divina commenda (Dal momento che, il fatto che quasi tutti gli dei, per la precisione coloro che sono sotto il cielo, siano riconducibili al sole, te lo mostra non una vana superstizione, ma la ragione divina).
XVIII, 2 [ed. Fritzsche]): “… ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset, quod quicquid <est> divinitatis in sede caelesti, nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere” ([…] e daremo ai cristiani e a tutti la libera facoltà di seguire la religione che ognuno preferisca, poiché, qualunque sia la divinità che è nei cieli, verso di noi e quanti sono posti sotto la nostra egida essa possa essere pacifica e propizia) oppure quanto riportato dal filosofo romano Macrobio, il quale afferma che tutti gli dei possono essere di fatto ricondotti al sole, simbolo visibile dell’Uno, di cui gli dei della tradizione sono manifestazione; in Saturnalia 1.17.2 (ed. Von Jan) egli fa affermare a Pretestato: Nam quod omnes paene deos, dumtaxat qui sub caelo sunt, ad solem referunt,non vana superstitio sed ratio divina commenda (Dal momento che, il fatto che quasi tutti gli dei, per la precisione coloro che sono sotto il cielo, siano riconducibili al sole, te lo mostra non una vana superstizione, ma la ragione divina).
Infine consideriamo la meravigliosa Relazione sull’altare della Vittoria del praefectus urbi Quinto Aurelio Simmaco.
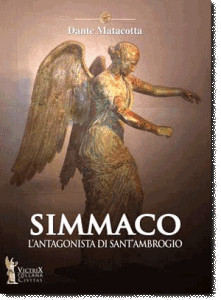 Egli propone all’imperatore cristiano Valentiniano proprio il concetto di Roma quale casa comune di popoli diversi per lingua, cultura e religione, che, nonostante le loro differenze, possano trovare in essa un comune punto di riferimento in quanto manifestazione terrena di quella mente divina, di quel Logos universale, di quel dei verbum, di quel νοῦςπατρός, che accomuna differenze di lingua, cultura, razza e religione senza annullarle, ma invece valorizzandole in sé. Il fatto che il tentativo di Simmaco fallì, e che l’altare della Vittoria fu rimosso dalla curia, è irrilevante per noi, in quanto le sue parole hanno un significato universale ed eterno, che trascende il momento storico in cui furono pronunciate; ascoltiamole:
Egli propone all’imperatore cristiano Valentiniano proprio il concetto di Roma quale casa comune di popoli diversi per lingua, cultura e religione, che, nonostante le loro differenze, possano trovare in essa un comune punto di riferimento in quanto manifestazione terrena di quella mente divina, di quel Logos universale, di quel dei verbum, di quel νοῦςπατρός, che accomuna differenze di lingua, cultura, razza e religione senza annullarle, ma invece valorizzandole in sé. Il fatto che il tentativo di Simmaco fallì, e che l’altare della Vittoria fu rimosso dalla curia, è irrilevante per noi, in quanto le sue parole hanno un significato universale ed eterno, che trascende il momento storico in cui furono pronunciate; ascoltiamole:
Relatio de ara Victoriae, 3.1.8 (ed. Klein): Suus enim cuique mos, suus ritus est: varios custodes urbibus cultus mens divina distribuit; ut animae nascentibus, ita populis fatales genii dividuntur (A ciascuno dunque i suoi costumi, a ciascuno i suoi riti: la mente divina distribuì molteplici custodi [e] culti alle città; come alle anime che nascono, così ai popoli sono assegnati genii stabiliti dal Fato).
Ibid. 3.10: Ergo diis patribus, diis indigetibus pacem rogamus. Aequum est quidquid omnes colunt unum putari. Eadem spectamus astra, commune caelum est, idem nos mundus involvit: quid interest qua quisque prudentia verum requirat?Uno itinere non potest perveniri ad tam grande secretum. (Quindi chiediamo la pace agli dei dei nostri padri, agli dei patrii. E’ giusto che ciò che tutti adorano sia considerato come l’Uno. Guardiamo le stesse stelle, il cielo ci è comune, lo stesso mondo ci circonda: che cosa ci importa per mezzo di quale tipo di conoscenza ciascuno di noi cerca il vero? Non possiamo arrivare ad un così grande segreto attraverso una sola strada).
Le parole di Simmaco non devono essere interpretate come quelle di un uomo sconfitto, che abbraccia l’ideale di Roma quale sede terrena della religio universalis del “Dio che è nei cieli”, – inconoscibile e chiamato con nomi diversi, ma basati sulla stessa pietas,dalle diverse religioni dell’impero – solo per salvare i propri privilegi di membro della classe senatoriale romana in una situazione in cui essi venivano messi in discussione; al contrario, egli si presenta a noi come un uomo consapevole di un processo di mutamento religioso che inizia ben prima di lui, già alla fine dell’età repubblicana, quando l’espansionismo romano si accompagnò ad una sempre maggiore apertura di Roma verso l’ellenismo di matrice greca e orientale (specialmente egiziana e persiana), che faceva del monarca la manifestazione terrena del Dio celeste supremo, di cui il re è figlio (dei filius). Un simile mutamento radicale dell’antica religione di Roma fu ferocemente combattuto dai patres, ovvero dai membri dell’aristocrazia senatoria, che si sentivano custodi degli antichi mores, come questo passo delle Filippiche di Cicerone, in cui egli ridicolizza la divinificazione già in vita di Giulio Cesare, chiaramente dimostra (II. 111 [ed. Clark]): Quaeris, placeatne mihi pulvinar esse, fastigium, flaminem? Mihi vero nihil istorum placet […] (Mi chiedi se non sia per me accettabile il sacro cuscino, il piedistallo, o il flamen (di Cesare)? A me niente di tutto questo piace […]).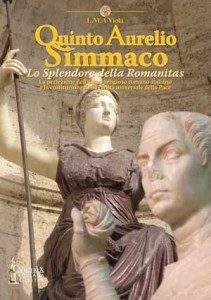
Agli occhi di Cicerone Cesare, e il di lui seguace Antonio, a cui egli rivolge questa orazione, rappresentano i distruttori della più antica religione di Roma, proprio per il loro tentativo di aprirla all’influenza della religione egizia e dell’ellenismo, di cui, tuttavia, Cicerone stesso era un cultore ed ammiratore. E’ chiaro quindi che anche coloro i quali, come Cicerone, erano per principio ostili all’influenza delle religioni orientali ellenizzate, non riuscivano a sottrarsi al potere di attrazione che esse esercitavano su di loro e che quindi una sintesi superiore era necessaria, sintesi di cui di fatto Roma stessa fu in parte capace con gli imperatori della tarda antichità, che promossero i culti orientali ellenizzati e cercarono di integrarli positivamente con le antiche consuetudini religiose propriamente romane, anche se il culmine di questo processo fu raggiunto solo quando l’unità politico-militare dell’impero era gia irrimediabilmente compromessa e l’intolleranza cristiana, dovuta ad una interpretazione riduttiva ed integralista del messaggio universale di Cristo, impedì definitivamente la costituzione di Roma a tempio terreno della religio universalis.
Oggi però, che l’uomo sta diventando sempre più consapevole della pericolosità dell’integralismo religioso rispetto alla stessa possibilità di sopravvivenza della specie umana, il messaggio di Simmaco ci si presenta in tutta la sua radicale attualità, quale unica via che l’umanità possa percorrere per ricondurre le proprie diversità culturali, politiche e religiose ad una sintesi più alta che le valorizzi senza annullarle, al fine di restaurare, attraverso l’idea di Roma quale faro della civiltà universale, Roma caput mundi, casa comune di tutti i popoli, quel legame col sacro che l’uomo stesso ha spezzato, ma che è l’unico mezzo con cui può riscoprire se stesso e la sua autentica umanità.