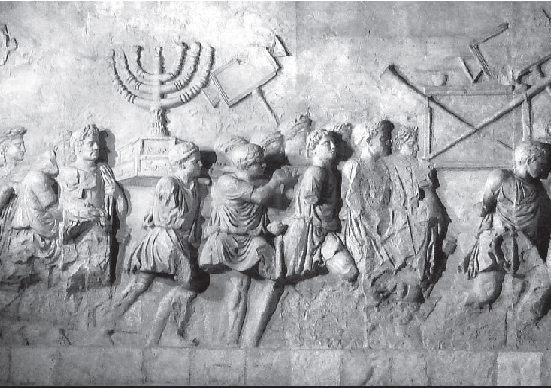Con la sconfitta nella seconda guerra mondiale, nonostante la statura di un popolo si misuri proprio nei momenti tragici, l’Italia subì un crollo identitario e una regressione spirituale e psicologica senza precedenti, da cui praticamente non si è più ripresa. Se la ricostruzione materiale e la rinascita economica ebbero successo permettendo alla nazione di procurarsi nel tempo un buon tenore di vita (ora nuovamente compromesso), non altrettanto avvenne per la risorgenza spirituale e psicologica, al posto della quale rimase un vuoto pericoloso che i “vincitori” poterono comodamente riempire nel corso di tutto il dopoguerra con i propri contenuti, le proprie ideologie, le proprie visioni del mondo, quasi sempre in flagrante contrasto con il Risorgimento, la cui forza ideale trapassata nella Grande Guerra e poi nel Fascismo, evidenzia come questi tre importantissimi eventi siano profondamente connessi l’uno all’altro, al punto che anche durante la Repubblica Sociale i legami con il Risorgimento rimasero forti e inalterati, e il nipote di Garibaldi, Ezio (figlio ultimogenito di Ricciotti), continuò la direzione della famosa rivista mensile “Camicia rossa”, che datava fin dal 1925, quale erede diretta della rivista originaria omonima fondata dallo stesso Garibaldi nel lontano 1871.
Il 13 marzo 1944, a Roma, alcune bombe venivano lanciate contro un corteo di fascisti che tornava da una commemorazione di Giuseppe Mazzini nella Casa Madre dei Mutilati, causando numerosi feriti, anche bambini. In tal modo l’antifascismo dimostrava la sua avversione non soltanto al Fascismo, ma a tutto ciò che storicamente vi si riconnetteva.
Molto problematico, perciò, per non dire poco credibile, fu per le forze antifasciste rapportarsi all’ingombrante passato dell’Italia, sia durante il corso della Resistenza che soprattutto dopo, quando, condannato il Fascismo all’esecrazione universale e levatolo di scena, si trovarono a dover gestire, senza averne i giusti titoli, impacciatamente, il patrimonio grandioso di memorie che dal Risorgimento giungeva fino al Piave e a Vittorio Veneto. Ciò che per il Fascismo era stato ovvio e naturale, fatto di tanti gesti rituali, grati e simbolici rivolti al passato (si pensi alla cerimonia dedicata perfino alla morte dell’ultimo dei sopravvissuti dell’insurrezione romana del 1867, Enrico Biagioli), per l’antifascismo si presentava come una spina nel fianco e un onere gravoso. Uscito di scena il mortale nemico in camicia nera con le sue devote cerimonie rivolte alla Patria, la nuova classe dirigente si preoccupò di spianare gradatamente il campo della memoria collettiva, restringendolo via via allo stretto indispensabile, mentre le cattedre di Storia – in particolare di Storia del Risorgimento – venivano occupate da professori graditi alla nuova politica catto-comunista, a cui le celebrazioni in pompa magna del Risorgimento riuscivano ben poco opportune e anzi fastidiose, e che intendeva riforgiare una lettura del medesimo che fosse in linea con la Resistenza, la Costituzione, la repubblica democratica nata dalla sconfitta e l’Europa, e non entrasse in contrasto con la Chiesa. Si cominciò così a spulciare e ad eliminare dalle trattazioni e dagli studi gli aspetti meno graditi, quelli più spiccatamente patriottici, cospirativi, nazionalisti, Romani, Italici, carbonari, tradizionali, peculiari e perfino etnici del Risorgimento, facendo emergere e risaltare solo quelli che non erano di disturbo alla nuova strumentalizzazione politica, intenzionata a livellarli in una visione europea-internazionale, meglio se di derivazione napoleonica – e quindi straniera –, o tutt’al più neoguelfa. Immaginiamo come poteva far piacere ai cattolici-papisti usciti trionfanti dalla guerra, ricordare un personaggio come Enrico Biagioli, sopravvissuto nel 1867 (aveva allora cinque anni) alla strage che gli zuavi pontifici scatenarono a Roma nell’osteria di suo padre, covo di cospiratori Garibaldini, strage da cui era uscito gravemente ferito all’avambraccio sinistro, e ciò nonostante trascinato, così piccolino, in Castel Sant’Angelo con altri prigionieri.
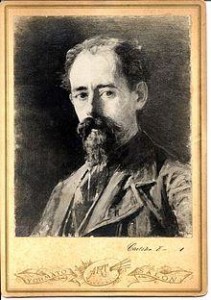
Gioacchino Toma, pugliese, fu uno dei più importanti pittori meridionali dell’ottocento italiano. Di origini poverissime, senza famiglia, abbracciò molto presto gli ideali garibaldini, arruolandosi volontario. Arrestato più volte, catturato infine dai borbonici nel 1860 in Molise durante una momentanea rotta della Legione garibaldina cui apparteneva, fu imprigionato a Isernia, dove venne liberato pochi giorni dopo dai garibaldini vittoriosi. Con l’Unità d’Italia potè vivere finalmente una vita tranquilla, professore all’Istituto delle belle arti e poi direttore della Scuola d’Arte a Napoli. Un suo autoritratto è conservato agli Uffizi a Firenze.
Immaginiamo come poteva far piacere ai comunisti celebrare adeguatamente Mazzini, il quale aveva messo in guardia dai gravi pericoli insiti nell’ideologia marxista, rigettandola nei suoi fondamenti, e nei confronti del quale Marx usò espressioni oltre il limite della villanìa. Le schiere di nobili che, rimettendoci la vita, la salute e i beni, avevano preso parte al Risorgimento insieme ai borghesi e ai proletari, venivano a contraddire flagrantemente la teoria marxista della contrapposizione fra le classi sociali di cui una sola doveva prevalere sulle altre. Antonio Gramsci, ma non lui solo, martellò sempre su questo punto, facendo passare la comoda tesi (comoda per lui e il suo partito) che al Risorgimento non aveva partecipato la massa popolare proletaria, e dunque spettava al comunismo colmare questa gravissima lacuna e risolvere i problemi sociali lasciati insoluti da un Risorgimento borghese e traditore. Anche l’ostinazione di Garibaldi manifestata fino all’ultimo per Nizza, la Corsica, la Savoia e tutte le terre irredente doveva essere saggiamente messa in ombra, enfatizzando piuttosto certe frasi che, negli ultimi anni della sua vita, l’eroe si era lasciato sfuggire sul socialismo, frasi di cui Bakunin e le prime leghe operaie italiane filomarxiste fecero un uso improprio, annunciando che Garibaldi era diventato uno di loro.
Gli effetti di un Risorgimento “politicamente corretto”, congeniale al nuovo regime, presentato come preludio incompleto della repubblica antifascista e che la repubblica antifascista avrebbe portato finalmente a compimento con le sue “altissime benemerenze”, sono chiaramente visibili a tutt’oggi nelle sedi ufficiali in cui si parla dell’argomento: dalle scuole alle università, dalle conferenze alle dichiarazioni degli ex Presidenti Ciampi e Napolitano, fino alle rappresentazioni televisive, in cui lo snaturamento, la banalizzazione e il depauperamento del Risorgimento, spogliato dei suoi contenuti più autentici e più “eretici”, staccato dai suoi documenti reali, l’hanno reso un fenomeno “sostenibile” e accettabile dal quadro politico attuale, europeista e mondialista. Ma i documenti reali del Risorgimento, spesso travolgenti e coinvolgenti, intrisi di un patriottismo e di una fede non di rado spinta all’estremo e in certi casi inquietante (alla luce di che ben si comprendono le prime strofe dell’inno nazionale), costituiscono il suo vero volto, che ben poco si attaglia alla repubblica antifascista, ed anzi non vi si attaglia affatto. E’ un Risorgimento che non si lascia imbrigliare in nessun orientamento politico-culturale definito, tantomeno francese (e ancor meno inglese), che non si lascia etichettare né tampoco ammansire e “rieducare” a ciò che vorrebbe l’attuale repubblica. Se ai ragazzi nelle scuole si leggessero i documenti reali del Risorgimento, il Ministero della Pubblica Istruzione interverrebbe subito, perché questi documenti, che sono in grado di calamitare lo spirito di un adulto, effetti ancor più forti susciterebbero nei ragazzi e nei bambini. Gli stessi proclami di Re Carlo Alberto durante la 1a guerra d’indipendenza (alcuni dei quali fino a qualche decennio fa erano leggibili nel Museo del Risorgimento di Mantova), stupiscono per la loro forza trascinante, nonostante Carlo Alberto fosse un uomo alquanto equilibrato e composto.

Chiuso in tal maniera dalla sinistra il Risorgimento in una scatola in modo da arrecare meno fastidio possibile, lo stesso ha dovuto presto fare i conti con il revanscismo cattolico, ansioso di rivincite postume. Dopo aver raccolto attorno a sé i lembi sparsi del più multiforme anti-Risorgimento vagante (filoaustriaco, neoborbonico, leghista padano, etc…), finalmente nell’anno 2000, al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, il cattolicesimo nostrano più ligio e devoto a Santa Madre Chiesa riuscì a radunare uno stuolo di politici, giornalisti, opinionisti e scrittori di una certa levatura per la condanna pubblica del Risorgimento, che venne gratuitamente insultato in modo becero e volgare da uno stuolo di ragazzini ignoranti spalleggiati da nomi più o meno altisonanti del ben noto universo politico-mediatico allora circolante, ognuno ansioso di assestare il suo bel colpo di piccone alle Patrie memorie, che mai prima d’allora erano state così impunemente calpestate e offese.
Chiaro che le premesse c’erano già. I due grandi partiti antifascisti, DC e PCI, eredi rispettivamente del partito popolare di Don Sturzo (nato formalmente nel 1919 ma che già di fatto preesisteva in varie organizzazioni cattoliche attive sul territorio), del partito socialista di Filippo Turati (che assunse questo nome ufficiale nel 1895, ma già preesisteva in varie organizzazioni operaie di stampo marxista, attive soprattutto a Milano) e del partito comunista fondato da Gramsci nel 1921, erano sempre stati in aperta polemica con il Risorgimento: tranne alcuni casi individuali e qualche velatura di facciata più o meno sincera, il loro atteggiamento nei confronti del Risorgimento era basato, quando non sull’indifferenza, sulla critica sussiegosa, la prosopopea politica, nonché sulla minimizzazione e l’oscuramento del suo ruolo, che, prendendo a pretesto la questione sociale e quella romana, veniva via via svuotato d’importanza con lo scopo di eclissarlo definitivamente dalla memoria collettiva nazionale per far posto a una nuova visione del mondo: quella cattolica e marxista, appunto. Le polemiche dei cattolici e dei socialisti, pertanto, gli uni forti dell’appoggio di una Chiesa che non aveva mai digerito la breccia di Porta Pia e gli oltraggi conseguenti dello Stato laico Risorgimentale (solo a Bologna c’erano più di 70 istituti religiosi, due terzi dei quali venne spazzato via dall’Unità d’Italia), gli altri della prorompente suggestione scaturita dalla pubblicazione del manifesto del partito comunista di Marx ed Engels nel 1848 (che cominciò a penetrare in Italia dopo il 1871), si allargavano a macchia d’olio a coinvolgere tutti i temi che più potevano far presa su di una certa massa frustrata e scontenta, facile preda di scorciatoie demagogiche e ribellistiche: dall’anti-militarismo (Don Sturzo si proclamò apostolo del disarmo universale) al suffragio universale, dalla pace planetaria alla salvazione dei poveri e degli oppressi, dalla terra ai contadini al decentramento amministrativo (Don Sturzo aveva ideato lo scudo crociato come simbolo della cristianità, ma anche come riferimento ai liberi Comuni medioevali, feriti anch’essi dalla riunificazione e centralità dello Stato). In verità, i progetti e le istanze sociali erano già a vario titolo contenute nel Risorgimento fin dagli albori, e, anche se non fu mai elaborata una teoria sociale definita e definitiva, essendo prioritaria la questione nazionale su ogni altra questione, piuttosto chiare erano le direttrici Risorgimentali in campo sociale, di cui era stata rimandata l’attuazione e l’analisi dettagliata al tempo opportuno, subordinandola alla cooperazione fra le classi.
Ma ai due partiti nati sotto la cattiva stella dell’anti-Risorgimento, non interessavano queste supreme idealità, né potevano interessare le alte parole che Nino Bixio pronunciò in Parlamento nel 1863, in occasione delle dimissioni di Garibaldi che Bixio invitava a respingere: “So di trovarmi, qui, di fronte alla crema degli Italiani: a coloro che hanno sofferto, a coloro che sono stati in catene, a coloro che hanno aspramente combattuto per la Patria…”
Nella loro lunga marcia verso il potere, per Don Sturzo, per Turati e per Gramsci il Risorgimento con tutti i suoi sepolcri e i suoi ideali rappresentava piuttosto un ingombro, un impiccio e un ferrovecchio del passato. Da qui il porre l’ossessivo accento su suoi presunti gravi errori, da qui l’esasperazione dei conflitti sociali ascritti a sua colpa, da qui la denigrazione costante del paese riunificato, presentato sempre in modo catastrofico come sull’orlo del baratro (anche se era costantemente in crescita), da qui il vituperare gli uomini del Regno d’Italia, definiti incapaci, intrallazzisti, opportunisti, avidi proprietari e sfruttatori, sordi alle grida di dolore del popolo, specie quello meridionale. Da qui, lo strizzare l’occhio ai neoborbonici – per pochi che fossero –, e addirittura agli austriacanti – che erano ancora meno –, propugnando o elucubrando improbabili ritorni a separatismi e separazioni, autonomie e secessioni.
Una carica sovversiva, più che costruttiva, emanava da questi due partiti che cercavano di farsi largo con ogni mezzo nella solida compagine del Regno d’Italia, anche sfruttando l’apparente collaborazione con le forze al governo. Pur tuttavia, a dimostrazione di quanto perdurasse ancora fortissima la carica patriottica Risorgimentale negli Italiani (il Regno d’Italia era continuamente percorso in lungo e in largo da commemorazioni patriottiche e celebrazioni degli anniversari di tutte le patrie battaglie) e di quanto non ci fosse pericolo alcuno che il Regno d’Italia venisse sovvertito da alcunchè, essi riuscirono a prendere il potere solo a seguito della grave sconfitta bellica del ’45 e del potente supporto straniero che l’accompagnava. Prima di ciò, nonostante non lasciassero nulla d’intentato, non vennero a capo delle loro mire neanche all’interno di sé medesimi, dal momento che tra i cattolici permaneva comunque alto il sentimento di attaccamento al Risorgimento stante il gran numero di religiosi che vi avevano preso parte, e tra i socialisti non mancavano i dissensi e le remore a violare l’inviolabilità di mostri sacri come Garibaldi e Mazzini, coi quali nessuno Sturzo e Turati poteva lontanamente competere. Di conseguenza, la vita dei due partiti-antenati della DC e del PCI procedette per molti anni ingloriosa, difficile, accidentata e contraddittoria, fino a quando una gloria insperata, risucchiando l’antiRisorgimento nell’antifascismo, non li investì dall’oggi al domani della luce abbagliante del potere, sulle ceneri di una sconfitta bellica che per l’occasione da quel momento chiamarono Vittoria. E infatti una vittoria certamente vi fu: la loro.
Con ciò il continuum della Storia d’Italia malauguratamente s’interruppe, e la coscienza collettiva che, nonostante varie vicissitudini, si era mantenuta salda intorno ai valori fondanti della nazione, alle sue tradizioni, alle memorie, ai sepolcri dei caduti e degli antenati Romani (non c’è inno o poesia del Risorgimento che non li nomini, senza dire dei continui rimandi a Roma antica di Garibaldi e di Mazzini), e all’orgoglio conseguente che intorno alla dinastia dei Savoia aveva trovato un centro di gravità permanente, venne a decadere come in un tonfo. Forse per la prima volta nella Storia si vide un Re dispensare il proprio Esercito dal giuramento di fedeltà, a seguito dell’ultimatum imposto dai democristiani e i comunisti: “O la repubblica o il caos.”
Una repubblica che nei primi tempi mantenne un dignitoso contegno di rispetto nei confronti delle patrie memorie: e, d’altronde, con la fiumana travolgente dei Triestini che accoglievano in massa nel 1954 l’Esercito Italiano, come avrebbe potuto essere altrimenti? Bisognava dare l’idea della continuità con il passato, bisognava dare una parvenza di Patria, assecondando l’ingenua illusione degli Italiani di esserlo ancora come una volta, e, magari, d’aver vinto la guerra. Ma i nodi vennero al pettine già con la ratifica del trattato di pace. Poi, con la firma del trattato di Osimo che cedeva l’Istria gli jugoslavi. Poi, con la questione dell’Alto-Adige, dove le bombe de tirolesi aprirono la porta all’emarginazione degli italiani in favore dell’elemento tedesco. Poi, con lo sparpagliamento dei 350.000 esuli istriani, fiumani e dalmati su tutto il territorio nazionale per indebolirli anziché concentrarli in un unico territorio per mantenerli forti e coesi. Poi, con il separatismo siciliano e la mafia, insediatasi alla grande in Sicilia. Poi, con l’attentato a Mattei. Poi, con l’abolizione della festa del 4 di novembre come festa nazionale. E così via, fino ai nostri giorni.
La pia illusione di un antifascismo continuatore del Risorgimento, fedele erede delle sue memorie, quale l’astuto Palmiro Togliatti, con il cinismo e la spregiudicatezza che gli erano congeniali, aveva ammannito dopo la svolta di Salerno, abbandonando l’anti-Risorgimento varie volte esternato in pubblico, per riesumare un Garibaldi e una Patria che gli servivano per dare presentabilità alla Resistenza, s’infranse drasticamente contro i fatti prima che contro la logica. Altrettanto poco durò la pretesa di Benedetto Croce, già enunciata nel manifesto degli intellettuali antifascisti nel 1925, di contrapporre il Risorgimento al Fascismo, stabilendone l’inconciliabilità reciproca. Solo la presenza dei tedeschi dopo l’8 settembre venne a dare man forte a questa pia illusione, in quanto, per associazione d’idee, questi apparivano una riedizione in peggio degli Austriaci. Non a caso il martellante richiamo al “tedesco invasore e secolare nemico dell’Italia” diventò il filo conduttore di tutta la lotta partigiana, quello che maggiormente riuscì a catalizzare l’emotività degli Italiani, pungolandoli là dove si poteva effettivamente concludere che i tedeschi erano la brutta copia degli Austriaci e, al pari di questi, andavano combattuti. Ciò portò non poca acqua al mulino della Resistenza, gonfiando artificiosamente la sua apparenza di “secondo Risorgimento”.
Ma la Resistenza non fu un secondo Risorgimento, e nemmeno pose in essere alcun vero e intimo legame con esso. Le differenze tra i due fenomeni storici sono troppe: nelle cause, nei fini, nel merito, nella sostanza e anche nel metodo. Principalmente, il Risorgimento non contemplò mai nulla che lontanamente assomigliasse a una resa incondizionata a cui l’antifascismo portò invece ostinatamente la nazione facendole credere si trattasse di un armistizio, se non addirittura di un premio degli Alleati. Gli armistizi ci furono durante il Risorgimento, in ciascuna delle tre guerre d’indipendenza, ma furono armistizi veri, non già dei trucchi dietro i quali si celava il baratro della resa totale. Non solo. Ma le reazioni anche violente che gli Italiani dimostrarono contro di essi (coi quali l’Austria di volta in volta s’illudeva di tacitare e acquietare l’Italia concedendole qualche contentino), danno l’idea di quale fosse lo spirito dominante della popolazione di allora. Nel primo caso, un febbricitante Re Carlo Alberto, stremato sopra un pagliericcio dopo la sconfitta di Custoza, si convinse a desistere per le penose condizioni dei suoi soldati e sue proprie, ma a Milano fu portato in salvo dai bersaglieri per salvarsi dalla folla inferocita che voleva continuare a oltranza la guerra (che da lì a pochi mesi infatti fu ripresa, concludendosi con la sconfitta di Novara cui seguì un altro armistizio, a seguito del quale Carlo Alberto dovette abdicare).
Nel secondo caso, l’armistizio con cui bruscamente s’interruppe la seconda guerra d’indipendenza in cui l’Austria se l’era vista brutta, fu concluso da Napoleone III e Francesco Giuseppe alle spalle del Piemonte, gettando nella costernazione tutti i patrioti d’Italia, e in primis il Conte di Cavour il quale ebbe davanti al Re Vittorio uno dei più violenti scoppi d’ira che la sua biografia ricordi, in cui, rosso paonazzo in volto, arrivò a urlargli in faccia: “Gli Italiani è a me che guardano! Sono io il Re!”. Al che il Sovrano, senza scomporsi, rispose in dialetto piemontese: “E’ tardi, portatelo a dormire.”
Durante la 3a guerra d’indipendenza, iniziata nel 1866 con tante speranze e una memorabile seduta in Parlamento, rievocata dal deputato Andrea Molinari in una lettera all’amico avvocato Quadrio (“Caro avvocato Quadrio, ti scrivo con l’animo profondamente commosso dello spettacolo che presentò la Camera nella sua tornata di ieri sera. Il momento fu solenne, sublime, e ho veduto a parecchi scorrere le lacrime agli occhi. Per me fu l’Italia che si è proclamata di fronte all’Europa pronta a qualunque sacrificio pur di raggiungere il compimento dei suoi destini e rendersi rispettata quanto lo deve essere una grande e libera nazione.”), la Prussia firmò con l’Austria un armistizio che mise l’Italia, già indebolita da due sconfitte ma pur decisa a continuare la guerra fino all’Isonzo, con le spalle al muro, costringendola di fatto ad accettare. Fu in quell’occasione che Mazzini esortò gli Italiani ad alzare le barricate e rovesciare Casa Savoia onde continuare le ostilità, ma le proteste della popolazione che a gran maggioranza si manteneva comunque fedele alla Monarchia Sabauda, non andarono oltre pacifici raduni sotto le finestre delle Prefetture e petizioni rivolte a Sua Maestà, tra cui quella scritta dai professori e studenti dell’università di Pisa, che si dichiararono pronti a partire per la guerra come ai tempi di Curtatone e Montanara.
Ogni tentativo della Resistenza di rapportarsi al Risorgimento cade perciò già al primo raffronto, quello più importante, e di per sé è sufficiente a fare del Regno d’Italia nato dal Risorgimento, pur tra le sue mille difficoltà, uno Stato ben diverso da quello nato dalla Resistenza: un Regno che se la cavò sempre da solo, con le sue forze e i suoi pochi mezzi, autonomamente, vogando in un’Europa sostanzialmente ostile. Un Regno che lasciò di sé un’impronta notevolissima nelle arti, nella letteratura, nella scienza e nell’architettura di tutte le città d’Italia, nonchè nell’Esercito, nelle istituzioni e nelle leggi, apportando radicali trasformazioni in senso laico e moderno. E che perciò esce dalla Storia a testa alta, ma il cui fatale errore fu quello di non accorgersi che stava covando due serpi in seno che lo rodevano dall’interno, e quando se ne accorse fu troppo tardi.
Maria Cipriano