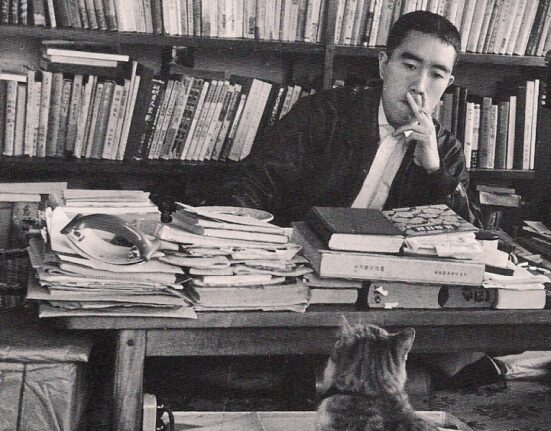A metà di questo mese di gennaio è in programma l’uscita di Notturni, antologia di racconti, presso le Edizioni Settimo Sigillo. Più autori si cimentano sul questo medesimo tema portando ciascuno personale contributo in narrazione forme espressive sensibilità. Un progetto fortemente voluto dall’amica Susanna Dolci, un regalo fatto a se stessa per il suo compleanno e un regalo a tutti noi. Mi ha telefonato mesi fa, prima dell’estate, chiedendomi di scrivere qualcosa ed io ho aderito volentieri. In linea con quel mio raccontare che ha preso l’avvio da Atmosfere in nero, passando per Ai confini del nero, fino ad arrivare a Nei meandri. Frammenti di storia, episodi raccolti dalla viva voce di protagonisti e testimoni, tra il vero e il verosimile di quel tempo eroico, in risposta alla malafede e alla dimenticanza, a difesa di quei giovani che scelsero per non essere scelti, che se ne andarono ardenti e irriverenti ‘a cercar la bella morte’ senza alcuna certezza e poche le speranze di vittoria. Agli amici e lettori di Ereticamente, dunque, faccio dono di questo mio racconto, quale anticipo al volumetto tutto.
La sottile linea di uomini, uno dietro l’altro, risale il sentiero nel bosco. Sono una ventina in tutto, quanti possono stare pigiati nel vecchio BL 18, lasciato vicino al cimitero del paese, quattro case di pietra e il tetto di travi, con un paio di militi a guardia. Stringono nelle mani, con il colpo in canna, il moschetto il mitra la pistola. Silenziosi, favoriti dal fango misto a neve che ne attutisce il passo; hanno l’ordine di non fumare e, per molti di loro, è il sacrificio più duro; solo quando la luna filtra tra i rami fitti degli alberi se ne intravede l’ombra, spettrale, di figure confuse, nere come la camicia o il maglione che indossano sotto il pastrano. Vanno a caccia, caccia di uomini che si annidano in quei luoghi impervi, bestie, sì, così pensano, capaci solo di scendere procurarsi cibo ghermire la vita dei loro camerati. E, come tali, verranno trattati, lordi di sangue da mettere nel carniere della signora morte chè pietà l’è morta, da entrambe le parti. Già ne pregustano la cattura.
Hanno vegliato, poche sere prima, gli ultimi due della mattanza senza fine. Un combattente della campagna di Russia, fra i pochi che sono tornati, con qualche dita dei piedi lasciati a ricordo nel gelo, che però s’era voluto mettere a disposizione, ‘li conosco io i rossi!’ soleva ripetere portandosi la mano alla gola nel segno rude di tagliarla, aspro nei modi e nel linguaggio. L’altro, un ragazzetto di quindici anni, forse meno, arrivato chissà da dove, sporco e affamato, due grandi occhi scuri e mobili. S’erano attardati a bere un bicchiere di vino all’osteria, al calduccio del camino al fumo acre di sigarette corpi sudati una scodella di minestrone di verdure fumante. Li avevano attesi, i partigiani, riparati dal buio e dall’angolo del muro, prima sparando loro alla schiena e, poi, finendoli con un proiettile alla nuca che ne aveva scoperchiato il cranio in un misto di ossa capelli massa cerebrale sangue rappreso. Li avevano raccolti poco dopo; la testa avvolta e tenuta con un fazzoletto annodato; in una aula della scuola elementare, requisita e trasformata in caserma, la camera ardente, il drappo nero alla parete con il fascio repubblicano, le due bare aperte al centro i militi a turno a fare il picchetto d’onore; solo pochi i civili, timidi e spauriti, un ufficiale della Gendarmeria tedesca i responsabili politici del P.F.R.. Ormai i giochi sono chiari fra chi sarà il prossimo vincitore e la sorte che sarà riservata ai vinti…
Poi la soffiata. Per rancore personale, un torto subito, denaro, chissà, poco conta. E l’automezzo s’è messo in moto appena s’è fatto buio ed ora questo sentiero il bosco le ombre della notte la luna. Avanti il sergente con la spia, la pistola puntata alle reni, se è una trappola, è il primo a lasciarci la pelle e lo sa. Un uomo dal volto affilato gli occhi incassati, con un berrettaccio calato sul volto e le orecchie, sembra una faina come se nel tratto si manifestasse già l’infamia del suo ruolo. Al contrario, in stridente contrasto, il sergente è un montanaro dalla testa squadrata il fisico possente mani e piedi grossi e nervosi una barbaccia scura e folta a nascondere in parte una lunga cicatrice che gli parte dall’occhio e gli taglia in due la guancia. E’ già nel pieno degli anni, squadrista delle prima ora, poi messo da parte quando il Fascismo ha imposto, con la conquista del potere, la normalizzazione. Ora è tornato nei ranghi, in prima fila, a riprendere la marcia, voce autentica delle origini di quell’Italia ‘proletaria e fascista’ che troppi accomodamenti e ritardi e ammiccamenti con la borghesia il Re e i preti avevano tacitato in modo maldestro e, infine, s’era rivolto contro. Volontario in Africa Orientale, con il moschetto e il badile a costruire strade, dove un abissino gli ha lasciato con la punta di lancia un ricordo indelebile che, d’allora, tende a mascherare con la barba, ora dà caccia ai banditi ai renitenti alla leva del Maresciallo Graziani, una ‘stupidata’ come la definisce, al mercato nero.
A chiudere la fila i militi più giovani, fra cui Ventoso, classe 1927, apprendista, fuggito di casa per riscattare la Patria tradita da Sciaboletta e Badoglio con l’8 di settembre, soprattutto essere vicino al Duce che, fra le tante cose buone, ha dato ai suoi un appartamento dell’I.A.C.P., alla periferia della città, in un quartiere venuto su con le palazzine a tre piani allineate le strade larghe e asfaltate la piazzetta con una bella fontana e tanto verde. Il padre fa l’operaio in una officina meccanica la mamma in casa a badare alle faccende alla spesa e a tirar su quattro figli di cui lui è il più piccolo. Una famiglia modesta, d’origini socialiste, conquistata dal Regime tramite le numerose iniziative a tutela delle classi più umili. Con le colonie estive, ad esempio, Ventoso ha avuto l’opportunità di conoscere il mare, tornare a casa tutto abbronzato. Ora s’è fatto crescere due baffi sottili da attore americano, di carnagione bruna, il carattere spavaldo e briccone, facile di lingua e di mano. Sale rapido, proteso in avanti, fiero del moschetto ’91 e di una ‘ballerina’, la bomba a mano tedesca con il manico, nel cinturone. E’ la prima vera azione, dopo giorni e notti trascorsi a fare di guardia alla caserma o al ponte sul torrente e di pattuglia a controllare che i pochi negozi aperti e al mercato mantengano equi i prezzi.
Dietro a lui, di un anno più grande, Almerigo, lo studente del plotone, esile, con gli occhiali dalla montatura rotonda, che ora gli si appannano con il vapore emesso dall’ansimare, dallo sforzo di inerpicarsi mantenere il passo nella fila, con il mitra a tracolla. Tra la prospettiva d’iscriversi all’università, sbocco obbligato dopo gli anni al liceo classico e la maturità conseguita a pieni voti, e trasformare in realtà di carne ossa e sangue i tanti eroi tratti dai Poemi classici dalla storia del Risorgimento dalle trincee del Carso e dai romanzi di Emilio Salgari la scelta era stata rapida e immediata. Il padre, notaio affermato, stimato nella cerchia dei salotti della buona borghesia, ormai sposato alla causa di un cauto e moderato antifascismo, imperante nello strano sodalizio fra massoni e clericali, s’era fatto rosso in volto e aveva battuto il pugno sul tavolo, con il tintinnare di bicchieri piatti e posate, la mamma s’era messa a piangere asciugandosi con il tovagliolo ricamato le lacrime, Almerigo s’era arrotolata l’ultima forchettata di pasta al sugo e, pronta una sacca con gli effetti personali, s’era chiuso la porta alle sue spalle. Senza ritorno.
Ed, ora, in questa notte d’inverno del ’44 risalgono il sentiero nel bosco con unica compagna la luna. Ad Almerigo viene a mente il Leopardi; si sforza di rammemorare qualche verso. Ecco: ‘… dietro Apennino od Alpe, o del Tirreno – nell’infinito seno – scende la luna, e si scolora il mondo’. Arianna gli ha regalato, quale pretesto il compimento degli studi, i Canti del poeta di Recanati, in edizione uscita nel mese di febbraio, per una casa editrice di Roma, prima che, il quattro di giugno, gli invasori vi entrassero trionfanti e applauditi dalla folla in festa. Impotenza e rabbia era stato il sentimento ufficiale nel territorio di quanto restava della Repubblica; mentre, in segreto, molti videro e ne trassero auspicio per una rapida fine della guerra. A tutti fu chiaro che ormai il cerchio andava chiudendosi e a danno di tedeschi e fascisti. La guerra era persa e già da lunga data. Sebbene Roma fosse formalmente dichiarata ‘città aperta’, con il comando germanico a dettare legge e Mussolini relegato sul lago di Garda, la sua caduta divenne tragica immagine della fine di una illusione di grandezza, di carta pesta, come ironizzarono i suoi detrattori, pur se tardiva e fragile idea dell’Impero rinnovatosi sui ‘colli fatali’, come il Duce aveva annunciato nella magica nottata del 9 maggio del ’36, ore 22,30, dal balcone di Piazza Venezia.
Arianna, già… compagna di liceo, un anno in meno, minuta bruna con la gonna a scacchi le calzette e le scarpe di sughero. Gli aveva fatto dono del libro, ‘ad Almerigo, con sincero affetto’, timida e ad occhi bassi, scappata via subito, prima che potesse ringraziarla. Solo allora s’era accorto di lei, aveva avvertito qualcosa di indefinito, alla bocca dello stomaco, che si sarebbe palesato nella lontananza, in quelle vallate per i monti in caserma accanto ai camerati di quella comune scelta, sempre più consapevole e disperata. E, allora, quel piccolo libro, quelle poesie che a scuola gli avevano reso antipatico il Leopardi il suo insanabile pessimismo l’immagine brutta e goffa dello scrittore, erano divenute conforto, paradossale ponte con la speranza, sì, la speranza assurda e tenace di tornare in città, di cercarla stringerle le mani sfiorarle le labbra… Sono ore lente e passi pesanti. Il bosco, l’intrico di rami e cespugli, le tenebre fitte vanno diradandosi. Dal sergente il segnale di fermarsi, poi l’ufficiale passa lungo la fila bisbigliando che oramai sono vicini. E’ un ex ufficiale del Regio Esercito, tenente di artiglieria sul fronte balcanico, sfuggito alle bande slave e, dopo l’armistizio, alla retata dei tedeschi. Piccolo, tozzo, un grande naso, duro ma giusto tanto da farsi rispettare e, al contempo, amare dai suoi uomini. L’attesa snerva i militi, l’immobilità ne irrigidisce i muscoli, il gelo si rapprende sui volti e le mani. Per la gran parte di loro è la prima azione a cui partecipano, in un insieme di paura di non sfigurare e, al contempo, di feroce esaltazione, quel montare della bestia che si nasconde in ciascuno di noi, quando prossimo si fa l’odore del sangue. Portano negli occhi l’immagine dei volti devastati dei camerati assassinati, gli occhi sbarrati sul nulla, non conoscono ancora lo sguardo degli assassini, fratelli nemici della guerra civile…
In un sussurro Almerigo cerca la certezza dell’essere nel giusto e la forza dell’agire accostandosi all’orecchio di Ventoso, l’unico con cui ha stretto confidenza:
‘Non sento quasi più i piedi. Ho le dita intirizzite; non riesco quasi a piegarle… per il nostro battesimo del fuoco sai che sfiga se mi manca la forza di premere il grilletto? Eppure sono qui proprio per vendicare i nostri. Combattere gli invasori e i traditori della Patria!’.
Immobile, l’amico, gli occhi fissi sulla nuca del camerata che lo precede, con la canna del moschetto rivolta a terra, muove appena le labbra, ironizza:
‘Tranquillo… Esegui gli ordini e vedrai che ti verrà naturale. Come spennare la gallina per il brodo…’.
Nuovo cenno del sergente. Allora si aprono a ventaglio e si spingono verso il limitare del bosco, stringendo d’assedio la radura e la legnaia. Seguendo gli ordini del tenente si dispongono dietro il tronco degli alberi, chi in piedi chi si accuccia le armi puntate. La legnaia sono quattro pietre tirate su a secco, una porticina di assi e il tetto di rami intrecciati, in un fazzoletto di terra erbosa. Se vi sono uomini là dentro, lo sapranno presto.
Il tenente, dopo essersi brevemente consultato con il sergente, trasmette gli ordini con il passa parola. La luna sembra declinare, sbiadire, mentre ad oriente il chiarore annuncia il nuovo giorno. Ognuno controlla il caricamento dell’arma. E’ lo stesso sergente e un veterano della guerra nei Balcani, venticinque anni spesi gli ultimi cinque prima in quella regione in rastrellamenti e compiere rappresaglie ed ora con la medesima e feroce determinazione nelle valli e sui monti del suo paese, a muoversi cauti e raccolti su se stessi, quasi a fornire minore bersaglio. Nessuna imboscata, nessuna reazione. In pochi attimi sono appoggiati alle pietre sfilano le bombe a mano prendono a calci la porta l’aprono qualcuno dentro si agita vola una bestemmia un grido la legnaia è scossa dalla doppia esplosione in successione fumo urla di dolore lamenti.
‘Venite fuori con le mani alzate ben visibili! Niente scherzi chè siete circondati!’.
Il tenente si fa avanti, pistola in pugno, i militi lo seguono. La caccia volge all’epilogo e ognuno vuole essere spettatore coinvolto della preda abbattuta. Dalla legnaia esce per primo un omone irsuto tutto stracci con il volto rigato di sangue e strascicando una gamba che non lo regge più; lo segue uno smilzo, radi i capelli, con una smorfia, un misto di dolore e di ghigno, la spalla ciondolona le dita che gocciolano lungo il braccio una sottile striscia rossa. Esce anche il milite:
‘Ce n’era un terzo. E’ andato’, con una sorta di risata e sputando soddisfatto.
‘Merde, letame per i maiali…’ – urla il partigiano magro – ‘Servi dei tedeschi, bastardi borghesi, il vento del comunismo vi spazzerà via, presto molto…’.
Senza attendere ordini, in una forsennata esplosione liberatoria, i militi aprono il fuoco, scaricano le armi l’odio il senso dell’ineluttabile che si approssima e di cui vanno rendendosi conto. I due ribelli ruotano su se stessi, in una sorta di danza macabra, estrema piroetta, cadono a terra sobbalzano ancora per ulteriori colpi che li raggiungono ormai morti. Silenzio. Un giovane milite trema piange si apparta e vomita. Imperioso il tenente: ‘Bene. La festa è finita. Caricate i morti chè, in paese, devono vederli, conoscere cosa attende chi tenta colpirci alle spalle. In fila. Si torna a valle’.
Ora il sole, pallido nel cielo terso e rigido, si mostra appieno e la luna ormai è una vaga forma, destinata a scomparire. Così vuole la natura, morte e resurrezione. Gli uomini si incamminano pestando con forza il terreno, quasi a sentirsi vivi, faccia al sole e in culo al mondo, quel mondo che sanno non appartenere più al domani, tomba per la gran parte di loro, senza speranza alcuna di redenzione… Se ne fregano, consapevoli, semplificano l’esistenza, riducendola qui ed ora, la sigaretta il rancio il caldo della stufa la branda oggi s’è scansata la ‘signora Morte’. Cantano stonati e ubriachi di vita: ‘Le donne non ci vogliono più bene…’. Pensa, con un sorriso, Almerigo che non è vero, che in città al suo ritorno c’è Arianna, che metteranno su casa e avranno tanti bambini.
Non è vero, non ci sarà altra storia, ad altro il destino gli ha riservato quanto resta.
S’approssima la primavera, le giornate s’allungano, un certo tepore riscalda i corpi, li rasserena, invito alla speranza, spuntano i germogli delle piante, la natura si rinnova e si colora. Solo gli uomini in camicia nera avvertono una morsa di gelo che stringe loro il cuore. Sono di nuovo lungo le strade sterrate che dalla valle portano in montagna. Sempre più soli, folli e disperati. Ormai il territorio s’è reso ancor più infido gli agguati si moltiplicano intere zone sono cadute in mano partigiana la gente li scansa ne teme il colpo di coda simili a bestia ferita. Vanno prigionieri fedeli a se stessi incuranti si espongono quasi ‘a cercar la bella morte’ ed essa li ghermisce ad uno ad uno, non manca alla promessa di fidanzarsi con ciascuno di loro, di avvolgerli nel suo scuro mantello, di portarseli via con sé.
Ventoso avanti, dietro Almerigo, come la prima volta. E, in alto, fredda e ostile, la luna conta i loro passi ne misura le forme li attende alla prova estrema. Non c’è il tenente, abbattuto con un colpo di pistola in pieno petto all’uscita del bordello; non c’è il veterano dei Balcani, catturato dopo uno scontro a fuoco e condotto in montagna, torturato e finito a calci e pugni con la testa fracassata dalla lama di un badile. E tanti altri, troppi, mancano all’appello. C’è il sergente che li guida e che tenta di infondere loro l’entusiasmo, la fede nelle riscossa sicura che, in lui, da lunga data s’è spenta. Sono i ragazzi a lui affidati e non può non vuole non deve deluderli. E così li porta avanti, oltre il disincanto le illusioni, e impone loro di cantare, unica sfida rimasta contro il cielo e la terra, contro i portoni serrati le finestre chiuse.
Da dietro un muretto a delineare i campi i partigiani, avvisati del loro arrivo, tendono l’ennesima imboscata armati tramite gli aviolanci alleati. Una raffica prende Almerigo in pieno petto, gli trapassa il polmone, e in pochi minuti non gli resta che sputare sangue rantolare nello sforzo di imprecare pregare invocare, chissà, forse la mamma o un nome di donna. Ventoso l’ha afferrato per le ascelle e tratto al riparo. Ora gli tiene la testa sollevata, se lo vede morire fra le braccia. Così lo seppelliscono in un piccolo cimitero montano, sotto una croce senza nome, mentre si prepara la mattanza d’aprile, la festa della liberazione…
E ancora una canzone, ‘a noi la morte non ci fa paura…’, ancora passi per le vie sul selciato gli sterrati i rami spezzati l’erba verde della primavera. Prima che un manto di rosso sangue ricopra i loro corpi, tinga di sé ogni cosa.
Il vecchio siede nei pressi della finestra aperta sulla notte. Solo luna stelle silenzio. Curvo, tiene le braccia appoggiate sui braccioli della poltrona. Si guarda il dorso delle mani, rugose il reticolo azzurro delle vene gonfie le macchie scure. Più che del volto sono esse l’indice di una storia, dell’inesorabile trascorrere del tempo. Mani forti nodose che hanno conosciuto anni di lavoro davanti ai macchinari della fabbrica. La stanza dal mobilio modesto si è trasformata nel suo rifugio, anticamera del nulla, da cui esce raramente. Dopo la morte della moglie, il figlio trasferitosi lontano, pochi i conoscenti, attende che tocchi anche a lui ricongiungersi con quelli che lo hanno preceduto. Come l’Anna Maria, conosciuta in fabbrica, ventenne dai capelli scuri e ricci, un bel seno, durante l’intervallo a fumare una sigaretta in cortile, sposata appena s’era accorta d’essere incinta, per oltre quarant’anni vissuti insieme, volendosi bene rispettandosi condividendo una esistenza grama e dignitosa. Poi, quando avrebbero potuto trascorrere la vecchiaia nella serenità della pensione, il figlio sistematosi, Anna Maria s’era scoperta uno di quei mali che ti crescono dentro rodono i tessuti ti devastano in pochi mesi.
Ci sono, poi, i morti lontani, quelli che credi esserti dimenticato. E notti come questa con il vento fra i rami del bosco la luna a fare da guida l’ordine d’evitare ogni rumore. I morti della guerra civile, l’un contro l’altro armati. Dopo il crollo delle illusioni ecco la strage annunciata gli assassinati gettati nei fossati, abbandonati dietro il muro dei cimiteri, trovati lungo i viottoli, esposti nelle piazze. E ti salvi, non sai neppure come, non ne conosci il perché, solo ti scopri vivo e in fuga. Un rifugio qualsiasi, una chiesa la soffitta di un cascinale la cantina di un’anima anonima e pietosa. Poi la tormenta, la resa dei conti, l’odio a dismisura si placano e te ne torni a casa. Spaurito lacero affamato indicato a vista scansato. Dimenticare, tacito interiore comando, tenersi dentro quel fazzoletto di vita, misero straccio di giorni mesi che si sognavano pieni di gloria, ‘contro l’oro c’è il sangue e fa la storia’, resi al contrario feroci, a lacerare la carne altrui e la tua, ad ammazzare ogni sogno di riscossa e di grandezza, d’amor di Patria… Neanche i tuoi potrebbero capirti, la donna con cui ti stendi nel letto e ne assapori il calore del corpo, il bimbetto che ti porge le manine sporche di marmellata, i mesi e gli anni, finisci tu stesso a non averne più memoria.
‘Ti ricordi, Alberigo, la prima volta sul sentiero protetti dalla notte dal bosco e la luna a guardarci silenziosa? Quanto eri fiero d’essere con noi, in fila, subito dietro le mie spalle, con quel libricino tutto sgualcito nella tasca del pastrano…’
S’accorge che sta muovendo le labbra mormora sussurra, come allora, alla notte fuori la finestra alle stelle alla luna. Racconta a se stesso di quei notturni in cui avvertivano in sé d’essere poeti e assassini, poeti senza versi e assassini al servizio dell’Ideale. Se ne frega, chi lo può sentire in quel buco di stanza? E, poi, ormai non gli conta nulla, anzi che sappiano che Ventoso non è stato soltanto il buon meccanico, gentile con tutti, la domenica con l’unico vestito buono, con il cartoccio di paste, no, è stato anche legionario in camicia nera il moschetto la bomba a mano la canzone strafottente.
Sul muro, di fronte casa, i ragazzetti del centro sociale hanno scritto in vernice rossa ‘no pasaran’, certo non per lui che, anzi, qualcuno lo saluta quando passa nei pressi del capannone occupato. Che ne sanno di quel vecchio dai capelli radi, piegato dagli anni, che si accompagna ad un bastone per non perdere l’equilibrio? Fanno musica si ammazzano di canne e di birra e di sesso litigano con le guardie e rissa con i loro coetanei dalla testa rasata i giubbotti neri e gli anfibi ai piedi…
‘I volti dei partigiani, gli occhi pieni di terrore, alcuni di sfida, qualcuno si pisciava sotto, c’era chi levava il pugno verso il cielo, chiamava la mamma, implorava pietà… e noi lì a fare fuoco, eccitati dal sangue, esaltati d’essere vivi a decidere della morte altrui, angeli vendicatori dei nostri ammazzati, ragionieri di un conto che non tornava mai pari, sempre in perdita… Ed ogni volta che si tornava in caserma, a buttarsi in branda con il pastrano addosso e gli scarponi ai piedi, stanchi delusi se ci erano sfuggiti o in una sorta di rabbiosa felicità se ne avevamo accoppato qualcuno, tu leggevi dei versi del tuo Leopardi e ti giravi verso il muro, lo so, e piangevi silenzioso, non per paura ma per amore, per quell’amore inappagato verso l’Italia e Arianna. E con la bocca sul cuscino perché non si sentissero i singhiozzi…’.
Di quei mesi, poco più di un anno, ha solo spezzoni immagini parole. Lasciati a riposare, sepolti, in qualche luogo sconosciuto della mente e del cuore. Un compagno di lavoro, già anziano e incontrato dopo ch’era andato in pensione, gli aveva confidato come la vita fosse finita quando ormai si circonda di ricordi. Se ne rende conto, ora, che parla con Almerigo, con i camerati della comune e irriverente giovinezza. Ne rivede nitidi i volti di allora i gesti il tono della voce… la morte per la maggior parte di loro. Senza gioia senza odio senza dolore senza nostalgia. Occhi aperti sulla notte.
‘Neppure una fotografia, niente di niente, qualcosa da stringere nelle mani, appendere alla parete, tirare fuori dal cassetto… Mi hanno portato via tutto, io stesso mi sono liberato d’ogni cosa nel terrore che mi riconoscessero mi catturassero mi riempissero di botte mi finissero come un cane rabbioso… Cancellato il presente d’allora, come erba secca da falciare, cos’è stato il futuro? Eppure quanta vita c’era in noi, quanta sfida e gioia e voglia di vivere e di amicizia e quanto amore, sì, tanto amore mentre si riceveva odio e si dava morte’.
I vecchi sono pietosi, fragili, facili a commuoversi. S’accorge che una lacrima gli scivola lungo la gota rugosa indugia sullo zigomo prosegue il suo lento cammino. Non se ne vergogna, anzi è come se gli facesse d’amica compagnia silenziosa in questa notte insonne ove il corpo è pervaso da immagini sopite e da pensieri di una storia che si rinnova che viene da un abisso lontano.
‘Ehi, Ventoso, guarda che ho trovato!’, Almerigo con le mani ad imbuto lo chiama dall’ingresso del fienile. Corre. Dentro, sulla paglia, una forma di formaggio un salame delle bottiglie di vino.
‘Altro che fucili e bombe.’ – ammette – ‘Qui c’è da far festa come a Natale… Dai che ci spazzoliamo questo ben di Dio. Requisito. Ottimo per la truppa, che siamo noi due. Caro Almerigo, oggi è il nostro giorno…’. ‘Non dovremmo pagarlo ai contadini? Mica siamo banditi… loro sì, che si portano via tutto con la minaccia e la promessa che pagheranno dopo, ‘li stronzi, essersi liberati della nostra presenza’.
‘Bravo il mio camerata… sei bravo. Noi a mensa pasta scotta o riso senza sale, mentre questi, cheti cheti, si riempiono la pancia alla faccia nostra e poi ad applaudire chiunque vinca. Neri o rossi, tedeschi o americani sono la stessa cosa… Eh, no, anche io sono figlio del popolo, proletario in divisa, e neppure nei giorni buoni ho visto in tavola tanta grazia. Mia madre tutti i giorni il minestrone e la domenica ci metteva dentro un tocco di bollito che bisognava schiumarlo per il grasso che buttava. Rancido. Io m’apparecchio al calduccio e finchè non mi sento sazio non esco… Tu fa’ come vuoi che sono capace di mangiarmi e bere tutto’.
‘Questo no. Non sia mai che lascio un camerata da solo ad affrontare una simile battaglia…’.
La guerra è guerra e la fame è tanta. Scrupoli e ideali vanno bene, ma lo stomaco non si placa con la morale e le belle idee… Tirano fuori il pugnale, si accoccolano sulla paglia, si apprestano ad affettare il formaggio e il salame e a stappare la prima bottiglia. Ecco, però, affacciarsi una contadina, età indefinita, gran fazzoletto a colori in testa, piagnucolosa chè è quanto rimane a lei il marito la vedova del figlio caduto in Russia sul Don il nipotino e, intanto, lesta afferra la forma di formaggio e se l’infila nella larga tasca del vestito. Prova anche con il salame, ma qui più veloce è Ventoso che le dà una spinta mandandola quasi a gambe all’aria. ‘Non va bene, cara mia… Noi si combatte e si crepa e ci si dipinge come i cattivi della storia ed ora restiamo a bocca asciutta. Guarda un po’ che puoi fare… chè da qui non ce ne andiamo prima d’aver fatto colazione pranzo e cena…’.
Accorrono i familiari della donna; Almerigo fa da paciere. Si giunge a un compromesso. Sul tagliere polenta fumante fette di formaggio e di salame vino senza limiti… Ubriachi a cantare manate sulle spalle Ventoso intrufola la mano sotto la gonna della vedova che non disdegna, ancora giovane e vogliosa, Almerigo ha tratto fuori dal pastrano il suo Leopardi e, rivolto alla notte, recita con la voce impastata e impicciandosi con le parole ‘vaghe stelle dell’Orsa, io non credea – tornare ancor per uso a contemplarvi – sul paterno giardino scintillanti, e ragionar con voi dalle finestre…’, poi, lacrimoso ‘Arianna, ti amo’ e, reclinato il capo sulle braccia appoggiate al piano del tavolo, s’addormenta. E’ il momento buono per la coppia di sganciarsi furtivi e completare la conoscenza in mezzo al fieno fino al mattino successivo. Poi di corsa riprendere la via del paese e della caserma, ridendo e sfottendosi allegramente, ma prima la rabbiosa sfuriata del sergente, incazzato e preoccupato, che, non vedendoli rientrare già temeva fossero caduti in agguato partigiano, in successione la consegna per due settimane, privati della libera uscita…
Al ricordo sorride. In fondo ha vissuto intensamente quella breve stagione e, a conti fatti, sarebbe ancora della partita. Certo l’8 settembre, data infame dell’armistizio, il tradimento di Badoglio, Mussolini liberato dalla prigione del Gran Sasso per finire macellato a Piazzale Loreto, i tedeschi gli alleati i partigiani, loro stessi con quell’anacronistico moschetto modello ’91, tutte quelle parole sulla Patria e l’Onore, dopo oltre mezzo secolo sono chiacchiere vane… Affidate ai libri di storia, rispolverate ogni 25 aprile, scimmiottate da ragazzotti dell’una e dell’altra parte, pretesto per scaldare i muscoli, alla stessa stregua della discoteca il sabato sera o della domenica allo stadio. Un sorriso, forse una smorfia…
Eppure, qualcosa permane e lo sa. Si alza a fatica, nel corridoio fruga nella cassapanca, una busta gialla con dentro un libro. Sono i Canti di Leopardi, la copertina ormai s’è consunta, alcune pagine scollate e i bordi si sono sfrangiati. Editoriale Romana, febbraio 1944. Lo sfoglia delicatamente. Va a pagina settantasette. Il tempo s’è fermato o, forse, gira come un disco all’inverso. Legge piano, strizzando gli occhi da presbite, appannati dalla cateratta e dalla rinnovata commozione ‘Sempre caro mi fu quest’ermo colle… e mi sovvien l’eterno, – e le morte stagioni, e la presente – e viva, e il suon di lei…’. V’è a lato una scura, indistinta ormai, macchia di un indice, il suo, sporco del sangue di Almerigo.
Comincia a far freddo, si dice, chiude il libro, accosta i vetri della finestra. In cielo rimane la luna indifferente e fredde le stelle…