Un eschimese iglulik disse un giorno a Rasmunssen: “noi consideriamo l’anima come la cosa più importante e più misteriosa di tutte”. La nostra sensibilità moderna interpreta queste parole come segno di arretratezza scientifica e culturale. Basare una società sul culto dell’anima e farne il valore “più importante di tutti” ci appare un residuo di quell’atteggiamento superstizioso che in tempi passati la nostra stessa civiltà ha conosciuto e le cui vestigia sono state rimosse dall’imporsi della razionalità, dell’informatica, della cibernetica, della neuroscienza ecc.
Ma se dicessimo all’ingenuo iglulik che la sua coscienza o i suoi sogni non provengono dall’anima ma da flussi di fotoni o elettroni che stimolano i suoi centri nervosi, come misteriosi spiritelli, trasformandosi in immagini mentali, potrebbe scambiarci per pazzi, o crederla una fiaba.
I cultori delle neuroscienze, gli ideologi della ‘coscienza corticale’, dovrebbero penare non poco per distogliere lo stesso Aristotele dalle sue concezioni di anime vegetative, sensitive, razionali, o per convincere Agostino, i neoplatonici, i Padri della Chiesa ecc. ad abbandonare le loro fatiscenti teorie sull’anima. Non sarebbe facile persuaderli che ‘anima’ è solo un modo di dire, metafora obsoleta usata per comodità da mistici e poeti che poco o nulla sanno di sinapsi. O comunicare a Cartesio che la sua res cogitans è un semplice epifenomeno della res extensa.
Secondo la scienza, il termine ‘anima’ – ovvero la summa dei nostri pensieri, ricordi, sentimenti ecc. – indica un complesso di fenomeni ‘mentali’ (termine altrettanto vago di ‘anima’ ma più neutro, privo di risonanze religiose) che nasce dalla stimolazione elettrica di centri neuronali. Su questa falsariga, potremmo pensare che sfregando quattro corde di budello si ottenga la Ciaccona per violino di Bach. L’uomo di cultura, l’amante dell’arte, resterebbero delusi. Ma la delusione non ha valore di confutazione e non può impedire che la ricerca scientifica spazzi via millenni di tradizioni animistiche. Tanto l’animismo totalizzante e primitivo, che vedeva un’anima in ogni cosa, quanto quel semi-animismo specifico, che considerava l’anima esclusivo privilegio degli esseri umani.
Dalla Rivoluzione francese in avanti, v’è stato un progressivo smantellamento delle nostre tradizionali concezioni spirituali. Una mentalità illuminista e scientista ha di fatto eroso gli archetipi dell’anima, fino a giungere alla cosiddetta “morte di Dio”. L’anima e Dio sono infatti due realtà complementari, poli di una correlazione. Come dice Silesius: «So che senza di me, Dio non può un istante vivere: se io divento nulla, deve di necessità morire». Così, senza Dio, l’anima non può vivere. E senza l’anima, il volto stesso dell’uomo viene cancellato.
La morte di Dio ha inoltre lasciato all’umanità la pesante eredità del potere. Non a caso, negli ultimi tempi, si è diffusa l’idea che “il potere è in sé cattivo”[1]. Carl Schmitt osserva che questa idea va di pari passo con l’idea che “Dio è morto”, anzi, significa la stessa cosa. Dio infatti, è fonte del Bene. Finché l’amministrazione dell’universo compete all’onnipotenza divina, si può dunque credere nella natura benefica del potere. Da quando Dio muore, il potere diventa esclusiva proprietà degli uomini, che se lo spartiscono e ne fanno un mostruoso Leviatano politico, tecnico, economico, militare ecc.
Il problema non è l’accentramento del potere nelle mani di poche persone, ma il fatto che il potere spogliato della sua natura spirituale diviene un potere impersonale. Potere tecnico, delle macchine, delle funzioni matematiche, dei grafici. L’assolutismo dell’antico monarca poteva certo essere viziato da una volontà cattiva, ma aveva ancora un’anima. Poteva scegliere tra il bene e il male e ne rispondeva a Dio. Un potere senza Dio è invece, per sua natura, disanimato. Non ha più un ‘cuore’, un centro di effusione metafisico che colleghi le nostre scelte etiche a una radice spirituale.
Di conseguenza, come si può ridurre l’anima ai tracciati elettrici dell’encefalo, si può assimilare il bene ai calcoli razionali del profitto o ai valori di esami fisiologici. Il Soggetto del bene è dimenticato, sostituito con l’astrazione di ragioni impersonali. Nell’economia, nella medicina, non pulsano più autentici bisogni umani, ma freddi modelli statistici e scientifici. Nella politica, i sistemi democratici impongono le loro strutture senz’anima, in cui il potere è delegato ai numeri.
L’anima si deposita sul fondo della coscienza moderna come il relitto di un’idea arcaica. Tutto il nostro impianto etico, giuridico, psicologico, si appoggia al concetto di anima come all’evocazione di un fantasma. La legge ritiene un uomo responsabile di un atto perché riconosce in lui un’anima libera, non una semplice una catena di eventi fisico-chimici. Questo evidentemente contraddice la scienza. Ma tutto il nostro linguaggio, la nostra cultura, letteratura, società, arte etc. svanirebbero nel nulla se negassimo l’anima. Soprattutto, l’amore pretende un’anima. “E in questo cieco corpo la mia Anima possa sentire che la tua è vicina”, canta Tennyson.
V’è certo una resistenza inconscia, nell’uomo moderno, a rinunciare all’idea di un’anima. Tuttavia, i fondamenti morali e spirituali della nostra società si sono fatalmente incrinati, piegandosi sotto il peso di una progressiva ‘disanimazione’. L’uomo moderno tende a interpretare la realtà senza più ricorrere a ipotesi come Dio o l’anima che, imprescindibili per l’uomo antico, appaiono oggi credenze anacronistiche. Il loro posto, rimasto vacante, viene occupato dai dogmi della scienza. Perciò, “frantumati in quel mulino sociale confondiamo con l’apparenza esteriore l’immagine interna di ogni uomo”[2].
Il punto è che la coscienza moderna non ha una visione dell’essere, non vede più “l’anima che sorge con noi … e da lontano è arrivata”, per usare le parole di Wordsworth. Il suo campo visivo è interamente occupato dall’esistenza. Ma l’anima non esiste, non è un fatto. A tale riguardo, possiamo essere d’accordo col negazionismo scientifico. Ex-sistere è infatti un ‘porsi fuori’. L’anima è invece la più radicale interiorità dell’essere in sé. È questo che la rende “la cosa più misteriosa di tutte”. Perché non è un oggetto osservabile, misurabile. Coincide con una totalità dell’esperienza, e non v’è dunque qualcosa di esterno che la possa definire. Noli siamo invece ipnotizzati dalle cose e non vediamo che «tutte le cose che stanno davanti a noi non sono altro che un’immagine riflessa nel cielo della conoscenza»[3].
Vediamo il sole, la luna, le stelle, senza il cielo. Noi cerchiamo nelle cose la loro causa, il loro fondamento. Ma l’anima, come il cielo, non ha fondamento. Ungrund (senza-fondo), direbbe Böhme, abisso di non-conoscenza. Se avesse un fondamento la ragione potrebbe chiedersi su cosa poggia il fondamento ecc. “A che ti reggi, questo tu non sai”[4]. Il problema è allora come si possa parlare di qualcosa che non si può conoscere. In realtà, l’anima si rivela a sé stessa con un sentimento immediato e totalmente autonomo. Indicando il proprio petto, l’uomo dice ‘io’. È il cuore, il centro dell’essere. Solo che, in questo caso, il dito non indica la luna o un luogo, ma il vuoto.
Dove sono i nostri pensieri, i nostri sogni? Non hanno dimora. L’anima è una sorta di meta-spazio non localizzabile. È il luogo che non esiste, l’utopia per eccellenza. È sciocco perciò immaginare un’anima dentro il corpo, come un autista dentro la sua auto. Un corpo non può contenere un’anima, perché un’anima non è in nessun luogo. Viceversa, l’anima può contenere infiniti corpi, infiniti mondi.
Stiamo di fronte all’anima come Agostino di fronte al tempo. Sappiamo benissimo cos’è finché non ci pensiamo. È un’intuizione silenziosa, uno sguardo senza oggetto. Una presenza che emerge rovesciando la direzione della coscienza, secondo la massima agostiniana: «in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas.» (“rientra in te: nell’intimo dell’uomo risiede la verità”).
Ma il cammino dell’introspezione è per molti faticoso e innaturale. Soprattutto per l’uomo moderno, perennemente distratto, trascinato fuori di sé da mille futili curiosità e desideri. La sua idea di anima si adagia così in qualche riposante luogo comune o in qualche venerabile dottrina. Prende per buona una teoria, come si legge in calce la soluzione a un problema matematico senza averlo capito.
Interrogarsi sull’anima richiede invece una paziente riunificazione dell’intelletto, lo sforzo di cogliere la natura propria delle cose. Questo implica che vi sia un’incognita, una x o essenza segreta dietro le apparenze dell’essere. Non si tratta però della ricerca di un ‘perché’, ma di un ‘cos’è?’ (quid est). Significa chiedersi: “chi sono io?”. La risposta non sta nei nostri dati anagrafici ma nella nostra coscienza di sé. I libri possono aiutarci a comprendere gli aspetti intellettuali e culturali del problema. Ma l’anima è un radicale ‘non-altro’ (non-aliud) e sarebbe assurdo cercarla altrove che in noi stessi.
«Interrogai me stesso»[5]. Solo così possiamo capire quello che altri prima di noi hanno capito, ma che solo una visione diretta ci può confermare. Le mie stesse parole non hanno alcun valore obiettivo. Vanno prese come testimonianza di un’osservazione soggettiva e indimostrabile.
Io credo che parlare dell’anima sia parlare di libertà. In una catena deterministica o aleatoria di eventi, come quella immaginata dalla scienza, o in una catena di sillogismi rigorosi, non v’è spazio per la libertà. Per questo il discorso sull’anima non è verificabile altro che dall’anima stessa. L’auto-chiarificazione è un atto libero cui non si possono imporre regole e condizioni: “è proprio dell’anima un logos che accresce se stesso”[6].
Chi rivolge l’attenzione alla propria luce interiore, vedrà l’anima versare i suoi archetipi eterni nella caducità delle cose sensibili, mescolando il mondo effimero dei fatti con quello durevole delle idee e dei valori. Coglierà l’eterno presente che incorpora il passato, lo conserva e lo proietta verso un futuro inesauribile. È questo che assicura perennità e coerenza alla vita. È come un discorso in cui ogni parte implica le parti precedenti e preordina le seguenti. Non è solo un atto di estemporanea creatività ma una catena di indistruttibili memorie. È un desiderio incessante, che si nutre di bellezza e di verità. E il destino non è forse che la sua lenta, paziente digestione.
In ciò io non vedo alcun conflitto tra l’anima e il corpo. Il corpo è segno e strumento dell’anima, non la sua prigione o tomba. È il punto in cui anima e mondo si toccano. Il corpo è futile se non è visto come manifestazione dell’anima, ma anche l’anima lo è, finché non si incarna in un corpo. Essendo il corpo medium dell’anima, le sue malattie non sono effetti di cause esterne ma simboli di processi spirituali. Il nascere, l’ammalarsi, il morire, non sono una contingenza naturale, ma una necessità dell’anima.
Se la interroghiamo, l’anima ci mostra le cose per quello che realmente sono: infinite. La percezione della mia finitezza nasce proprio dal contrasto tra la mia struttura psicofisica limitata e lo spazio infinito del mio essere. Se non fosse per questo sfondo illimitato non potrei concepire i miei limiti. E analogamente, questa mia natura finita mi è necessaria perché evoca l’infinito che la sostiene.
La sostanza dell’anima sembra essere la coscienza e l’amore di sé. Le immagini del mondo sono lo specchio in cui l’anima si contempla. La stessa percezione del mondo esterno è quindi auto-coscienza. La compassione, l’amore per le creature, è un riflesso del suo amore per sé. L’occhio dell’anima infatti si rispecchia in ogni cosa e tutto in lei invoca l’unità. “Dispersa collige in unum”[7]. Ma io credo che solo nella visione di Dio raggiunga la pienezza della coscienza e dell’amore.
In fondo, non puoi sapere qualcosa dell’anima. Qualsiasi cosa se ne possa dire, l’anima resiste ad ogni tentativo di comprenderla. “I confini dell’anima, per quanto lontano tu vada, non li scoprirai, neanche se percorri tutte le sue vie: così abissalmente si dispiega”[8]. Per questo non è possibile esplicitarne in forme adeguate il significato. Perché non soltanto si dispiega in un’infinita lontananza o profondità, ma si cela in un’infinita vicinanza. Non è dunque possibile misurarla con gli scandagli del pensiero razionale. E resterà sempre un nulla per chi la cerca.
“V’è una via e v’è un andare, ma non v’è chi vada”[9]. Questa è l’estrema libertà dell’anima. Non essere riconducibile a un chi o a un cosa. Questo le permette di sfuggire a ogni determinazione. Come il vento, “soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va”[10]. Le parole dell’anima sono libere, i suoi pensieri vengono e vanno per strade sconosciute. Emergono dal non-essere, dai fondali insondabili della sua libertà.
Perciò, quella cultura che rifiuta l’idea di anima finirà col cancellare anche l’idea di libertà. E di fatto noi oggi constatiamo come non solo alle nostre azioni, alle nostre parole, ma alla nostra stessa interiorità venga imposta la schiavitù di condizionamenti e meccanismi sociali sempre più oppressivi. Impariamo a nostre spese che dove arretra l’anima avanza la barbarie e la disumanità.
Infine il potere e la libertà dell’anima si ribelleranno al mondo moderno, come un impulso troppo a lungo represso. Non possiamo conoscere in anticipo gli esisti di questa rivolta. La sua libertà rende l’anima impredicibile, aperta a ogni ‘possibilità’. In lei confliggono forze opposte, pulsioni creative e distruttive sempre in precario equilibrio; ogni luce proietta un’ombra, ogni anelito all’ordine trova la resistenza del caos. E quando in lei prevale la tenebra, sul mondo cala una desolante aridità spirituale.
Allora, come dice il Fonditore di bottoni a Peer Gynt, l’anima viene buttata in un crogiuolo e rifusa. Purificata dalle scorie dell’oscurità nel calore bruciante delle fiamme. In un lungo e doloroso processo ogni grumo di tenebra deve liquefarsi, colare dall’anima come nera pece bollente. Non è una punizione. È lei stessa che chiede dal profondo di sé d’esser redenta, salvata dal suo rovinoso naufragio. Dal relitto spirituale del mondo, come da una zattera alla deriva, sentiremo alzarsi verso Dio una preghiera: Save Our Souls, salva le nostre anime.
[1] Jakob Burckhardt
[2] Alfred Tennyson
[3] Abhinavagupta
[4] Stefan George
[5] Eraclito
[6] Idem
[7] Agostino
[8] Eraclito
[9] Buddhaghosa
[10] Gv (3,8)




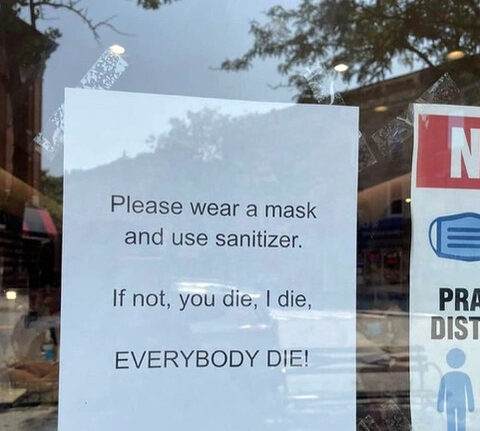


18 Comments