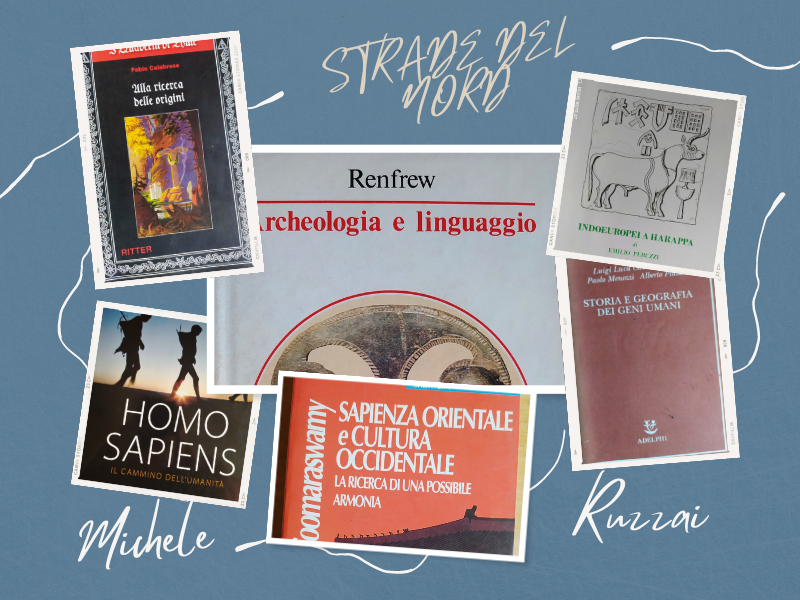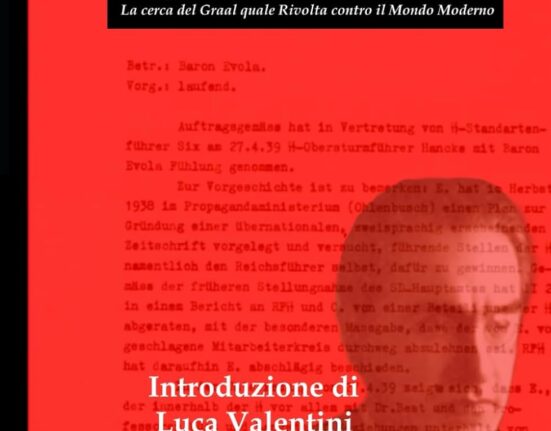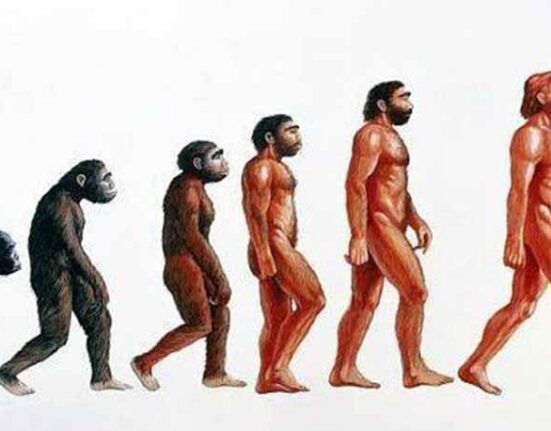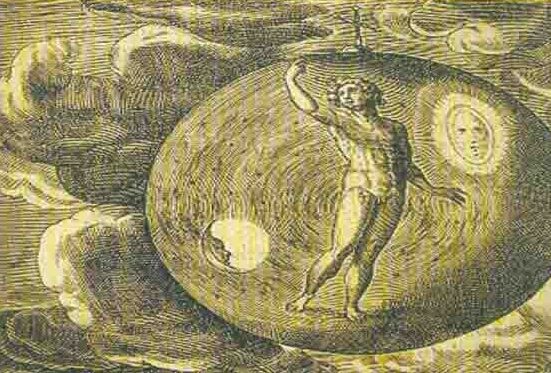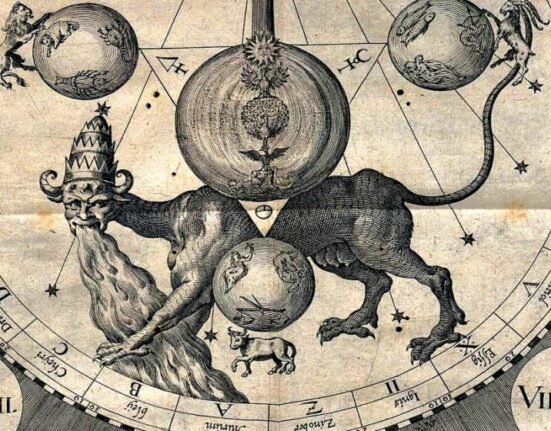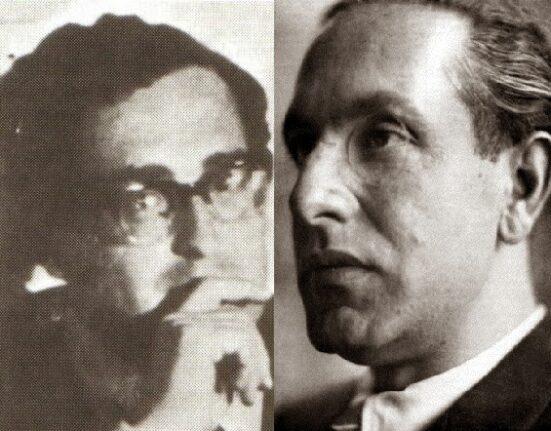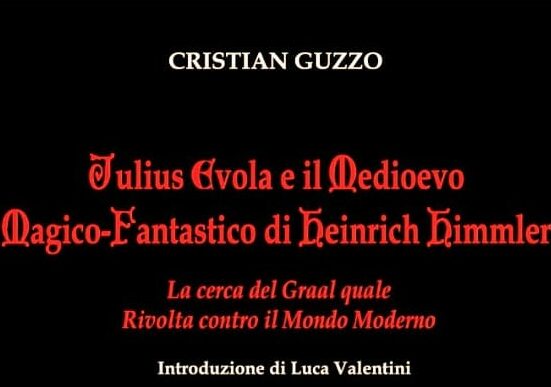(alla fine dell’articolo, prima delle Note, è presente il link dell’articolo precedente)
9.3 – “Drang nach Osten!”
Herman Wirth ritiene che una cospicua parte della migrazione marittima sudatlantica non entrò nel Mar Rosso ma si diresse verso Oriente, lasciandosi alle spalle il Corno d’Africa per costeggiare il Sud della penisola arabica.
Secondo il Nostro, i Semiti meridionali sarebbero inquadrabili nel vasto alveo di questo ciclo, anche se non è facile capire quanto nella loro origine possa aver pesato la componente riconducibile alla migrazione continentale-nordafricana da Ovest (quella già ricordata in relazione alla Urheimat afroasiatica nel Maghreb), rispetto alla parte giunta per via marittima, che per Wirth sembrerebbe invece prevalente. In ogni caso, una ramificazione di questa fece ingresso nel Golfo Persico, fino ad approdare nella Mesopotamia meridionale: qui trovò già stanziata una popolazione di ceppo sumerico che, come detto a suo tempo, era anch’essa di remotissima provenienza artico-nordica ed era entrata nel Vicino Oriente provenendo, fondamentalmente, da nord-est. I nuovi arrivati sudatlantici sarebbero quindi da considerare come la seconda stratificazione etnica dell’area, quei Mauri o Amorrei – la “gente delle navi straniere” – che abbiamo già menzionato in precedenza ed i quali, interagendo sulla prima popolazione, avrebbero concorso a formare l’antica cultura elamitica dell’Iran occidentale.
Procedendo ancor più ad Est, secondo Wirth un altro ramo della stessa migrazione sudatlantica avrebbe portato i Dravidi nel subcontinente indiano: in questo modo, quindi, il Nostro sembra sottintendere una certa comunanza di origine fra l’Elamitico ed il Dravidico, aspetto che riveste un certo interesse dal momento che tale accostamento linguistico è stato proposto anche da altri studiosi, sia più recenti (959) che meno (960).
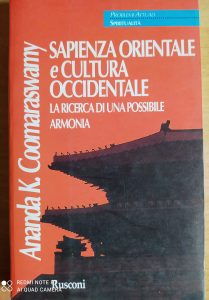 Inoltre, sul collegamento tra le genti dravidiche ed, in ultima analisi, il continente oceanico-occidentale dal quale sarebbe scaturita questa vasta corrente etnica, sembrano concordare anche altri autori: ad esempio, sia Julius Evola – che in India segnala importanti resti di civiltà collegate al ciclo atlantico-meridionale e risalenti a tempi anteriori al più recente ingresso degli Indù (961) – sia Alain Danielou, che a tale evento aggiunge un riferimento temporale ancora più preciso, ponendo questo flusso alla fine del periodo glaciale ed in corrispondenza del Diluvio biblico (962). Su questo punto torneremo sicuramente più avanti, ma per dare una prima idea possiamo già ora segnalare che, sulla base della cronologia “Guenon/Georgel” del Manvantara (963), tale cataclisma si dovrebbe collocare attorno a 13.000 anni or sono, cioè verso la metà del Dvapara Yuga. E’ una fase temporale che corrisponderà alla discesa del settimo Avatara di Vishnu, Ramachandra (964), il cui ciclo è infatti connesso alla penetrazione delle prime stirpi bianche, di provenienza occidentale, in quel subcontinente indiano che fino ad allora era stato popolato da Dasyus, cioè genti di razza gialla e nera (965), probabilmente paleomongolidi e veddoidi/australoidi.
Inoltre, sul collegamento tra le genti dravidiche ed, in ultima analisi, il continente oceanico-occidentale dal quale sarebbe scaturita questa vasta corrente etnica, sembrano concordare anche altri autori: ad esempio, sia Julius Evola – che in India segnala importanti resti di civiltà collegate al ciclo atlantico-meridionale e risalenti a tempi anteriori al più recente ingresso degli Indù (961) – sia Alain Danielou, che a tale evento aggiunge un riferimento temporale ancora più preciso, ponendo questo flusso alla fine del periodo glaciale ed in corrispondenza del Diluvio biblico (962). Su questo punto torneremo sicuramente più avanti, ma per dare una prima idea possiamo già ora segnalare che, sulla base della cronologia “Guenon/Georgel” del Manvantara (963), tale cataclisma si dovrebbe collocare attorno a 13.000 anni or sono, cioè verso la metà del Dvapara Yuga. E’ una fase temporale che corrisponderà alla discesa del settimo Avatara di Vishnu, Ramachandra (964), il cui ciclo è infatti connesso alla penetrazione delle prime stirpi bianche, di provenienza occidentale, in quel subcontinente indiano che fino ad allora era stato popolato da Dasyus, cioè genti di razza gialla e nera (965), probabilmente paleomongolidi e veddoidi/australoidi.
Se dunque pare certa la connotazione razziale, caucasoide e decisamente occidentale, dei Dravidi (966), meno sicure sono le modalità ed i percorsi di questo ingresso nell’area austroasiatica, dal momento che, come detto, Wirth propone una via essenzialmente marittima che però non risulta sia condivisa da altri ricercatori. Ciò che in ogni caso si può dire, prescindendo dal piano linguistico e rimanendo su quello più propriamente antrolopogico, è che l’elemento caucasoide indiano risulta molto simile a quello mediterraneo, verso il quale sfuma quasi impercettibilmente attraverso il tipo orientalide del Vicino Oriente: la fisionomia prevalente ovunque è cioè quella dolicocefala, di piccola statura, con il volto alto e sottile (967) riscontrabile come genericamente “protomediterranea” fin dal Natufiano palestinese del tardo Pleistocene in una fascia estesa dall’Egeo fino all’Indo (968). Se consideriamo che anche la dinamica diffusoria di questa stirpe ebbe essenzialmente uno sviluppo da Ovest verso Est – cioè dal Levante attraverso la Mesopotamia e la Persia, fino all’India (969) – e che lo stesso movimento viene ipotizzato anche per la propagazione delle lingue dravidiche (970), sembrano sussistere buone ragioni per sovrapporre i due soggetti in marcia e quindi concludere che i popoli elamo-dravidici arrivarono nel quadrante indo-iranico per via continentale e non per via marittima, come invece proposto da Wirth.  Oltretutto, tale idea troverebbe un’ulteriore conferma nella ipotesi formulata dall’archeologo britannico Colin Renfrew a proposito della comune origine elamo-dravidica localizzata nel “lobo” dei Monti Zagros nell’Iran occidentale, alla quale sarebbe seguita un’espansione neolitico-agricola verso Est (971) fino ad arrivare all’area indiana e costituire la base etnica della civiltà di Harappa e Mohenjo-Daro, il cui tipo fisico fondamentale fu proprio, come detto sopra, quello dolicocefalo protomediterraneo (972): un’ipotesi suffragata anche dalle frequenze molecolari degli indiani odierni che evidenziano una forte affinità con gli antichi agricoltori provenienti dall’Iran (973).
Oltretutto, tale idea troverebbe un’ulteriore conferma nella ipotesi formulata dall’archeologo britannico Colin Renfrew a proposito della comune origine elamo-dravidica localizzata nel “lobo” dei Monti Zagros nell’Iran occidentale, alla quale sarebbe seguita un’espansione neolitico-agricola verso Est (971) fino ad arrivare all’area indiana e costituire la base etnica della civiltà di Harappa e Mohenjo-Daro, il cui tipo fisico fondamentale fu proprio, come detto sopra, quello dolicocefalo protomediterraneo (972): un’ipotesi suffragata anche dalle frequenze molecolari degli indiani odierni che evidenziano una forte affinità con gli antichi agricoltori provenienti dall’Iran (973).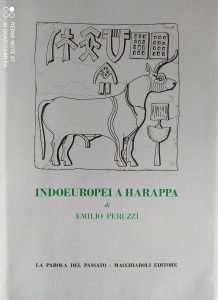
Sennonchè è lo stesso Colin Renfrew a proporre un’interessante variante della sua teoria che riteniamo valga la pena menzionare in questo contesto: ovvero sostituendo, nella Civiltà della valle dell’Indo, l’elemento elamo-dravidico addirittura con quello indoeuropeo.
In effetti abbiamo già visto che l’archeologo britannico sostiene per l’Europa un modello simile, facendo cioè coincidere l’indoeuropeizzazione del nostro continente con l’avanzata degli agricoltori anatolici e la diffusione delle tecniche neolitiche. Ma se per l’Europa tale ipotesi non ci sembra convincente – per i tanti motivi espressi in precedenza – per il subcontinente indiano, come vedremo, la teoria in questione potrebbe invece avere qualche fondamento in più. In quest’ottica, a parere di Renfrew, negli “Inni del Rigveda” non vi sarebbero elementi tali da dimostrare inequivocabilmente che la popolazione di lingua vedica (cioè di ceppo indoeuropeo) sia intrusiva nella regione indiana secondo il quadro invasionista classico e quindi lo studioso suggerisce la possibilità che la civiltà della valle dell’Indo avesse già parlato una lingua indoeuropea arcaica antenata del Sanscrito, giunta nell’area secondo il modello dell’espansione agricolo-neolitica (974). Ciò soprattutto in considerazione del fatto che, dal punto di vista prettamente archeologico, sembrerebbero non sussistere chiare e conclusive testimonianze di devastazioni e saccheggi che avrebbero messo fine alla civiltà della valle dell’Indo per opera di traumatiche invasioni dall’esterno (975). L’ipotesi dunque di una profonda retrodatazione della presenza indoeuropea nel subcontinente indiano sarebbe ad esempio coerente con le teorie a suo tempo formulate da Hrozny sulla similitudine fra le iscrizioni rinvenute a Mohenjo Daro e quelle di ambito ittita (976) ed anche con le più recenti osservazioni che, in chiave opposta, avrebbero invece evidenziato una nettissima differenza, soprattutto nei numerali, che la grafia protoindiana denoterebbe con le lingue dravidiche, tanto da escluderne decisamente un rapporto di derivazione (977).
In effetti, a nostro avviso, il modello di indoeuropeizzazione neolitica potrebbe essere più convincente in questo contesto rispetto a quello europeo perché mentre per il nostro continente, come abbiamo visto, vi sono diversi elementi per collocare l’Urheimat primaria molto lontano dall’Anatolia, direttamente in casa nostra – sebbene nell’estremo nord-est – e comunque notevolmente più indietro nel tempo rispetto a quanto proposto da Renfrew, il quadro è piuttosto diverso per il subcontinente indiano, dove sussistono resistenze di altro tipo, legate all’ormai radicata idea di un’invasione indo-aria estremamente recente, situabile appena nel II° millennio a.c. In altri termini, per respingere la teoria dell’archeologo britannico, noi Europei siamo “agevolati” dal fatto che disponiamo di troppi elementi per collocare l’Urheimat indoeuropea al di qua degli Urali e quindi non seguire Renfrew già fin dal primo punto della sua ipotesi – ovvero l’Urheimat anatolica – elemento del quale invece non dispone l’India, dato che il mito di una “culla” protoindoeuropea collocata nelle sue immediate vicinanze non è praticamente più seguito da almeno un secolo e mezzo: l’India, quindi, deve sempre e comunque porsi in una prospettiva necessariamente invasionista, ma ciò non significa che non vi siano spazi per riconsiderare tempistiche, modalità e traiettorie d’ingresso degli Indoeuropei nelle sue terre. Ecco perchè riteniamo che, su questo preciso punto, le argomentazioni di Renfrew possano avere un certo fondamento, ovvero nella questione se i primi Indoeuropei giunti sulle rive del Gange corrisposero ai più recenti nomadi a cavallo di età calcolitica, o se invece si identificarono con i più antichi agricoltori di età neolitica.
Sotto questa luce, dunque, il tema centrale è legato alla questione su “chi furono” gli agricoltori che, come sembra accertato, erano partiti dal “lobo” dei monti Zagros per arrivare in India. E’ ovvio che su tale questione, ovviamente di carattere più etnico che archeologico, si possono solo avanzare delle mere ipotesi non sussistendo, per l’età neolitica, iscrizioni decifrabili e quindi collocabili nell’alveo di una qualsivoglia famiglia linguistica. E su questo punto, come dicevamo, è lo stesso archeologo britannico a proporre una duplice possibilità.
Se, come nella prima formulazione teorica di Renfrew (978), questi agricoltori parlavano lingue elamo-dravidiche, è molto probabile che dovette essere proprio questo l’idioma della civiltà di Harappa e Mohenjo-Daro, il che sembrerebbe anche coerente con le soprastanti note sulla provenienza occidentale dei Dravidi: un quadro che, dunque, non è antitetico alle visuali convenzionali oggi dominanti basate su di un’indoeuropeizzazione solo recente del subcontinente indiano.
Ma se invece, come l’archeologo britannico contempla in una seconda formulazione della sua teoria, tali agricoltori erano di lingua protoindoeuropea, è chiaro che il quadro muta radicalmente. A nostro avviso è un’idea da non scartare a piori ma a patto di sganciarla dall’ipotesi, correlata, di una Urheimat indoeuropea mediorientale e di riconciliarla con quella seguita in questo scritto (ovvero, posta nel nord-est europeo e di datazione paleolitica): sotto tale pemessa, la presenza protoindoeuropea sui monti Zagros potrebbe cioè essere derivata da una ancora più antica presenza nel nostro continente. Dal quale, azzardiamo un’ipotesi, alcune correnti potrebbero essere giunte nel quadrante mediorientale già in tempi tardo-paleolitici e seguendo due possibili vie: una prima che abbiamo già intuito in precedenza, cioè quella “transcaucasica” più diretta ed antica, che come dicevamo dovette essere collegata all’enucleazione della componente autosomica CHG sulle sponde orientali del Mar Nero; oppure una seconda che vedremo più avanti, fondamentalmente atlanto-mediterranea, più indiretta e recente, propria a quella fase “ario-atlantica” che sviluppò una migrazione grossomodo di direzione Ovest => Est.
L’uno o l’altro, o anche entrambi, di questi due flussi potrebbero quindi aver portato nel Medio Oriente delle lingue che, se non ancora riconoscibili come indoeuropee in senso stretto, quanto meno potrebbero essere state “indogermanoidi” come nella definizione di Kretschmer. Gruppi che poi, sui Monti Zagros, nel corso di qualche millennio avrebbero sviluppato quelle tecniche agricole poi necessarie per espandersi ulteriormente ad Est, ma ormai da contadini, e così arrivare fino ad Harappa e Mohenjo-Daro. Un tanto anche in considerazione del fatto che, dal punto di vista genetico, è stata riscontrata una notevole continuità fra le popolazioni neolitiche dell’Iran occidentale ed i cacciatori-raccoglitori che li avevano preceduti in zona (979). In questa cornice, dunque, il Protoelamita attestato nell’Iran meridionale potrebbe non essere stato autoctono ma sarebbe arrivato, magari appunto per via marittima, solo successivamente alla diffusione continentale delle lingue protoindoeuropee (980): e così anche il Protodravidico, quindi in coerenza con le ipotesi di Herman Wirth. Ma tuttavia – molto significativamente – Renfrew riconosce di buon grado che questa ipotesi non escluda per forza quella invasionista classica e di indoeuropeizzazione recente, perché il subcontinente indiano potrebbe comunque aver ricevuto in tempi diversi due distinte ondate ariane (981), cioè una più antica e neolitica da Ovest ed una più recente e calcolitica da Nord.
In ogni caso, nella vasta ricostruzione di Herman Wirth, le correnti sudatlantiche non si sarebbero fermate all’India, ma proseguirono oltre.
Spingendosi cioè fino in Indonesia, nella Nuova Guinea ed in Oceania, avrebbero qui fondato la cultura dei Maori della Nuova Zelanda, che il Nostro inserisce in questo ciclo confortato dalla sensibile somiglianza del loro etnonimo con quello dei Mauri e della Mô-uru atlantica, ma anche per le relative caratteristiche fenotipiche che evidenziano dei tratti piuttosto vicini allo standard caucasoide (982). Si tratta comunque di una morfologia presente anche in molti altri popoli polinesiani (983), a volte in modo particolarmente spiccato come nel caso degli abitanti delle isole Marchesi (984), che hanno portato diversi antropologi a classificare queste genti nel gruppo delle razze bianche (985), o quanto meno a considerarle il frutto di una mistione nella quale sarebbe entrato in non trascurabile quota un elemento genericamente caucasoide (986), se non addirittura quello più specificatamente ario-nordeuropeo (987).
9.4 – “Go west!”
Dopo essere giunti agli estremi lembi orientali del pianeta, ritorniamo ora al “rifugio” euro-occidentale di epoca solutreana che avevamo lasciato indietro quando ci siamo avventurati oltre Gibilterra.
Questo rifugio non rappresentò uno snodo di rilievo solo in relazione al Sud ed al mondo maghrebino, ma probabilmente rivestì una funzione non trascurabile anche nei confronti dell’Ovest, fino addirittura in America. Vi è infatti la sorprendente possibilità che alcuni gruppi umani possano aver attraversato l’Oceano Atlantico con una navigazione di piccolo cabotaggio appoggiata alla banchisa ghiacciata, o forse addirittura percorrendo aree al tempo ancora emerse, soprattutto nei settori più settentrionali. E’ questo un tema che da vari decenni è stato preso in considerazione non soltanto sulla base di supposizioni “atlantologiche”, va riconosciuto, dalla solidità spesso discutibile, ma indagando il problema anche in termini geologici sulla possibilità di una diversa conformazione delle terre oceaniche in età glaciale. In effetti alcuni elementi sembrerebbero confermare che la soglia nordatlantica, collocata tra la Scozia e la Groenlandia, a suo tempo doveva essere decisamente meno profonda degli attuali 600 metri medi (988), con la concreta possibilità che, anche in concomitanza con il più basso livello marino connesso all’LGM, vi potessero essere numerose aree emerse tra Groenlandia, Islanda ed Isole Faroer (989). Terre il cui ricordo forse giunse fino a tempi piuttosto recenti, se così vogliamo interpretare la grande isola ad est della Groenlandia raffigurata nella mappa di Zeno del XVI secolo e che probabilmente non corrisponde all’Islanda (990): si trattò di lembi probabilmente estesi fino alla Scandinavia (991), quindi anche approssimativamente nel settore dove oggi si trova l’isola di Jan Mayen, tra Mar di Groenlandia e Mar di Norvegia.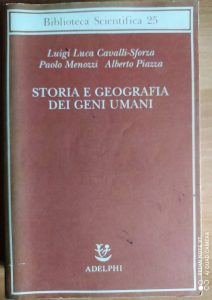
Da un punto di vista antropologico, inoltre, non sono sfuggiti ai ricercatori alcuni tratti di somiglianza fenotipica evidenziati da diverse tribù native americane, soprattutto settentrionali, con la specifica linea cromagnoide europea e che potrebbero effettivamente confermare le ipotesi di un attraversamento atlantico tardo-paleolitico (992) o comunque, secondo le teorie di Herman Wirth, di connessioni con le genti oceanico-fomoriane. E’ in ogni caso opportuno sottolineare come tale ipotesi non vada confusa con quella, di prospettiva ben più antica, relativa invece alla comune origine filogenetica e, segnatamente, della particolare vicinanza tra i gruppi boreali nell’ambito della “meta-popolazione” già ricordata in precedenza. La fase arcaica, infatti, troverebbe evidenza nel substrato più profondo dei Nativi americani, il cui canone non può certamente esser fatto ricadere per intero nell’alvero razziale mongoloide (993), ma che risentirebbe invece di un’importante base paleo-caucasoide di derivazione antichissima, analoga ad esempio a quella del tipo Chu-cu-tien o simil-Ainu, definibile anche “amuriana”, “paleoamericana” (Deniker) o “pre-europide”. Una base, in definitiva, non distante dalla già descritta linea capelloide (994), che avrebbe fatto ingresso nel continente americano ben prima della definitiva fissazione delle caratteristiche “gialle” e troverebbe logica conferma anche nei fenotipi molto vicini a quelli europoidi, e quasi del tutto privi di elementi mongoloidi, riscontrabili nelle popolazioni più australi d’America – cioè quelle che, si presume, sono le odierne discendenti delle “avanguardie” più antiche del popolamento americano – come ad esempio i Fueghini (995).
Ma appunto questo è un tema precedente a quello toccato adesso, che invece si colloca solo in un momento tardo-paleolitico e riguarda l’arrivo in America di una linea umana più specificata, rispetto alla precedente e sfumata “paleocaucasoide”, cioè ora quella afferente al tipo Cro-Magnon, i cui movimenti sarebbero riscontrabili anche in tracce genetiche più definite rispetto all’andamento generale, essenzialmente nord-sud, della già vista “prima componente principale” americana (996): infatti, i gradienti disegnati dalla seconda, terza e quarta componente continentale, evidenziano dei significativi  picchi nelle aree più orientali del Nordamerica (ed anche in Groenlandia, come vedremo più avanti) che starebbero ad indicare dei probabili fenomeni di mescolamento tra Nativi autoctoni e gruppi caucasoidi di più recente penetrazione (997). Da non dimenticare, oltretutto, le analisi dal punto di vista autosomico, le cui risultanze nel genoma amerindio ne attribuirebbero un buon terzo alla componente “ANE”, cioè gli “Antichi Nord Eurasiatici”, che è ben presente nelle popolazioni europee (998), anche se riteniamo che l’interpretazione di tale evidenza potrebbe essere tentata, benchè forse con minore forza esplicativa, pure nel quadro della remota origine comune dei due gruppi. La questione è comunque ben lungi dall’essere chiusa e le due ipotesi non dovrebbero necessariamente essere incompatibili.
picchi nelle aree più orientali del Nordamerica (ed anche in Groenlandia, come vedremo più avanti) che starebbero ad indicare dei probabili fenomeni di mescolamento tra Nativi autoctoni e gruppi caucasoidi di più recente penetrazione (997). Da non dimenticare, oltretutto, le analisi dal punto di vista autosomico, le cui risultanze nel genoma amerindio ne attribuirebbero un buon terzo alla componente “ANE”, cioè gli “Antichi Nord Eurasiatici”, che è ben presente nelle popolazioni europee (998), anche se riteniamo che l’interpretazione di tale evidenza potrebbe essere tentata, benchè forse con minore forza esplicativa, pure nel quadro della remota origine comune dei due gruppi. La questione è comunque ben lungi dall’essere chiusa e le due ipotesi non dovrebbero necessariamente essere incompatibili.
Inoltre, la teoria del remoto arrivo europeo in America è stata analizzata anche sul piano archeologico fin dagli anni ’60 del secolo scorso da E.F. Greenman (999), ricercatore che è stato ripreso e menzionato anche da studiosi successivi (1000).
L’elemento fondamentale a sostegno di tali ipotesi è la fortissima similitudine, evidenziata fino nei minimi dettagli, delle tecnologie litiche solutreane europee con quelle riscontrare, qualche millennio dopo, nel contesto Clovis americano (1001), i cui tratti peculiari non sembrano neanche lontanamente ravvisabili né tra le coeve culture asiatico-siberiane (1002) né in Alaska; ma nemmeno nelle aree prossime a quello strettissimo passaggio canadese che per un certo periodo dovette essere libero dai ghiacci (1003), noto come “corridoio Yukon-Alberta”, lungo il quale potrebbero essere transitati alcuni gruppi nativi americani dalle aree della Beringia verso meridione. Per contro, invece, siti archeologici significativamente collocati sulla costa atlantica degli Stati Uniti d’America, come ad esempio Meadowcroft Rockshelter in Pennsylvania, con reperti datati al radiocarbonio a più di 16.000 anni fa (1004), o quello di Cactus Hill in Virginia risalente ad almeno 15.000-17.000 anni or sono (1005), oltre a confermare anch’essi l’esistenza di un ormai incontestabile popolamento “pre-Clovis” americano – evidenziato anche dagli altri siti ancora più antichi già segnalati in precedenza – sembrerebbero presentare alcuni elementi stilistici chiaramente precursori della successiva tecnologia Clovis (1006).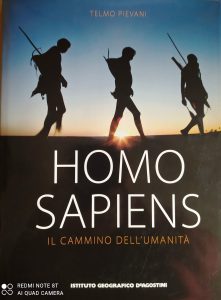
In definitiva, dal punto di vista geologico, antropologico, genetico ed archeologico, vi è dunque un ragguardevole numero di elementi che sembrerebbero suggerire la concreta possibilità di contatti transoceanici verificatisi in epoche tardo-paleolitiche, sia in concomitanza con la cultura solutreana che con quella successiva del Magdaleniano di cui parleremo prossimamente.
Link articolo precedente:
NOTE
959. Mario Alinei – Origini delle lingue d’Europa. Volume 1: La Teoria della Continuità – Il Mulino – 1996 – pag. 320; Harald Haarmann – Storia universale delle lingue. Dalle origini all’era digitale – Bollati Boringhieri – 2021 – pag. 131
960. Alfredo Trombetti – Le origini della lingua basca – Arnaldo Forni Editore – 1966 – pag. 156
961. Julius Evola – Rivolta contro il mondo moderno – Edizioni Mediterranee – 1988 – pag. 300
962. Alain Danielou – La Fantasia degli Dei e l’Avventura Umana – CasadeiLibri Editore – 2013 – pagg. 26, 60, 61, 68
963. Giuseppe Acerbi – La questione dei “Tre Diluvi” nella tradizione ellenica – in: Algiza, n. 9, Gennaio 1998, pag. 13; Gaston Georgel – Le quattro Età dell’umanità. Introduzione alla concezione ciclica della storia – Il Cerchio – 1982 – pag. 211
964. L.M.A. Viola – Religio Aeterna, vol. 2. Eternità, cicli cosmici, escatologia universale – Victrix – 2004 – pag. 128
965. René Guénon – L’archeometra – Editrice Atanòr – 1992 – pagg. 12, 49; Fabio Ragno – Iniziazione ai Miti della Storia. Frammenti di una storia perduta – Edizioni Mediterranee – 1999 – pag. 80
966. Domenico Silvestri – La nozione di indomediterraneo in linguistica storica – Macchiaroli – 1974 – pag. 30
967. Georg Glowatzki – Le razze umane. Origine e diffusione – Editrice La Scuola – 1977 – pag. 51
968. Mario Cappieri – I Protomediterranei dalle regioni dell’Egeo al Bengala – in: Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica, 1957, pag. 94
969. Giuseppe Sergi – I Britanni – Settimo Sigillo – 1987 – pag. 57
970. Alain Danielou – La Fantasia degli Dei e l’Avventura Umana – CasadeiLibri Editore – 2013 – pag. 62; Domenico Silvestri – La nozione di indomediterraneo in linguistica storica – Macchiaroli – 1974 – pag. 192
971. Colin Renfrew – Le origini delle lingue indoeuropee – in: Le Scienze, Dicembre 1989, pagg. 105-106
972. Domenico Silvestri – La nozione di indomediterraneo in linguistica storica – Macchiaroli – 1974 – pag. 21
973. David Reich – Chi siamo e come siamo arrivati fin qui. Il DNA antico e la nuova scienza del passato dell’umanità – Raffaello Cortina Editore – 2019 (copia in pdf) – pagg. 132, 191
974. Colin Renfrew – Archeologia e linguaggio – Editori Laterza – 1989 – pagg. 204, 206
975. David Reich – Chi siamo e come siamo arrivati fin qui. Il DNA antico e la nuova scienza del passato dell’umanità – Raffaello Cortina Editore – 2019 (copia in pdf) – pag. 167
976. Giacomo Devoto – Origini indeuropee – Sansoni – 1962 – pag. 174
977. Emilio Peruzzi – Indoeuropei a Harappa – Macchiaroli Editore – 2002 – pagg. 461, 465, 466
978. Colin Renfrew – Le origini delle lingue indoeuropee – in: Le Scienze, Dicembre 1989, pagg. 105-106
979. David Reich – Chi siamo e come siamo arrivati fin qui. Il DNA antico e la nuova scienza del passato dell’umanità – Raffaello Cortina Editore – 2019 (copia in pdf) – pag. 131
980. Colin Renfrew – Archeologia e linguaggio – Editori Laterza – 1989 – pag. 216
981. Colin Renfrew – Archeologia e linguaggio – Editori Laterza – 1989 – pag. 236
982. Renato Biasutti – Razze e Popoli della terra – UTET – 1967 – vol. 1 – pag. 506
983. Vittorio Marcozzi – L’Uomo nello spazio e nel tempo – Casa Editrice Ambrosiana – 1953 – pag. 159
984. Felice Vinci – I misteri della civiltà megalitica – La clessidra edizioni – 2020 – pag. 266; Felice Vinci – I segreti di Omero nel Baltico. Nuove storie della preistoria – Leg Edizioni – 2021 – pag. 432; Felice Vinci – Omero nel Baltico. Saggio sulla geografia omerica – Fratelli Palombi Editori – 1998 – pag. 399
985. Henry V. Vallois – Le razze umane – Garzanti – 1957 – pag. 91
986. Vittorio Marcozzi – L’Uomo nello spazio e nel tempo – Casa Editrice Ambrosiana – 1953 – pag. 159
987. Renato Biasutti – Razze e Popoli della terra – UTET – 1967 – vol. 4 – pag. 27
988. Edith Ebers – La grande era glaciale – Sansoni – 1957 – pag. 168
989. Alberto Malatesta – Geologia e paleobiologia dell’era glaciale – La Nuova Italia Scientifica – 1985 – pag. 78
990. Charles H. Hapgood – Le mappe delle civiltà perdute. Le prove dell’esistenza di una civiltà avanzata nell’Era Glaciale – Mondo Ignoto – 2004 – pag. 191
991. Charles H. Hapgood – Lo scorrimento della crosta terrestre – Einaudi – 1965 – pag. 283
992. Fiorenzo Facchini – Il cammino dell’evoluzione umana. Le scoperte e i dibattiti della paleoantropologia – Jaca Book – 1994 – pag. 177; Raffaello Parenti – Lezioni di antropologia fisica – Libreria Scientifica Giordano Pellegrini – 1973 – pag. 323
993. Renato Biasutti – Razze e Popoli della terra – UTET – 1967 – vol. 1 – pag. 508
994. Renato Biasutti – Razze e Popoli della terra – UTET – 1967 – vol. 1 – pag. 510 e vol. 4 – pag. 329; Fiorenzo Facchini – Il cammino dell’evoluzione umana. Le scoperte e i dibattiti della paleoantropologia – Jaca Book – 1994 – pag. 177; Raffaello Parenti – Lezioni di antropologia fisica – Libreria Scientifica Giordano Pellegrini – 1973 – pag. 322
995. Renato Biasutti – Razze e Popoli della terra – UTET – 1967 – vol. 1 – pagg. 509, 513, 514
996. Luigi Luca Cavalli Sforza, Paolo Menozzi, Alberto Piazza – Storia e geografia dei geni umani – Adelphi – 1997 – pag. 635
997. Luigi Luca Cavalli Sforza, Paolo Menozzi, Alberto Piazza – Storia e geografia dei geni umani – Adelphi – 1997 pagg. 636, 638-641
998. Fabio Calabrese – Alla ricerca delle origini – Ritter – 2020 – pag. 196; David Reich – Chi siamo e come siamo arrivati fin qui. Il DNA antico e la nuova scienza del passato dell’umanità – Raffaello Cortina Editore – 2019 (copia in pdf) – pag. 118
999. E.F. Greenman – The Upper Paleolithic and the New World – Current Anthropology – 1963
1000. Bruce Bradley, Dennis Stanford – The North Atlantic ice-edge corridor: a possible Palaeolithic route to the New World – in: World Archaeology, vol. 36, n. 4, 2004, pag. 465; Jean-Francois Le Mouel – Preistoria del Nordamerica – in: AA.VV. (a cura Jean Guilaine), La preistoria da un continente all’altro, Gremese Editore, 1995, pag. 117
1001. Bruce Bradley, Dennis Stanford – The North Atlantic ice-edge corridor: a possible Palaeolithic route to the New World – in: World Archaeology, vol. 36, n. 4, 2004, pag. 465; Aldo Conti – L’enigma dei primi americani – in: Le Scienze, Ottobre 2003, pag. 27; Raffaello Parenti – Lezioni di antropologia fisica – Libreria Scientifica Giordano Pellegrini – 1973 – pag. 322; Steve Olson – Mappe della storia dell’uomo. Il passato che è nei nostri geni – Einaudi – 2003 – pagg. 228, 231, 232; Luca Sciortino – Un giapponese in America – in: Le Scienze – Giugno 2006
1002. Fabio Calabrese – Alla ricerca delle origini – Ritter – 2020 – pag. 191; Steve Olson – Mappe della storia dell’uomo. Il passato che è nei nostri geni – Einaudi – 2003 – pag. 232
1003. Bradley, Dennis Stanford – The North Atlantic ice-edge corridor: a possible Palaeolithic route to the New World – in: World Archaeology, vol. 36, n. 4, 2004, pagg. 462, 463
1004. Ivan Briz Godino – Chi erano i primi veri abitanti d’America? – Storica National Geografic – 23/9/2020 – https://www.storicang.it/a/chi-erano-i-primi-veri-abitanti-damerica_14630; Telmo Pievani – Homo Sapiens. Il cammino dell’umanità – De Agostini – 2012 – pag. 103
1005. Michael F. Johnson – Cactus Hill Archaeological Site – https://www.encyclopediavirginia.org/Cactus_Hill_Archaeological_Site; Telmo Pievani – Homo Sapiens. Il cammino dell’umanità – De Agostini – 2012 – pag. 103
1006. Bruce Bradley, Dennis Stanford – The North Atlantic ice-edge corridor: a possible Palaeolithic route to the New World – in: World Archaeology, vol. 36, n. 4, 2004, pag. 472