Dopo essermi posto per lungo tempo la domanda “a che serve la religione?” son giunto a questa conclusione: “a nulla”. La sua importanza sta proprio nel mostrarci il valore dell’inutile, la bellezza di un agire senza scopo. La ricerca dell’utile indurisce il cuore, la religione lo ammorbidisce. Parlare di utilità della religione è dunque possibile solo in senso traslato. Viceversa, quando si parla del suo danno, lo si può ben fare in senso letterale, ricordando le concrete circostanze in cui la religione ha nuociuto all’uomo. È questa la ragione per cui, carichi di livore, molti se ne allontanano prima d’averne ben compreso la natura.
Alcuni sembrano rallegrarsi all’idea che nella società futura non esisteranno religioni. Secondo loro sarà la scienza a rispondere alle domande dell’uomo, e la tecnica a soddisfarne i bisogni. Ne consegue che non sentiremo più alcuna sete di Assoluto, né necessità che una macchina non possa contentare. La felicità consisterà nel godere di cose reali, oggettive, non di consolazioni metafisiche e immaginari aldilà. Tali profeti dan per certo che la religione diverrà una cosa inutile, non sapendo che lo è sempre stata. E non s’accorgono d’auspicare in fondo l’avvento d’una nuova religione, che sia culto dell’utile, fede nella scienza, promessa di paradisi terreni, sottomissione all’autorità di nuove Chiese.
Forse, come talvolta si dice del comunismo, la religione è rimasta sempre e soltanto una grande utopia. A legger la Storia del Guicciardini si crederebbe che nell’Italia rinascimentale, che si diceva cristiana, non esistessero religione, coscienza, virtù, e che dietro ogni azione umana si nascondessero sempre intrighi, vizi e corruzione. Cinismo dello storico? Più probabilmente specchio fedele d’una società che, come l’attuale, ama enunciare nobili principi senza metterli in pratica.
Le religioni sono “l’opera di persone d’ingegno a vantaggio degli spiriti mediocri e tardivi”, direbbe Chamfort. Nei dogmi e negli assiomi della religione i pigri credono di trovare la verità in modo rapido e sicuro, il che li dispensa dalla fatica di cercarla. Per questo, su tali credenti cala spesso l’ombra di un’esistenza inautentica, di ideali inapplicati.
Si può dire che la religione sia utile all’uomo perché lo educa a nobili intenti, lo sprona a coltivare valori etici, perseguire riforme umanitarie, compier battaglie per la giustizia ecc.. Tuttavia, questo sarebbe possibile anche a una dottrina puramente morale e, per altro, non sembra compensare i danni arrecati all’umanità dai settarismi fanatici, dalle persecuzioni e dalle guerre a sfondo religioso. Ma son questi giudizi che si fermano al sociale, allo storico e al psicologico, senza cogliere l’essenza del fenomeno religioso. Dunque, qual è il senso della religione?
Secondo san Gerolamo ‘giudeo’ significa “colui che vede Dio”. L’etimologia è dubbia ma è questa probabilmente la definizione più esatta di ciò verso cui tende lo spirito religioso. Esperienza quindi soggettiva, dato che non è possibile vedere con gli occhi di altri. La religione mi pare un’originaria scienza dell’essere, poi decaduta a credenza in oggetti astratti e sovrannaturali. Più che indurre l’uomo a rientrare in sé stesso, a cercare quella verità che “abitat in interiore homine”, produce in lui forme di falsa coscienza e lo irretisce in realtà oggettive, fuori di lui.
Comunemente si pensa che la religione incoraggi nell’uomo fantasie soggettive, l’elaborazione di entità fittizie. Ma questo significa solo che offre alla sua immaginazione oggetti che suscitano in lui particolari disposizioni interiori. La sua stessa anima diventa come un guanto rovesciato, un’interiorità esteriorizzata, e Dio l’Oggetto assoluto e sovrano che incombe sopra il suo destino.
Anche la preghiera oggettiva, che chiede qualcosa, ha in sé una volontà di appropriazione profana, estranea alla dimensione del sacro, che la allontana da quella contemplazione senza scopo che è prerogativa della vera religione. Un atto autenticamente religioso non si pone obiettivi. Infatti, la religione è vita dell’anima e l’anima è solo nel soggetto. L’esito coerente di una mentalità oggettiva sarà dunque la cancellazione dell’anima o la sua reificazione. Tale prospettiva è tipica di una scienza che ci inclina a vedere obiettivamente il mondo, credendo così di riportarci dai luoghi dell’immaginazione mitica o religiosa ai fatti nudi e reali della fisica. In realtà spostando la nostra fede nella realtà degli oggetti metafisici a cose fisiche, del cui ordine, della cui consistenza, non è più Dio il supremo garante ma la Natura. Finché la meccanica quantistica non ci fa notare che è l’osservatore a creare la realtà, rimediando in parte all’oblio del soggetto cui una Metafisica dell’oggetto ci aveva abituati.
Si crede che una percezione oggettiva del mondo debba avere chiarezza ed evidenza ‘cartesiane’, forse dimenticando che Cartesio, nella sua ricerca di un fondamento ultimo, approdò a un radicale soggettivismo. E forse lui stesso preferì scordarsene, preoccupato di riportare l’oggettività nelle cose e nelle idee, nelle anime e in Dio. Ma per Descartes l’utilità della metafisica stava nel fornire fondamenta stabili alla fisica e alla morale. I corpi sensibili, oggetti della fisica, gli parevano realtà dubitabili, finché la loro realtà non fosse dimostrata da ragioni universali. E la stessa fisica trovava per lui ragion d’essere nella sua utilità per la tecnica e la costruzione di macchine. La sua ricerca aveva dunque fin dall’inizio finalità pratiche, era attirata dall’artefatto, ossia dall’’oggetto’ per antonomasia.
L’uomo moderno, che trova superflua la metafisica, ha posto direttamente la Tecnica a principio e fondamento della realtà. Oggi è il progresso tecnologico in sé, a prescindere dalla sua utilità per l’uomo, a produrre una metafisica e, in modo analogo, a definire gli oggetti dell’etica, a imporre una morale retta non dalla nostra relazione con Dio o con l’uomo, ma con le macchine e la loro indubitabile bontà.
Anche le eterne questioni metafisiche vengono così ridotte a fatti oggettivi, pure nozioni, problemi cui non dovremo più cercare faticosamente una risposta in noi perché la troveremo in un’intelligenza artificiale che saprà tutto sull’anima e la verità, il bene e il male ecc.. Perfetta religione “per spiriti mediocri e tardivi”, coerente evoluzione di un pensiero dominato da credenze oggettive. La nuova fede algoritmica non farà che liberarci dalla dipendenza al magistero d’una Chiesa per legarci a quello di circuiti elettronici.
Finiremo con l’avere un’oggettività senza soggetto, un mondo che si esaurisce nel ‘fuori’, senza alcun ‘dentro’. Neuroni al posto della coscienza, ormoni al posto dell’amore ecc.. Non si tratta di opporre a questa assoluta oggettività una soggettività tutta racchiusa nella mente, di sostituire l’ossessione per gli oggetti con la fissazione sull’io. Un’anima senza mondo è infatti tanto inconcepibile quanto un mondo senz’anima. Il problema nasce quando incliniamo totalmente verso un mondo di cose, fatti, dati, valori e saperi obiettivi, perdendo di vista il loro invisibile soggetto.
Per ristabilire l’equilibrio occorre resistere all’assenso automatico e abitudinario che diamo a un sistema di credenze e opinioni, vedere che ogni nostro discorso dà per scontate innumerevoli cose di cui potremmo dubitare. Proviamo dunque a mettere in crisi le nostre parole, le nostre idee, le nostre intoccabili autorità. Non si può esser religiosi senza “uccidere il Buddha”, Dio e ogni altro idolo della nostra oggettività. Ci serve l’audacia del dubbio cartesiano per sottoporre a esame critico le convinzioni in cui ci adagiamo, ripartire dall’atto del pensare e del dubitare come certezza dell’essere. Questa ricerca di un senso ultimo non può però coincidere con i limiti di una coscienza immanente ma tende a una trascendenza che la illumina.
Dobbiamo mettere tra parentesi gli insegnamenti, i maestri, le rigide nomenclature che altri hanno stabilito, se vogliamo cercare una verità che può essere colta solo soggettivamente. In questo non ci assiste l’istinto sociale, che volentieri si piega all’autorità. E neppure c’è d’aiuto il comune ‘buon senso’, che facilmente si lascia convincere dalle ragioni dell’utile e della convenienza. Le varie religioni, dal canto loro, possono porci davanti a noi stessi come a un problema, dotarci di alcuni strumenti atti ad indagarlo, ma non possono darcene la soluzione. Sarebbero sempre risposte oggettive, riguardate dall’esterno, perciò radicalmente inadeguate.
Ogni religione implica una diversa segnaletica, è indicazione di una via. Se si parla d’una loro “unità trascendente” è solo in relazione a un unico centro e non alle sue diramazioni, a un fine generale – la visione di Dio – e non ai mezzi particolari e diversi che ciascuna religione ci offre. Questa differenza è un elemento prezioso e irriducibile. Alcuni vorrebbero operare sincretismi religiosi, come a cavarne un artificiale esperanto dell’anima. Ma ogni religione ha un particolare linguaggio, un suo retaggio di sapienza, un ruolo preciso nella storia.
Si possono trovare affinità tra i vari misticismi, tra Meister Eckhart e il Vedanta, sufismo e taoismo ecc., ma un’omologazione della fede non farebbe che indebolire quel carattere irriducibilmente individuale, idiosincratico, con cui lo Spirito si esprime. Carlo V diceva di usare lo spagnolo per parlare con Dio e il tedesco col suo cavallo, ma non esiste una lingua migliore delle altre e neppure una religione. Questo potrà suonare offensivo ai bigotti e ai fanatici, a quelli che non capiscono come tutte le nostre rappresentazioni e dottrine siano ugualmente incapaci di esprimere una verità assoluta. Ogni religione è confinata nello spazio di verità relative, determinata da fattori storici e culturali, contaminata da elementi mitologici e immaginari. Se v’è un linguaggio di Dio è il silenzio. “O Tu, di là da ogni cosa: come è lecito chiamarTi altrimenti?” dice Proclo.
Nondimeno, questi sforzi di concepire l’inconcepibile, di dargli un nome, non sono per il pensiero una vana occupazione ma uno stimolo a trascendersi, spingendosi oltre i limiti oggettivi della moralità e dei giudizi astratti. La stessa resistenza offerta dagli oggetti della nostra ricerca ci fa infine prender coscienza di Quello che non può essere cercato e desiderato, perché nessuna distanza lo separa da noi. E non fa differenza come lo chiamiamo: Dio, Brahman o Tathātā.
Si passa da un dubbio radicale, sospensione del giudizio sulle cose, a un giudizio semplice e sincero sulla nostra vita. Chi sono? Cosa devo fare? Perché? Giudicare viene da Jus – da cui ‘giustizia’ – e ancor prima dalla radice Yug, che indica il legare insieme. Esser religiosi è ritrovare in sé quel giudizio giusto che ricorda all’uomo la sua trascendenza e l’unisce a Dio. La religione può vivere senz’etica e filosofia, ma muore senza una mistica sperimentale, senza quell’energia che spinge l’uomo al fondo di sé stesso. Pazientemente ci si spoglia delle proprie illusioni. È una via che non aggiunge nulla a ciò che siamo ma anzi conduce verso la pienezza del nulla.
Questa pienezza è appunto la visione di Dio. Perché gli oggetti dei sensi o dei pensieri, materiali o immateriali, esistono come qualcosa fuori di noi. Ma Dio – il Tao, il Brahman – non è un oggetto, non esiste in nessun luogo. Non lo si può vedere come si vede un albero o una nuvola. Non lo si capisce come si capisce un teorema geometrico. Né lo si ama come si ama una creatura. Finché lo scambiamo per un oggetto non possiamo vederlo, amarlo, capirlo. Perciò diciamo che è un nulla, un vuoto, una trascendenza. Queste parole non sono il dito che indica la luna, perché questo ci chiuderebbe ancora in una visione oggettiva. Sono solo tentativi di distogliere l’attenzione dagli oggetti.
Ma se non usciamo dal pensiero oggettivo faremo anche del nulla, del vuoto un’altra cosa, e ci metteremo a cercarlo. Oppure vedremo in questo pieno-nulla un’astrazione. Eppure, come Cartesio, di tutto si può dubitare tranne che di questo essere vuoto, che nessun oggetto può riempire. Da questa certezza germoglia un distacco dalle cose. Non si tratta di trasalimenti estatici. “Anche tra le pentole sta il Signore” diceva Teresa d’Avila. Tutto il mio zen, diceva un vecchio monaco buddhista, è mangiare riso e restituirlo al cesso. Basta sentire il respiro segreto della vita, quel quid inattingibile che non è oggetto di studio ma un mistero sfuggente. Non serve cercarlo, perché «Io mi son fatto trovare anche da quelli che non mi cercavano, mi sono rivelato anche a coloro che non chiedevano di me».
Infine, la vera religione presuppone un’incrollabile fede in sé. Questa fiducia è la base della libertà. La società moderna vuole invece renderci sempre più dipendenti dall’informazione, dalle macchine, da ordini economici, dalle opinioni degli ‘esperti’, alienandoci da noi stessi. Non so quindi se il progresso decreterà la fine dell’uomo religioso. Dipende. V’è una religione dell’essere e una dell’avere, la prima legata al Soggetto, la seconda al possesso di cose. Una aspira alla grazia, l’altra pretende di farsi Potere e verità oggettiva. Viviamo così, pericolosamente in bilico, tra la purezza dell’inutile e le soteriologie tecno-scientifiche, tra l’attesa di Dio e i culti satanici. In questa alternativa, io credo, si determinerà anche un domani l’utilità o il danno della religione.




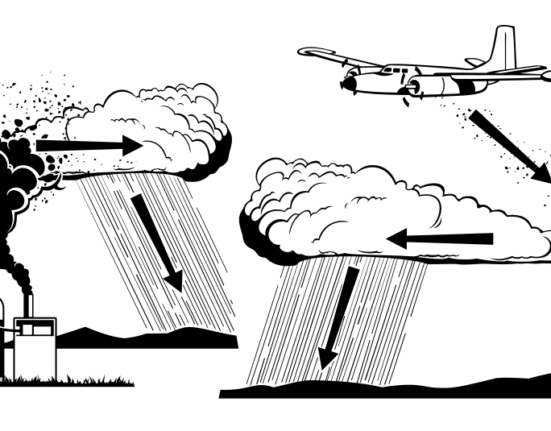



7 Comments