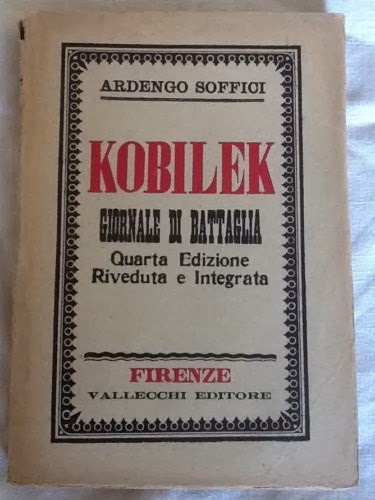contro una realtà di guerra tra mercanti.
la sociologia americana ha individuato come la “mama’s baby sindrome”.
Privacy Policy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, pubblicare annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Facendo clic su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.
The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ...
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.
No cookies to display.
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.
No cookies to display.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
No cookies to display.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
No cookies to display.
Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.
No cookies to display.
…. EreticaMente è una comunità filosofica non interessata alla politica, alle logiche partitiche, che interagisce liberamente con studiosi di diversa formazione e di differente pensiero, nel rispetto della visione del mondo di ognuno.