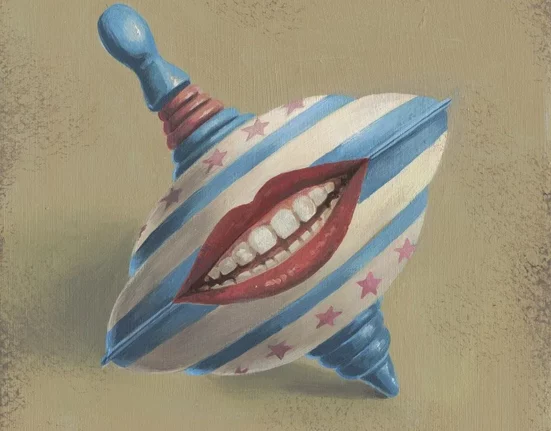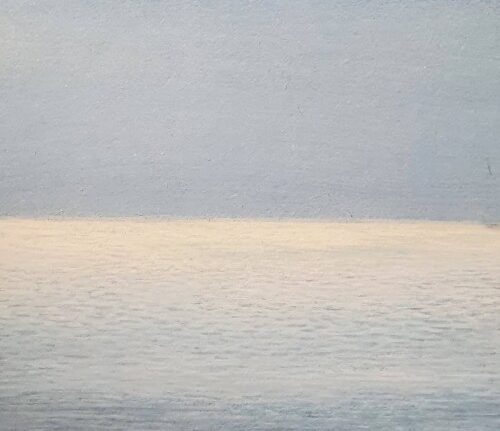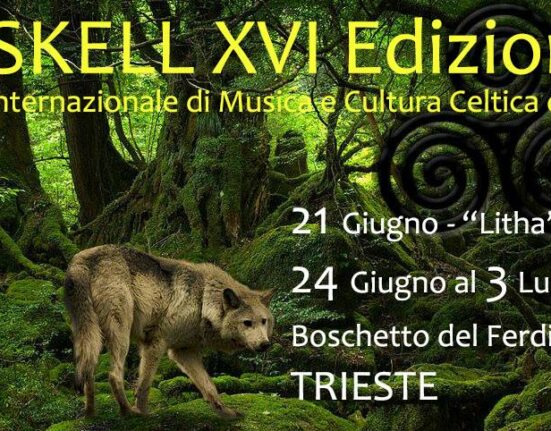Torino è una delle città più affascinanti d’Europa, molta cara al mondo esoterico, in quanto ritenuta al vertice di ben due triangoli magici, quello della magia bianca, con Lyon e Praga, e quello della magia nera, con Londra e San Francisco. Attualmente il comune di Torino conta circa 900.000 abitanti, anche se la sua area metropolitana contiene circa 2.000.000 di abitanti. Si tratta del quarto comune italiano per popolazione ed uno dei maggiori complessi produttivi, industriali e culturali del nostro Paese. La città di Torino ha una storia bimillenaria, anche se si hanno poche notizie certe in merito alle sue origini, dove a partire dal III sec. a.C. sorgevano alcuni villaggi abitati da una popolazione celto-ligure nota con il nome di Taurini. Gli studiosi raccomandano di non fare confusione nell’identificare la predetta popolazione con quella dei Taurisci che, invece, abitavano nelle vicine valli di Susa e di Lanzo. Nell’area dove sarebbe fiorita la città di Torino, secondo alcune fonti storiche, un villaggio un pò più esteso, denominato Taurasia o Taurinia, sarebbe stato raso al suolo nel 218 a.C. dall’esercito cartaginese di Annibale, durante la sua marcia verso Roma, dopo aver attraversato le Alpi.  Su quello che rimaneva dell’antico villaggio distrutto, Giulio Cesare fece edificare un presidio militare nel 58 a.C., con il nome di Iulia Taurinorum. Successivamente questo presidio diventò un castrum durante le guerre galliche, fino ad assumere la dignità di colonia romana nel 28 a.C. con il nome di Iulia Augusta Taurinorum, o in maniera sincopata, Augusta Taurinorum (1).
Su quello che rimaneva dell’antico villaggio distrutto, Giulio Cesare fece edificare un presidio militare nel 58 a.C., con il nome di Iulia Taurinorum. Successivamente questo presidio diventò un castrum durante le guerre galliche, fino ad assumere la dignità di colonia romana nel 28 a.C. con il nome di Iulia Augusta Taurinorum, o in maniera sincopata, Augusta Taurinorum (1).
Nel travagliato periodo successivo alla caduta dell’impero romano d’occidente, Torino fu occupata dai Longobardi e diventò capitale di un loro ducato, per passare poi sotto il dominio dei Franchi di Carlo Magno. La svolta si ebbe nel 940 quando si formò la Marca di Torino controllata dalla cosiddetta “dinastia arduinica” (2) che, mediante unioni matrimoniali tra esponenti della nobiltà, fece sì che la città rientrasse sotto l’influenza sabauda. Dopo essersi costituita come libero Comune, la città diventò parte dal 1280 prima della Contea di Savoia e poi del nuovo Ducato di Savoia. Torino iniziò ad assumere la fisionomia attuale nella seconda metà del sedicesimo secolo, quando, a seguito della pace di Cateau-Cambresis (1559), il duca Emanuele Filiberto di Savoia la elesse a capitale del ducato al posto di Chambery. In quel periodo furono costruite mura moderne ed una cittadella pentagonale, la cui forma, soprattutto alla luce delle considerazioni che faremo in seguito, non sembra casuale. Nel XVII secolo Torino visse un ulteriore periodo di espansione, uscendo dal perimetro originario delle mura romane ed estendendo la sua influenza sulla zona di Asti e sul Monferrato, nonché acquisendo uno sbocco sul mare che contribuì a rendere più “europea” la dimensione del Ducato. Nel XVIII secolo la popolazione ebbe un incremento di circa il 50%, con qualche pausa di arresto solo in concomitanza dell’occupazione francese e delle guerre napoleoniche (3). Già nel 1713 i duchi di Savoia acquisirono il titolo di re, prima di Sicilia per soli sette anni, poi di Sardegna fino all’unificazione d’Italia avvenuta nel 1861. Dalla fine del XIX secolo, Torino ha sviluppato la propria vocazione industriale, con la fondazione della FIAT, della LANCIA e di altri importanti poli produttivi. Dopo il secondo dopoguerra, il capoluogo piemontese, insieme a Milano, ha rappresentato il simbolo della crescita economica italiana, attirando numerosi emigranti dal Meridione e dal Veneto, a causa della grande richiesta di manodopera degli stabilimenti automobilistici. Non mi esprimo sulle questioni afferenti all’unificazione dello stato italiano, costruita a tavolino dalle potenze europee, né sui torti subìti dai territori meridionali della penisola, in quanto esulerebbero dalla presente trattazione.
Come detto in apertura, Torino è considerata una delle città più esoteriche e misteriose al mondo. Secondo alcune credenze, il capoluogo piemontese, allineato al 45° parallelo, sarebbe sospeso tra le forze del bene e quelle del male: il suo “cuore bianco” corrisponderebbe alla fontana dei Tritoni, situata dietro Piazza Castello. In Piazza Solferino ritroveremmo la “porta dell’infinito”, formata seguendo precise regole di origine massonica, in quanto composta da quattro gruppi di statue appoggiate a basi di granito, con ai due lati due gruppi femminili da identificare nella stagione primaverile ed in quella estiva, mentre al centro, in posizione rialzata, due figure maschili intente a versare acqua da un otre, simboleggianti l’autunno e l’inverno. L’anima nera della città di Torino, invece, avrebbe il proprio epicentro in Piazza Statuto, con la sua fontana del Frejus. Un’antica leggenda narra che qui sia nascosta la porta dell’inferno e che l’angelo che sovrasta l’obelisco, collocato nella piazza, sia Lucifero in persona. Colpisce, inoltre, la presenza della stella pitagorica a cinque punte posta sul capo dell’angelo, inteso nel suo significato originario di “portatore di luce”, quindi simbolo di evoluzione, conoscenza e di trasmissione all’umanità della sapienza. Nella stessa piazza si trova l’obelisco geodetico, denominato anche “guglia Beccaria” (4), al cui vertice è posto un astrolabio che, secondo gli esperti di magia, starebbe ad indicare il cuore delle potenze oscure della città. A ciò si aggiunge il fatto che, nei pressi di piazza Statuto, si può ammirare la Domus Marozzo (5) dove, secondo la tradizione, avrebbe soggiornato Nostradamus per curare la sterilità di Margherita Valois, moglie di Emanuele Filiberto. La permanenza di Nostradamus a Torino, comunque, non è considerata certa. Ciò non rende meno affascinante la lapide iscritta all’ingresso della casa: Nostradamus ha alloggiato qui, dove c’è il Paradiso, l’Inferno e il Purgatorio. Io mi chiamo la Vittoria, chi mi onora avrà la gloria, chi mi disprezza avrà la rovina intera”. Si tratta di una frase criptica e misteriosa che forse fa riferimento ai presunti poteri del potente mago d’oltralpe o di qualche altro personaggio che voleva ispirarsi alla sua fama.
Uno dei luoghi che ha maggiormente solleticato la fantasia degli appassionati, è sicuramente il Palazzo Trucchi di Levaldigi, al cui ingresso è collocato uno stravagante portone, noto come il “Portone del diavolo”. Attualmente l’edificio ospita la Banca Nazionale del Lavoro ed, in maniera analoga al portone, è denominato il “Palazzo del diavolo”. Il portone fu scolpito nel 1675 da un artista francese su commissione di Giovanni Battista Trucchi di Levaldigi (6), nobile e generale delle finanze di Carlo Emanuele II. Il portone si presenta in maniera molto suggestiva: sono raffigurati fiori, frutta, animali ed amorini. La caratteristica, tuttavia, che gli ha fatto guadagnare il titolo demoniaco è il batacchio centrale raffigurante il diavolo che osserva i visitatori che bussano alla porta, nonché la parte finale del batacchio formata da due serpenti le cui teste si uniscono in cima. La leggenda racconta che il portone sia comparso dal nulla in una sola notte, quando un apprendista stregone avrebbe invocato le forze oscure ed il diavolo in persona. Satana, infastidito dall’invocazione, come punizione avrebbe imprigionato lo sventurato dietro il portone, condannandolo ad una segregazione perpetua.
Quando abbiamo passato in rassegna la breve panoramica storica sulle origini di Torino, si è fatto riferimento alla storiografia tradizionale. In realtà, in merito alla sua fondazione, vi sono affascinanti leggende che rendono la sua nascita avvolta dall’enigma e dal mistero, aspetto comune a molte metropoli europee. Una delle ipotesi più suggestive, che per la verità non ha mai trovato alcun riscontro oggettivo, è che Torino fosse stata fondata dagli antichi Egizi e, per l’esattezza, su iniziativa di Fetonte, figlio della dea Iside.  Il figlio della più celebrata divinità egizia avrebbe scelto l’incrocio tra i fiumi Dora e Po’ per omaggiare il dio Api, raffigurato di frequente nelle sembianze di un toro. L’animale, venerato dagli antichi Egizi, sarebbe alla base della denominazione della città sabauda. Non sarebbe una coincidenza, pertanto, il legame di Torino con l’importantissima civiltà mediterranea, culminato nella presenza del più grande Museo di antichità egizie dopo quello del Cairo (7). Tra gli edifici religiosi, un luogo veramente singolare è la Chiesa della Gran Madre di Dio (8), fatta costruire per ordine di Vittorio Emanuele I di Savoia. Si tratta di un tempio abbastanza differente dal solito culto cristiano a Maria, intesa come madre di Gesù, avvicinandosi, nella sua simbologia, maggiormente alla concezione pagana di Grande Madre, considerata come colei che governa i cicli di trasformazione, di rigenerazione e di rinascita. E’ significativo notare come all’esterno della Chiesa siano collocate in alto due statue: la fede e la ragione. Una curiosa tradizione vuole che lo sguardo della statua che rappresenta la Fede possa far luce su un particolare luogo dove sarebbe possibile reperire preziose e ben celate informazioni per mettersi sulle tracce del Santo Graal. Si tratta di racconti che potrebbero suscitare ilarità e sembrare ingenui, nonchè poco significativi, se non fossero confrontati con la cultura popolare che molto spesso ingloba, in maniera trasfigurata, alcuni elementi della sapienza ermetica ed esoterica. A tale proposito, si osserva che alcuni studiosi ritengono che il castello di Moncalieri sia stato una delle sedi più importanti dell’enigmatico ordine dei Templari.
Il figlio della più celebrata divinità egizia avrebbe scelto l’incrocio tra i fiumi Dora e Po’ per omaggiare il dio Api, raffigurato di frequente nelle sembianze di un toro. L’animale, venerato dagli antichi Egizi, sarebbe alla base della denominazione della città sabauda. Non sarebbe una coincidenza, pertanto, il legame di Torino con l’importantissima civiltà mediterranea, culminato nella presenza del più grande Museo di antichità egizie dopo quello del Cairo (7). Tra gli edifici religiosi, un luogo veramente singolare è la Chiesa della Gran Madre di Dio (8), fatta costruire per ordine di Vittorio Emanuele I di Savoia. Si tratta di un tempio abbastanza differente dal solito culto cristiano a Maria, intesa come madre di Gesù, avvicinandosi, nella sua simbologia, maggiormente alla concezione pagana di Grande Madre, considerata come colei che governa i cicli di trasformazione, di rigenerazione e di rinascita. E’ significativo notare come all’esterno della Chiesa siano collocate in alto due statue: la fede e la ragione. Una curiosa tradizione vuole che lo sguardo della statua che rappresenta la Fede possa far luce su un particolare luogo dove sarebbe possibile reperire preziose e ben celate informazioni per mettersi sulle tracce del Santo Graal. Si tratta di racconti che potrebbero suscitare ilarità e sembrare ingenui, nonchè poco significativi, se non fossero confrontati con la cultura popolare che molto spesso ingloba, in maniera trasfigurata, alcuni elementi della sapienza ermetica ed esoterica. A tale proposito, si osserva che alcuni studiosi ritengono che il castello di Moncalieri sia stato una delle sedi più importanti dell’enigmatico ordine dei Templari.
In relazione ad Iside ed alla Grande Madre, è necessario notare che Torino ed il Piemonte in generale, racchiudono nel loro territorio un numero considerevole di “sacri monti”, inseriti nell’elenco UNESCO nell’ambito del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Come è noto, il Cristianesimo ha elaborato molteplici elementi delle religioni preesistenti, adattandoli alla propria dottrina. La Vergine Maria, con ogni ragionevole probabilità, trae origine dai culti della Grande Madre e dalla dea Iside. Tra i santuari montani più suggestivi menziono quello di Oropa (9), dove il culto della Madonna Nera affonda radici in un lontano passato. Nostra Signora di Oropa, come viene comunemente chiamata, è una delle Madonne nere più venerate in Italia, situata a poco più di dieci chilometri da Biella, a circa 1160 metri di altezza, in uno splendido anfiteatro naturale costituito da montagne che formano le Prealpi biellesi. Come in tante altre grandi città, anche il sottosuolo di Torino presenterebbe intricati misteri, così come sottolineato da Giuditta Dembech nel libro Torino città magica (10). Secondo l’autrice, nel sottosuolo torinese esisterebbero tre grotte alchemiche, forse posizionate nell’area corrispondente a Piazza Castello ed ai Giardini Reali. Secondo la tradizione, in questi antri, durante l’epoca medioevale, alcuni alchimisti praticavano esperimenti per intervenire sulla materia, sul tempo e sulla concatenazione degli eventi. Le grotte avrebbero costituito una solida base operativa per poter compiere prodigi di trasmutazione della vile materia e per poter elevare la propria anima verso gli stadi più alti della conoscenza e della spiritualità.
Torino, come città profondamente esoterica, presenta un indubbio contrasto anche dal punto di vista religioso: da un lato è la sede della Sacra Sindone, dall’altro è considerata come un luogo dove da secoli si invoca Satana e gli altri spiriti del male. Come vedremo, l’origine di questa fama deriva da motivazioni soprattutto di carattere politico e sociale, più che legate esclusivamente al mondo dell’occulto. Ma proviamo a dare una velocissima descrizione del mistero della sacra Sindone, con la consapevolezza di non poter assolutamente fornire un quadro esaustivo delle problematiche interpretative riguardanti la tanto discussa reliquia. La Sindone, come è noto, è un lenzuolo di lino conservato nel Duomo di Torino, sul quale si nota l’evidente immagine di un uomo con segni considerati compatibili con quelli descritti nella passione di Gesù Cristo. Il culto cattolico, anzi, ritiene che si tratti del lenzuolo usato per avvolgere il corpo di Gesù deposto nel sepolcro. Nel 1988, l’esame del carbonio  14 sulla Sindone, eseguito in contemporanea in tre diversi laboratori situati in località distanti fra loro, ha collocato il prezioso lenzuolo in un periodo intercorrente tra la metà del tredicesimo secolo e la fine del quattordicesimo, in un’epoca, quindi, di gran lunga successiva alla vita di Gesù Cristo (11). Nel XV secolo e nel XVI secolo, la Chiesa espresse molti dubbi sulla sua autenticità e, pur permettendone l’ostensione, metteva in guardia i fedeli sul suo certo collegamento con Gesù. Dal XX secolo, il Magistero ecclesiastico non si è espresso ufficialmente, lasciando alla scienza il compito di verificarne i dati compatibili con la passione di Gesù, pur autorizzandone la venerazione come “icona” di tale evento. E’ necessario ricordare, tuttavia, che alcuni pontefici moderni, come papa Pio XI e papa Giovanni Paolo II ne hanno sempre fermamente sostenuto l’autenticità, pur non dando spiegazioni logiche in merito. I fautori dell’autenticità della Sacra Sindone hanno rimarcato la presenza di presunti segni della crocifissione, della flagellazione e della corona di spine sull’immagine del personaggio raffigurato, individuando perfino l’impronta di due piccoli oggetti tondeggianti sugli occhi, considerati come monete coniate da Ponzio Pilato tra il 29 ed il 32 d.C..
14 sulla Sindone, eseguito in contemporanea in tre diversi laboratori situati in località distanti fra loro, ha collocato il prezioso lenzuolo in un periodo intercorrente tra la metà del tredicesimo secolo e la fine del quattordicesimo, in un’epoca, quindi, di gran lunga successiva alla vita di Gesù Cristo (11). Nel XV secolo e nel XVI secolo, la Chiesa espresse molti dubbi sulla sua autenticità e, pur permettendone l’ostensione, metteva in guardia i fedeli sul suo certo collegamento con Gesù. Dal XX secolo, il Magistero ecclesiastico non si è espresso ufficialmente, lasciando alla scienza il compito di verificarne i dati compatibili con la passione di Gesù, pur autorizzandone la venerazione come “icona” di tale evento. E’ necessario ricordare, tuttavia, che alcuni pontefici moderni, come papa Pio XI e papa Giovanni Paolo II ne hanno sempre fermamente sostenuto l’autenticità, pur non dando spiegazioni logiche in merito. I fautori dell’autenticità della Sacra Sindone hanno rimarcato la presenza di presunti segni della crocifissione, della flagellazione e della corona di spine sull’immagine del personaggio raffigurato, individuando perfino l’impronta di due piccoli oggetti tondeggianti sugli occhi, considerati come monete coniate da Ponzio Pilato tra il 29 ed il 32 d.C..
Le prime notize certe riguardanti la reliquia risalgono al 1353, in un periodo rientrante nella ricostruzione avvenuta mediante il carbonio 14 del 1988. Dopo varie vicissitudini e dispute sul possesso della Sindone, Margherita di Charny la vendette nel 1453 ai duchi di Savoia che la conservarono prima a Chambery, poi a Torino, a Vercelli, a Nizza e poi di nuovo nella sede iniziale (12). Nel 1578 la Sindone fu portata definitivamente a Torino, con due eccezioni: nel 1706 fu nascosta brevemente a Genova, quando la città piemontese fu assediata dai Francesi e dal 1939 al 1946, durante la seconda guerra mondiale, fu conservata presso il santuario di Montevergine in Campania. Come si diceva in precedenza, non è la sede adatta per parlare di tutti gli esami compiuti sul celebre lenzuolo di lino: quelli ematici, immunologici, sul tessuto etc., anche se, negli ultimi anni, l’attendibilità della prova ricavata col carbonio 14 è stata messa in discussione, perfino da una parte della comunità scientifica. Permane enigmatico, comunque, il mistero della fissazione dell’immagine, non dipinta, perchè prodotta da una leggera “bruciatura” superficiale delle fibre di lino ed avente un aspetto quasi tridimensionale. Su questo elemento gli studiosi non hanno saputo dare una spiegazione scientifica adeguata, perchè sembrerebbe che quel lenzuolo abbia avvolto il corpo di un uomo morto, per non più di 36-40 ore, mancando i segni di putrefazione e che ne sarebbe uscito senza alcun movimento fisico. Pur non entrando nella specificità dei racconti sulla resurrezione riportati nei Vangeli, ci troveremmo di fronte a proprietà stravaganti dall’indubbio sapore soprannaturale.
In contrapposizione al culto della Sacra Sindone, a Torino è attribuita, da molto tempo, la fama di “città satanica”, come vedremo brevemente, per motivi che non riguardano soltanto la sfera soprannaturale od occulta. Nell’epoca risorgimentale, sopratttuto nei decenni immediatamente antecedenti all’unificazione italiana (1861) e alla Breccia di Porta di Pia (1870), il governo piemontese era molto tollerante nei confronti di tutte le forme religiose non cattoliche ed anticattoliche. Ciò era ovviamente strumentale in funzione di politica contro lo Stato Pontificio. In questo contesto culturale, Torino diventa una delle città in Europa con il più elevato numero di movimenti magici, spiritisti ed occultisti in generale. Dopo l’annessione di Roma, tuttavia, nell’ottica dell’unificazione sociale del nascente stato italiano, le ragioni della tolleranza religiosa si affievoliscono e la magistratura torinese si impegna nell’arginare fenomeni dilaganti di pratiche occulte. Tra questi, nel 1890, spicca il famoso “processo delle sonnambule” che, in realtà, formavano un gruppo di donne con problemi psichici manipolate da soggetti senza scrupoli (13). Nel secondo dopoguerra, Torino diventa una delle città simbolo della contestazione operaia e studentesca culminata nel 1968, con la presenza ancora di forti movimenti anticlericali e di una frangia della massoneria non ufficiale, interessata per lo più alle pratiche magiche ed all’attività sessuale. Nel decennio, tra il 1960 ed il 1970, sembra che alcuni movimenti occultisti siano entrati in contatto con la Chiesa di Satana californiana e da qui ne sarebbe derivata la Chiesa di Satana di Torino (14). Su iniziativa del romanziere Claude Seignolle (15), autore di diversi libri sulle tradizioni popolari concernenti le gesta del diavolo, in maniera quasi goliardica, nel 1969 sarebbe sorta a Torino “una seconda chiesa di Satana”, anche se non si hanno evidenti tracce di proselitismo sistematico, ma solo di nuove adesioni originate da amicizie personali. Non si hanno notizie, peraltro, di strutture associative o di divulgazioni pubbliche del proprio credo, per la verità non ben identificato, anche se si moltiplicano le segnalazioni di rituali denominati “messe nere” partecipati dagli adepti, come parodia della celebrazione eucaristica cristiana. Negli ultimi anni, tuttavia, alcune indagini delle forze dell’ordine hanno rivelato che nella città della Mole effettivamente vi è una certa abbondanza di sette e di gruppi che si ispirano a sedicenti credenze demoniache, molto spesso per mascherare alcuni crimini ed in primo luogo per praticare la promiscuità sessuale. Non è la sede per distinguere le varie forme di satanismo che, al di là di quanto si possa comunemente pensare, abbracciano i più disparati ambiti razionalisti e spirituali, mentre solo alcune frange si limitano all’estremizzazione “acida” e quasi farsesca dei sacrifici e delle cosiddette “messe nere”.
Se si parla del capoluogo piemontese, ovviamente, non si può omettere qualche cenno alla “Mole Antonelliana”, diventata il simbolo di Torino e raffigurata in tutti i principali sfondi panoramici della città. Il nome “Mole” le fu attribuito perchè, in passato, era stata la costruzione in muratura più alta del mondo, mentre l’aggettivo deriva dall’architetto che l’aveva progettata, Alessandro Antonelli. Ripercorrere tutte le fasi di costruzione del celebre edificio richiederebbe una trattazione a sé stante, per cui mi limito a dire che la sua altezza è passata dai 47 metri del 1863 ai 167,5 metri raggiunti nel 1953 ed attualmente persistenti. Nel corso degli anni, la “Mole” è stata costruita con continue sovrapposizioni: prima il “Tempietto”, poi la “Lanterna” ed infine il completamento della guglia con il genio alato (simbolo di casa Savoia), o angelo, a seconda dell’interpretazione cattolica od ermetica, caduto poi nel 1904, con successiva apposizione della “stella a 5 punte”, anche questo famoso simbolo esoterico, dalla lettura estremamente variegata, a seconda del contesto culturale. La statua del genio caduto, tuttavia, rimasta per prodigio in bilico sul terrazzino sottostante,  è tuttora conservata all’interno della Mole. Nel 1953, a causa di un violentissimo nubifragio, si spezzò la guglia che cadde nel giardino sottostante, sede della RAI. La ricostruzione della guglia durò fino al 1969, ma fu inaugurata il 31 gennaio 1961, nell’ambito dei festeggiamenti del centenario dell’Unità d’Italia, sulla cui cima fu collocata una nuova stella, quella che si può ammirare tuttora, non più a cinque punte, ma a forma tridimensionale con ben 12 punte. Oggi la Mole ospita il Museo nazionale del Cinema (16), presentando ambienti suggestivi ricchi di preziosi reperti, come macchine ottiche pre-cinematografiche, lanterne magiche ed i più svariati pezzi che provengono da set cinematografici nostrani e stranieri. Una delle caratteristiche più evidenti di Torino è la grande diffusione di portici monumentali che attraversano circa 18 km della città, tra cui alcuni interconnessi. I primi portici furono costruiti nel Medioevo, ma lo sviluppo maggiore si ebbe a partire dal XVII secolo. La città sabauda si impone per il suo fascino sobrio ed elegante, esprimendosi soprattutto nello sfarzo contenuto delle sue residenze nobili, come lo stesso Palazzo Reale, Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Villa della Regina ed il pittoresco Castello del Valentino (17).
è tuttora conservata all’interno della Mole. Nel 1953, a causa di un violentissimo nubifragio, si spezzò la guglia che cadde nel giardino sottostante, sede della RAI. La ricostruzione della guglia durò fino al 1969, ma fu inaugurata il 31 gennaio 1961, nell’ambito dei festeggiamenti del centenario dell’Unità d’Italia, sulla cui cima fu collocata una nuova stella, quella che si può ammirare tuttora, non più a cinque punte, ma a forma tridimensionale con ben 12 punte. Oggi la Mole ospita il Museo nazionale del Cinema (16), presentando ambienti suggestivi ricchi di preziosi reperti, come macchine ottiche pre-cinematografiche, lanterne magiche ed i più svariati pezzi che provengono da set cinematografici nostrani e stranieri. Una delle caratteristiche più evidenti di Torino è la grande diffusione di portici monumentali che attraversano circa 18 km della città, tra cui alcuni interconnessi. I primi portici furono costruiti nel Medioevo, ma lo sviluppo maggiore si ebbe a partire dal XVII secolo. La città sabauda si impone per il suo fascino sobrio ed elegante, esprimendosi soprattutto nello sfarzo contenuto delle sue residenze nobili, come lo stesso Palazzo Reale, Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Villa della Regina ed il pittoresco Castello del Valentino (17).
E mi piace concludere la breve rassegna, proprio ricordando un pomeriggio di primavera nel parco del Valentino. Come è noto, si tratta del più importante parco del capoluogo piemontese, la cui origine del nome è incerta, anche se alcune fonti parlano della presenza di una Cappella intitolata a San Valentino intorno al III sec. d.C. (18). Attraversando il Borgo, cuore del parco, quasi dimenticavo di trovarmi in una metropoli industriale, in quanto la rocca visitabile evocava stili e costumi del lontano Medioevo. Quando raggiunsi la fontana dei dodici mesi, imponente monumento con una grande vasca rococò, circondata da dodici statue, raffiguranti i mesi dell’anno, un’insolita sensazione di benessere mi pervase, forse complice la compagnia benevola, appagante e rassicurante che seguiva i miei passi. Una scena divertente e simbolica si impose al mio campo visivo: intorno alle statue dei mesi un audace scoiattolo sfidava un indomito cane ad inseguirlo, nascondendosi e riapparendo ad arte per continuare il gioco. Lo scoiattolo scorazzava intorno alle statue dei dodici mesi con invidiabile disinvoltura ed allora pensai che solo un inguaribile ottimismo può prendersi gioco del passare del tempo….
Note:
(1) Cfr. G. Sergi, Storia di Torino, Vol.1,Edizione Einaudi, Torino 1997;
(2) La dinastia prende il nome da un nobile franco di nome Arduino. Gli arduinici si imparentarono con la dinastia salica tramite il matrimonio di un’esponente in linea femminile della famiglia, Berta di Savoia, con Enrico IV di Franconia;
(3) Cfr. G. Oliva, Storia di Torino, Editore Biblioteca dell’immagine, Pordenone 2014;
(4) Viene denominata anche “guglia Beccaria” dal nome del professore di fisica Giovan Battista Beccariache aveva realizzato la struttura in pietra per misurare il meridiano geografico passante per Torino;
(5) Si tratta della dimora che i Conti Morozzo dedicavano agli ospiti illustri;
(6) Il famigerato “Palazzo del diavolo” sorge precisamente tra le attuali Via Alfieri e Via XX Settembre;
(7) Il Museo Egizio di Torino è il più antico, a livello mondiale, dedicato per intero alla civiltà egizia e nel 2017 è stato classificato come il Museo più apprezzato in Italia;
(8) La Chiesa ha la forma del Tempio e rappresentò la rinascita dello stato sabaudo dopo la sconfitta di Napoleone, tanto da portare sul timpano l’epigrafe latina: ordo populusque taurinus ob adventum regis (la nobiltà ed il popolo di Torino per il re). L’iscrzione fa riferimento al ritorno di Vittorio Emanuele I;
(9) Nel 2020, precisamente il 30 agosto, si ripeterà il rito dell’incoronazione della Madonna di Oropa che dal 1620 si ripete ogni 100 anni;
(10) Cfr. Giuditta Dembech, Torino città magica Vol. 1, Ed. L’Ariete, Torino 1995;
(11) Cfr. Luigi Fossati, La sacra Sindone, Ed. Elle Di Ci, Torino 2000;
(12) Cfr. Barbara Mirò, Storia della santa Sindone, Ed. Ugo Mursia, Milano 2010;
(13) Il cosiddetto processo delle sonnambule iniziò nel 1886, qunado due clienti dell’ipnotizzatore Donato lo denunciarono per truffa. Si trattò di un caso di cronaca che fece molto scalpore;
(14) La Chiesa di Satana non deve essere confusa con il Tempio di Satana, altra congregazione occultista nata nel capoluogo piemontese nel marzo 2013;
(15) Claude Seignolle (1917-2018) scrisse alcuni suoi testi con lo pseudonimo di “Sarcante”, “San Claude” e “Jean Robert Dumoulin”;
(16) Il Museo nazionale del Cinema di Torino è considerato tra i più forniti al
mondo, sia per il notevole numero dei reperti, sia per la ricchezza dell’attività divulgativa e scientifica;
(17) Dal 1997 il Castello del Valentino è inserito nel patrimonio dell’umanità UNESCO, come elemento del sito complessivo “Residenze sabaude”;
(18) Sembra che la cappella contenesse anche alcune reliquie del santo, protettore degli innamorati, portate a Torino direttamente da Terni. Quando la cappella fu distrutta, le reliquie del santo furono conservate nella vicina chiesetta di San Vito.
Luigi Angelino