Ci siamo già ritrovati una volta, tra queste pagine, nella posizione di dover parlare filosoficamente dell’opera che stiamo presentandovi: Berserk[1]; specifichiamo come, il qui presente, si componga di riflessioni completamente slegate rispetto a quelle del precedente contributo ma, seppur questo, vale parimenti il preambolo precedentemente posto: parlare di Berserk filosoficamente è sempre un’ impresa ardua, tanto per la mole di informazioni in potenza d’essere riportate, tanto per quanto sia impossibile – date le eterogenee interpretazioni, essere unanimemente d’accordo. Nonostante questo, abbiamo potuto apprezzare l’enorme affetto e attenzione ricevuti per lo scorso pezzo e, proprio grazie a questi, vi presentiamo con grande felicità quella che vuole essere un’analisi maggiormente profonda dell’universo berserkiano; stavolta, aiutandoci con uno dei pensatori dai quali Miura – autore del manga, ha tratto maggiormente, Friedrich Nietzsche, sviscereremo quelli che sono i meandri più contorti, crudi ed oscuri dell’intera produzione. Come dicemmo introducendo l’opera precedentemente, Berserk si pone come una delle produzioni nipponiche maggiormente complesse, ma soprattutto contorte, nude e crude; non specificammo – al tempo, cosa fosse ciò che lo rendesse tale, lasciando che l’argomento fosse posto in secondo piano da un’argomentazione maggiormente vertente gli aspetti più teoretici ed esistenziali dell’opera. Non volendoci discostare completamente da un approccio teoretico, dobbiamo comunque ben evidenziare come Berserk sia inquietantemente sublime, tremendo, duro, poiché tocca impudicamente quelle aree dell’umanità – intesa come essenza umana – più trattenute, rigettate; leggere ed apprezzare Berserk è come leggere ed apprezzare un qualsiasi componimento baudelairiano: godi esteticamente della contorsione disdicevole di qualcosa che si dovrebbe aborrire.
Berserk, seppure possa superficialmente non essere evidente, vista la presenza di temibili creature demoniache e mostri impossibili, non possiede alcunché che non sia umano: ciò che terrorizza maggiormente è che quei demoni, quei mostri assolutamente disumani, siano in realtà rappresentazioni della umanità più illibata. Le mostruosità berserkiane – per quanto narrativamente venga solosilenziosamente riferito[2], non sono altro che manifestazioni fisiche della consunzione cui si è sottoposti quando ci si lascia invadere dai sentimenti più primitivi, dalle persistenti tensioni istintive che, freudianamente, vengono soppresse, o sublimate: non c’è niente, in Berserk, che non sia umano; anche la più bassa, terribile, incommensurabilmente sporca azione, è maledettamente umana. E’ proprio in questo contesto che va inserendosi la riflessione più spiccatamente nietzschiana presente nell’opera di Miura: Griffith – del quale abbiamo approfonditamente parlato, per poter soddisfare il suo sogno, essendo stato, a causa di avvenimenti narrativi importanti ma impossibili d’esser considerati in questa istanza, torturato e reso invalido, trascende la sua umanità cedendo in sacrificio l’intera Armata dei Falchi; in questo modo, si rende protagonista di quanto dicevamo poco sopra: lasciandosi andare completamente alla propria tensione più umanamente primitiva (forse pura – ed è questa la provocazione), scegliendo di sacrificare i propri compagni, si spoglia della propria umanità per abbracciare una dimensione fisico-spirituale del tutto nuova, talmente tanto umana da essere ripugnante. Griffith non trascende la sua umanità per guadagnarsi le spoglie di una divinità – o meglio, quella stessa divinità che diviene, è frutto del suo aver abbracciato la sua umanità nel modo più sinceramente concepibile. Di fatti, il sacrificio compiuto da Griffith, non è altro che la massima espressione ed esplicitazione del desiderio che maggiormente covava in sé – e della voglia di vivere dopo essere stato reso inabile: non è altro, quindi, che l’esplicarsi della sua umanità più sostanziale racchiusa in un desiderio. Era il suo progetto, era quanto aveva sensatamente – e heideggerianamente autenticamente, fondato il suo essere-nel-mondo.
«Il mio io è qualcosa che deve essere superato: il mio io è per me il grande disprezzo dell’uomo» (F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Del pallido Delinquente)[3]: il superamento qui nietzscheanamente inteso, viene interpretato da Griffith in modo iperumano[4]; quell’io – che in-sé racchiude il senso ontologico dell’umanità – il cui superamento necessario parte dallo spogliarsi di quelle vacuità che lo relegano nella condizione di impotenza, o di minor potenza rispetto a quella di cui potrebbe godere se si abbracciasse in-quanto-sé: gli affetti ipocriti, le catene delle passioni senza fondamenta solide, la prigione di una concezione del mondo parziale ed incompleta, fuorviante ed inconcludente. La trasvalutazione di valori tanto importante nel pensiero nietzschiano, assume qui un senso più tremendo e struggente: seppure – nietzscheanamente parlando, l’amicizia ed i legami affettivi maggiormente puri non esulino necessariamente dal concetto di oltreuomo[5], è evidente come la“filosofia del martello” inglobi in sé un grande rigore e vigore che la renda stoicamente distaccantesi dall’altro e dalla sua presenza morale[6] per come prima intesa. Inoltre, come già vedemmo precedentemente, il sogno di Griffith era quello di godere di un suo regno, di ascendere le caste sociali fino a diventare un vero e proprio reggente del mondo[7] e, trascendendo la sua umanità divenendo “umano, troppo umano”, va anche configurandosi in lui una comprensione del mondo maggiormente estesa, più coerente col mondo stesso; accorgendosi ora che il suo «[…] tempo fa l’impressione di una situazione provvisoria; le vecchie concezioni del mondo, le vecchie culture sono ancora in parte esistenti, le nuove non ancora sicure e abituali, e quindi senza compattezza e coerenza» (F. Nietzsche, Umano, troppo umano, Parole di conforto di un progresso disperato, fr. 248)[8], andrà realizzando il suo sogno ritornando in quel mondo del quale ha rinnegato i valori, instaurandone dei nuovi, che sublimino le possibilità umane.

(Griffith trasceso descritto in una delle tavole del manga (K. Miura, Berserk, Planet Manga, Modena, 2003, n. 48); in questa tavola è inoltre apprezzabile il chiaro citazionismo hegeliano)
In questo senso, Griffith, ritornando al mondo, non si farà che iniziatore di quel “grande meriggio” nietzschiano, non diverrà altri che l’incarnazione al contempo metafisica e fisica dell’übermensch: avrà «il compito di preparare l’umanità a un momento di suprema riflessione su sé stessa»[9], di portarla ad uscire «dal dominio del caso e dei sacerdoti»[10], di regolare il mondo su un nuovo sistema di concezioni e visioni quanto più umanamente fondate, anche se questo “umano”dovesse significare “terribile”. Questa spaesante e terribile ipertrofia umana, viene mostrataci immediatamente dal personaggio nello stesso momento in cui ascende la sua umanità per abbracciare l’oltre-umanità: volendo riprendersi il possesso di Casca – membro fondamentale dell’Armata dei Falchi che ha sacrificato, davanti agli occhi di Gatsu (col quale aveva nel frattempo intrattenuto una relazione), ora impotente, disperato, morente e senza più forze, la stupra con quella stessa «lussuria fetente» esorcizzata nei componimenti di Iacopone da Todi[11]. Un atto immisurabilmente spietato, quasi inumano – perché così tanto umano nel suo desiderio soddisfatto in modo canonicamente dionisiaco, cristallizza immediatamente il portamento di quell’uomo che ha annullato i valori precedenti, instaurandone dei nuovi che tengono maggiormente conto delle più recondite inclinazioni dionisiache, umane.
Questa riflessione viene consegnataci direttamente da Miura attraverso l’apprezzamento da parte di Slan – membro della Mano di Dio che ha aiutato Griffith a trascendere il suo stato umano, dell’atto indicibile del rinato: «sono commossa: amore, odio, dolore, voluttà, vita e morte… tutto questo è laggiù. E’ così che sono gli uomini… è questo il male»; questo, come a voler identificare, mediante un principio d’identità perfetto, l’uomo con il male. Il male è questo: come sono gli uomini. Chiaramente, deve essere ripensato “il male” alla luce di una nuova tavola di valori: quel male a cui Slan sta riferendosi, non è la malvagità per come è possibile intenderla in modo certamente banale e bambinesco; in realtà, quel male del quale tanto si compiace la donna, è quello rappresentato dall’istinto umano realizzatosi più primitivo e per questo più puro. Quello che freudianamente viene tenuto a freno, inibito, relegato nell’istanza psichica dell’es, viene qui rappresentato in modo dionisiaco, impudicamente nietzschiano, e maledettamente umano: non c’è niente di più umano dell’umano stesso.
Successivamente, il mondo di Berserk – con la venuta di Griffith a rivoluzionarne la logica, subirà un mutamento repentino e, quelle mostruosità iperumane presenti in quella dimensione dove l’Armata dei Falchi è stata trasportata per essere sacrificata da Griffith, invaderanno il mondo; da qui, Berserk si colorerà di sfumature sì fantasy, sì anche geo-politiche – con Griffith che tenta di creare un suo regno realizzando il suo sogno, ma, ciononostante, sarà pervasiva la sensazione opprimente di pericolo, destabilizzazione, paura. Per quanto possano essere informi, aberranti, impensabili e confusi, i “mostri” di Berserk avranno sempre un volto, qualcosa che in qualche modo li individualizzi nella loro umanità, che li renda uomini, che è quanto ontologicamente comunque sono: pur manifestandosi in modo apparentemente inumano, conservano la loro sostanzialità umana.

(K. Miura, Berserk, Planet Manga, Modena, 2001, n.40)
Lo stesso Gatsu, sopravvissuto – assieme a Casca[12], all’Eclissi[13], sarà protagonista di un complessissimo dissidio interiore che vede contrapposti il desiderio amoroso per la ragazza, e la irrefrenabile brama di vendetta contro la Mano di Dio, e soprattutto Griffith. Miura, sempre con la sua penna e matita crude e forti, ci rappresenterà questo dissidio soprattutto quando il ragazzo, cercando di lasciar stare il suo desiderio di vendetta originariamente intrapreso, torna da Casca per cercare di rimanere con lei, e proteggerla da quelle aberrazioni che ora danno loro la caccia ed hanno invaso il mondo. Infatti, quanto più sta reconditamente frenando, è quanto più lo anima nelle sue intenzioni: l’odio, la necessità incontenibile di vendetta; quando Gatsu cercherà di sublimare tutto questo, questi sentimenti persistenti si manifesteranno in modo feroce ed aggressivo, come a ricordargli che non possa rinnegare per davvero quello che in modo più profondamente umano sa di essere.
Nelle tavole di Miura, tutto questo si concretizzerà nella figura simbolica di un lupo ad un occhio: questo, simboleggerebbe l’ultima visione che l’occhio destro di Gatsu ha potuto contemplare – avendolo perso nell’Eclissi, ossia lo stupro, la violenza che ha dovuto subire lui, Casca, e tutti i suoi compagni. Questi sentimenti persistenti prenderanno – sporadicamente ma inevitabilmente, il controllo del ragazzo facendogli compiere degli atti totalmente imprevedibili, che ben sono contestuali rispetto a quelle tensioni dionisiache[14] dove ci si sentirebbe fuori-di-sé. Tutto questo – per quanto terribile e rinnegabile, ci porta a contemplare, anche se con disgusto, quanto umano possa essere l’umano, e quindi, quanto noi stessi, nella nostra individualità e singolarità, possiamo spingerci nell’abisso della nostra umanità, essendo comunque consapevoli che, nietzscheanamente, scrutando a lungo nell’abisso, finirà l’abisso per scrutare dentro di noi.
Note:
1: Puoi recuperare il contributo seguendo questo link: L’esistenzialismo kierkegaardiano ed il progettualismo heideggeriano in Berserk (with englishversion)- Simone Santamato – EreticaMente
2: Cfr. K. Miura, Berserk, Planet Manga, Modena, 2003, n.48
3: Fabbri, Milano, 1996, p.55
4: Anche in Nietzsche varrebbe canonicamente parimenti, essendo l’oltreuomo comunque uomo, per quanto superi il concetto stesso di essere-umano.
5: cfr. F. Nietzsche, Gaia Scienza, fr.279, Amicizia Stellare
6: Seppure possa anche dirsi che, rifiutando i valori dell’ipocrisia e di una mollezza morale sconsiderata, non faccia che avvicinarsi in modo maggiormente puro e convinto, per quanto superficialmente sia percepibile come allontanamento.
7: Il desiderio del personaggio – e l’influenza che narrativamente avrà – è sicuramente sovrapponibile al concetto di “individuo cosmico-storico” hegeliano: colui che muove l’intero mondo, cambiandolo, che sta-al-mondo modificandone le regole, la logica umana, l’assetto.
8: Adelphi, Milano, 2019, p.176
9: F. Nietzsche, Ecce Homo, Adelphi, Milano, 2019, p.89
10: ibidem
11: Lauda 39 – Laude, Laterza, Roma-Bari, 2006, p.111
12: E’ da specificare, inoltre, come la ragazza, per i traumi subìti nel corso del sacrificio, perderà completamente qualsiasi tipo di autosufficienza, iniziando a manifestare segni di completo squilibrio mentale.
13: E’ così che – berserkianamente, viene definito il momento in cui l’Armata dei Falchi viene sacrificata; questo poiché, il banchetto, avviene, appunto, durante un’eclissi. «Non dire più nessuna cosa al mondo/“impensabile, assurda, prodigiosa”/da quando Zeus, il Padre degli Olimpici,/ha portato la notte in pieno giorno/e ha coperto il sole più radioso./E la gente sudava di terrore.»–Archiloco, giambografogreco, VII secolo a.c., parlando della famosi eclissi del 648 a.c.
14: Tensioni tecnicamente estatiche magistralmente rappresentate – tra le altre cose, nella tragedia euripidea “Le Baccanti” (V secolo a.c.), dove una donna, Agave, in preda all’ebbrezza dionisiaca, farà letteralmente a pezzi il suo stesso figlio, Penteo.
Simone Santamato


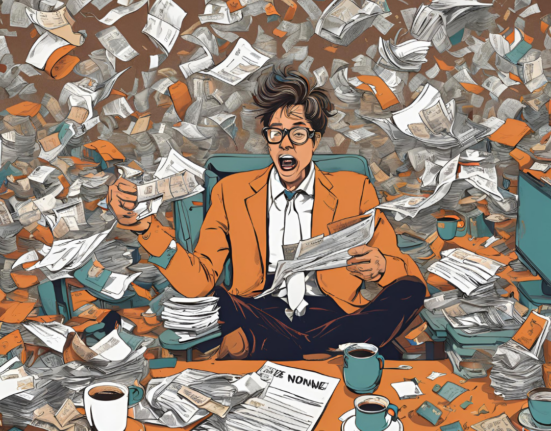



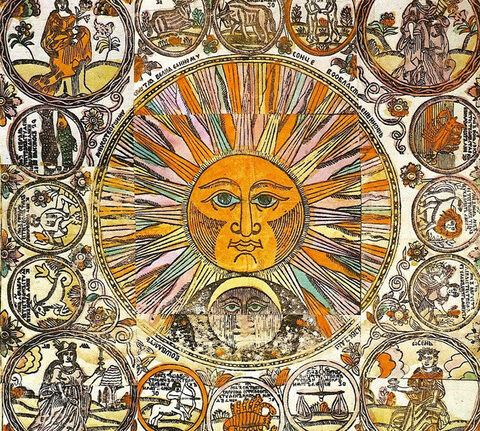

1 Comment