So per esperienza che si possono dire cose molto serie con l’aria di scherzare o, al contrario, prendere sul serio delle emerite sciocchezze. Per esempio, il mio ultimogenito. È esasperante. Quando assume un’espressione seria e concentrata è perché il suo cervellino sta girando in tondo su questioni della massima futilità. Il guaio è che mi coinvolge in pensieri o dubbi tanto insensati che è impossibile dargli una risposta. Se si limitasse al classico “come nascono i bambini?” avrei pronto un repertorio di spiegazioni logiche a base di api, pollini, fiori ecc. Invece mi fa sempre domande assurde.
Chi ha figli mi capirà. Ogni genitore spera infatti di cavare qualche soddisfazione dai figli. Io non sono un’eccezione alla regola, e vorrei qualcosa in cambio della fatica di crescerli. Invece ogni giorno una delusione. Ma la genetica è una scienza o una favola? Infatti, pur avendo io un’intelligenza non disprezzabile, mi ritrovo questo figlio che è un prodigio di insipienza. La cosa strana è che mi batte a scacchi. Ma penso sia questione di fortuna. Sta di fatto che quando i miei amici si vantano della precocità dei loro pargoletti – c’è quello che a tre anni legge Hermann Hesse, quello che a quattro conosce i logaritmi ecc. – io glisso, cercando di spostare altrove il discorso.
Non posso dire che mio figlio non sia un bel ragazzino – e in questo credo che l’ereditarietà conti qualcosa, visto che mi somiglia – ma se passo a un esame delle facoltà mentali, non so proprio da chi abbia preso, se non forse da mia moglie. Ricordo infatti che, prima di sposarmi, notavo spesso in lei l’attitudine a trarre deduzioni illogiche, a esprimersi con dei nonsensi.
Credevo allora che questa irrazionalità corrispondesse al decantato ‘intuito femminile’ e non le davo peso. Me ne sarei invece dovuto preoccupare e temere che, com’è poi successo, si trasmettesse alla prole. Ma ormai il danno è fatto ed è inutile lagnarsene. È quindi con un senso di colpa e di espiazione che ascolto i discorsi del mio ultimo rampollo, della cui esistenza suppongo d’essere per metà responsabile. Mi consola il pensiero che presto andrà a scuola, dove spero gli tolgano il vizio di ragionare con la sua testa.
Ieri, tanto per fare un esempio, ero comodamente seduto in poltrona a leggere il giornale. Arriva lui e mi chiede: “ma io quanto sarò alto da grande?”. “Mah, non lo so…un metro e ottantacinque, un metro e novanta” gli rispondo io. Di fatto, per uno di sei anni è piuttosto alto. “Ma quant’è un metro?” Ecco una delle sue tipiche domande senza senso. “Un metro è più o meno così.” e faccio un segno con la mano a circa un metro da terra “Come quello sgabello lì.” “Ma come fai a dire che è un metro?” “Prendi il metro che c’è in cucina e lo misuri, semplice.” “Ma come si fa a stabilire che un metro è proprio un metro?” “Ma che ne so? Credo ci sia da qualche parte una barra indeformabile che indica un metro esatto.” “Ma perché hanno detto che quello era un metro? Non potevano fare che un metro era così?” e fa un segno con la mano a mezzo metro da terra. “È solo una misura convenzionale, tanto per intendersi quando si parla o si fanno dei calcoli. È un modo di dividere lo spazio in parti uguali.”
È rimasto assorto per un attimo, cercando un varco tra le nebbie della sua testolina. “Ma lo spazio quant’è grande?” “Beh, non lo so di preciso…” “Ma se non sai quanto è grande come fai a dividerlo in parti uguali?” “Ragiona un attimo. Ti ho già detto che la Terra ha una circonferenza di 40.000 chilometri.” “Sì”. “Bene, sono quaranta milioni di metri. Quindi un metro è la quarantamilionesima parte della circonferenza della Terra.” “Papà, ma come fai a dire che la Terra ha la circonferenza di quaranta milioni di metri se non sai quanto è lungo un metro?”. “Ma cosa c’entra? Basta che tu prenda la misura intera e la divida in tante parti uguali.” “Ma uguali a che cosa?” “Uguali tra loro, è ovvio.” “Ma come fai a dire che sono uguali?”. Ormai la discussione stava degenerando. “Basta che le misuri.”
Qui ho capito di aver commesso un errore, come quando in una partita a scacchi porti incautamente la torre in C3 invece che in C1 e l’alfiere te la mangia. “Ma con che cosa la misuri?” Sapevo che il piccolo impertinente ci sarebbe arrivato. Dovevo trovare una mossa difensiva ma nelle mie nozioni, tipicamente umanistiche e poco scientifiche, non trovavo appigli. Alla fine mi balenò un’idea. “Ti ricordi quando ti ho spiegato che la luce viaggia a 300.000 Km. al secondo?” “Sì, papà.” “Bene, allora un metro è lo spazio che la luce percorre in una frazione piccolissima di tempo. Non so di preciso quanto, ma su qualche libro l’avranno scritto.”
Vedendo la sua espressione confusa ho pensato “scacco matto!”. “Allora” ha ripreso esitante “io potrei dire che un metro è la strada che Speedy (è la sua lumaca. Alcuni ragazzini hanno il cane o il gatto, lui ha una lumaca) fa in…4 minuti”. “Beh, non lo so. Se Speedy si muovesse sempre alla stessa velocità, si potrebbe dire anche così. Ma credo sia più preciso basarsi sulla luce”. “Speedy va sempre alla stessa velocità ma…” ha riflettuto un attimo “come faccio a sapere quant’è un minuto?” Ero certo che mostrargli le lancette dell’orologio non sarebbe servito. “Beh, prendi il sole. Lui impiega 24 ore per fare un giro completo intorno alla Terra”. “Ma non è la Terra che gira intorno al Sole?” “Ma sì, era solo un modo di dire … Allora, se oggi il Sole sta lì, domani quando è ancora lì, son passate 24 ore, cioè … 1440 minuti, quindi … se tu dividi …” mi stavo ficcando in un altro vicolo cieco. “Oppure” questa mi parve una buona mossa “quando la luce ha percorso, fammi pensare …18 milioni di chilometri, vuol dire che è passato un minuto. Hai capito adesso?”.
“Ma come si fa a sapere …” ho intuito cosa stesse obiettando, perciò l’ho subito bloccato. “Senti caro,” e in questa parola c’era più un’affettazione di sentimento che un reale affetto “non è che si può spiegare tutto. Si stabiliscono certe regole perché sono utili. E adesso vai a giocare con Speedy”. “Sta dormendo”. “E tu come lo sai?”. “Ha gli occhi chiusi”. “E tu svegliala.”
Sul momento è sembrato desistere da ulteriori domande insulse. Così ho ripreso a leggere il giornale. Ero sulla pagina politica. Le solite baruffe tra destra e sinistra. Pensavo che ‘destra’ suona meglio di ‘sinistra’. Si dice infatti ‘un rumore sinistro’, ‘un tiro mancino’. Oppure, ‘un tipo maldestro’. Pregiudizi. In ogni caso, oggi non si capisce più nulla. La sinistra sembra la destra, la destra sembra la sinistra. Ero assorto in questi pensieri quando, con un certo disappunto, vedo il mio ultimogenito che torna indietro.
“Non giochi con Speedy?” gli domando senza alzare gli occhi dal giornale. “Speedy è stanca. Ieri ha corso troppo”. “Ah …” mi è sfuggito un sospiro di sconforto. Lui si mette lì di fronte alla mia poltrona e mi osserva in silenzio. “Cos’hai?” gli chiedo ormai rassegnato. “Papà, cos’è la sinistra?” Sembrava mi avesse letto nel pensiero. Sul momento mi sono compiaciuto di quel precoce interesse per la politica. Ho riposto il giornale e ho preso a parlargli di Marx, proletariato, lotte sindacali e materialismo dialettico.
Mi ha guardato perplesso. “C’è qualcosa che non capisci?” gli chiedo. “La mamma mi ha detto che prima di giocare devo fare un lavoro per lei”. “È giusto”. “Ma come faccio a sapere quando è prima di giocare se prima non gioco?”. “Ma ti rendi conto che dici cose senza senso?”. “Scusa papà, ma come faccio a sapere che una cosa viene prima di un’altra se l’altra non so quand’è?”. “L’altra è dopo quella di prima”. “Ma quella di prima è prima di quella che viene dopo e…”. “Senti giovanotto, basta chiacchiere, prima aiuti la mamma e dopo giochi”. “Ma …”. “Niente ma. Fai come ti dico”. Non volevo farmi trascinare in altri discorsi surreali. Così ho ripreso in mano il mio giornale.
Lui è rimasto immobile. “Che c’è adesso?” “E la sinistra?”. “Ah, già. Ne parliamo dopo”. “Ma la mamma mi ha detto di prendere una spazzola in cucina, nella mensola di sinistra, e io non so dov’è la sinistra”. “Come non sai dov’è la sinistra? È questa” e ho alzato il braccio sinistro. Lui, che mi stava di fronte, ha alzato il suo braccio destro. “Questa?” mi chiede. “Ma no! Quella è la destra”. “Ma perché la tua destra è di lì e la mia di qui?”. “Perché guardiamo in direzioni opposte”. Mi sono alzato dalla poltrona e mi sono girato come lui. Ho alzato il braccio sinistro. “Questa è la sinistra” gli ho detto. “Ma prima era dall’altra parte” ribatte lui. Un caso disperato. Allora gli prendo il braccino sinistro e gli dico “Vai in cucina, guardi dalla parte di questo braccio e lì c’è la mensola di sinistra”. “Sì, papà”. È partito deciso come un soldatino con il suo braccio alzato.
Appena ripresa la mia lettura lo vedo tornare indietro. “Papà, ma in che direzione devo guardare?”. È triste avere un figlio minus habens. Comunque, gli ho fornito la precisazione richiesta. Non passa un minuto che me lo ritrovo davanti, muto, ancora in attesa di qualcosa. “Che c’è adesso?”. “Papà, ho abbassato il braccio e non mi ricordo più qual è quello giusto”. Avrei certo preferito continuare la lettura del giornale ma, conscio del mio dovere di padre, ho deciso di fargli entrare nella testa una volta per tutte la differenza fra destra e sinistra. Credo sia dovere di un buon genitore fornire ai figli un sicuro orientamento nella vita.
Così, ho preso il mio orologio e gliel’ho stretto sul polso sinistro. “Ora,” gli ho ingiunto “ogni volta che dirò ‘sinistr’ tu alzerai il braccio sinistro, cioè quello con l’orologio. Così”. Gli ho fatto fare questo semplice esercizio per un paio di minuti, finché mi è parso rispondesse all’ordine in modo automatico. “Bene,” ho detto soddisfatto “ora cammina per la stanza e quando ti dico ‘sinistr’ devi girare dalla parte dell’orologio. Così. Hai capito?”. Questo esercizio ha richiesto qualche correzione, ma l’obiettivo mi sembrava raggiunto. “Ecco, adesso sai dirmi qual è la sinistra?”. Ha alzato il braccino sinistro. Ha fatto anche un mezzo giro su se stesso in senso antiorario. “Bravo. Adesso fammi leggere il giornale”. Non sembrava convinto. “Papà, ma se io sono una palla e non ho le braccia, come faccio a sapere qual è la sinistra?”. Cominciava a innervosirmi. Mi sembravano i discorsi che fa ogni tanto sua madre.
Dovevo trovare una risposta che tappasse la bocca a quel piccolo scocciatore una volta per tutte. Riflettendoci attentamente, mi è parso di trovare un argomento inoppugnabile. “Allora, stai attento. Questa è la parete Nord della casa. Quindi, se hai davanti il Nord, la sinistra è la parte che indica l’ovest”. “Ma come faccio a sapere qual è l’ovest?”. Era chiaro il trabocchetto. Se avessi detto che, guardando a Nord, l’ovest è a sinistra, sarei caduto dritto nella sua trappola. Ma non per nulla io sono un adulto e lui è solo uno sciocco bambino. “Ascolta. Domani mattina ti alzi all’alba e guardi da che parte si alza il sole. L’ovest sta dalla parte opposta”. Ero tranquillo. Sono miliardi di anni che il sole si alza da quella parte.
Mi illudevo così di aver messo fine alla questione. “Cosa vuol dire opposta?”. Era una mossa che non avevo previsto. “Opposta vuol dire che se domattina tu guardi verso il sole, l’ovest sta dietro”. Mi ero difeso con un arrocco, ora aspettavo la mossa del mio avversario. “Ma dietro cosa vuol dire?”. Come immaginavo. “Dietro è il contrario di davanti”. Stava già per aprir bocca ma io l’ho anticipato. “Davanti è dove ci sono gli occhi, il naso, la bocca. Dietro c’è il culetto”. Ha fissato per un po’ il vuoto, come se vi cercasse un appiglio. Ero sicuro di aver vinto. “Ma se io sono una palla non ho mica gli occhi e il culetto”. Ero di nuovo sotto scacco. Avevo bisogno di tempo per riflettere. Non ero più sicuro neppure io di sapere cos’è la sinistra. “Senti, ne riparliamo quando sarai una palla, adesso non ho tempo. Se vuoi, vallo a chiedere a tua madre.” Era un po’ come dare un calcio alla scacchiera, lo so. Mi dispiaceva usare la mia autorità per troncare quel nodo gordiano, ma non v’era altra soluzione. Lui se ne è andato e io ho potuto finalmente riprendere in mano il mio giornale. Dopo qualche minuto è tornato. “La mamma è arrabbiata perché non le ho portato la spazzola”. “Arrabbiata?”. “Sì. Le ho detto di aspettare domani mattina. Che me l’hai detto tu…”.





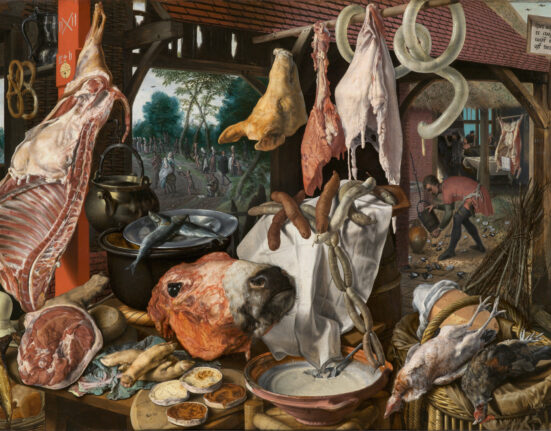
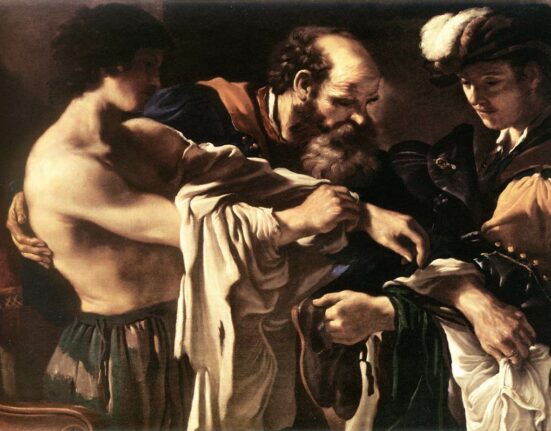
12 Comments