a cura di Diego Fusaro
“Arriviamo a capire che cosa significa pensare quando noi stessi pensiamo. Perché un tale tentativo riesca, dobbiamo essere preparati ad imparare a pensare. Non appena ci impegnamo in questo imparare, abbiamo già anche confessato che non siamo capaci di pensare. Eppure, l’uomo significa colui che può pensare, e ciò a giusto titolo ” (“Che cosa significa pensare”).
Martin Heidegger (1889-1976) ha una formazione giovanile di stampo teologico e religioso, molto influenzata dall’ambiente familiare, e questa matrice teologica resterà costante in tutto il suo pensiero; la sua fu una vita piuttosto regolare, segnata da pochi eventi, tra i quali il più importante fu senz’altro l’adesione al nazismo: ciò ha fatto molto discutere e proprio per via di quest’adesione, dopo il 1945, Heidegger fu emarginato dagli ambienti culturali tedeschi. Essa risulta particolarmente fastidiosa se teniamo presente che il suo maestro, Husserl, fu espulso dalla Germania in quanto ebreo e Heidegger gli prese il posto negli ambienti accademici: in veste di rettore dell’università, pronunciò un acceso discorso in cui tesseva le lodi del nazismo; ma, per onestà, è bene ricordare che egli non ha mai abiurato, ma, al contrario, si è sempre assunto le sue responsabilità. E del resto la sua adesione al nazismo durò pochissimo: dopo il celebre discorso in cui elogiava il nazismo, Heidegger se ne allontanò, ritirandosi all’interno della vita accademica, e arrivò perfino ad opporsi vivamente all’espulsione nazista degli insegnanti ebrei. Trattando il suo pensiero, ci accorgeremo di come in realtà l’adesione heideggeriana al nazismo sia più complessa del previsto e non possa risolversi in una questione di comodo: si tratta di un’adesione che potremmo, in un certo senso, definire “strumentale”, in quanto Heidegger vede nel nazismo non un fine, ma uno strumento attraverso il quale far emergere alcune cose importanti. Sul versante culturale, gli studiosi del suo pensiero hanno individuato essenzialmente due fasi nella sua filosofia: il punto di confine tra di esse si colloca, anche se in modo non del tutto ben definito (poiché in quegli anni il filosofo pubblica pochissimo), all’incirca negli anni ’30. Dopo aver pronunciato il discorso rettorale di adesione al nazismo ed essersi immediatamente ritirato nella vita accademica, non pubblica più quasi nulla fino agli anni ’40. Da quel momento in poi si entra in una nuova stagione del suo pensiero: tra l’Heidegger degli anni ’20 e quello degli anni ’40 troviamo quella che lui stesso definisce “Kehre”, ovvero una svolta. Sul fatto che una svolta ci sia stata nel suo pensiero tutti gli studiosi concordano: meno chiaro, tuttavia, è di che genere essa sia stata. Qualcuno ha sostenuto che si tratta di una svolta radicale e che l’Heidegger degli anni ’40 dica cose diversissime da quello degli anni ’30, ma c’è anche chi, sulla scia dell’interpretazione che Heidegger stesso dà del proprio pensiero, tende a intendere tale svolta come lieve e piuttosto sfumata. Secondo questa linea interpretativa, il problema centrale nella filosofia heideggeriana resterebbe sempre lo stesso e a cambiare sarebbero esclusivamente gli strumenti impiegati dal filosofo nel tentativo di risolverlo. Questo permetterebbe anche di capire, almeno in parte, perché si studia Heidegger tra gli esistenzialisti sebbene egli non abbia mai accettato di essere etichettato come tale e, anzi, dopo la svolta, abbia polemizzato aspramente con l’esistenzialismo: ancora più curioso rispetto a questo rifiuto dell’etichetta esistenzialista è il fatto che la stragrande maggioranza dei pensatori esistenzialisti si ispiri ad Heidegger sebbene egli neghi che la propria filosofia sia esistenzialista. In gioventù, Heidegger oscilla fra teologia, fenomenologia e ontologia: proprio come Nietzsche, anch’egli può essere considerato un pensatore “inattuale”, che scrive nel Novecento ma che si occupa di problemi fin troppo classici. Heidegger, infatti, dedica costantemente la sua attenzione alla metafisica, in particolare alla dottrina dell’essere in Aristotele: come testimonianza dei suoi interessi metafisici merita di essere ricordata la sua tesi di dottorato su “La dottrina delle categorie e del significato in Duns Scoto” (1915).
abiurato, ma, al contrario, si è sempre assunto le sue responsabilità. E del resto la sua adesione al nazismo durò pochissimo: dopo il celebre discorso in cui elogiava il nazismo, Heidegger se ne allontanò, ritirandosi all’interno della vita accademica, e arrivò perfino ad opporsi vivamente all’espulsione nazista degli insegnanti ebrei. Trattando il suo pensiero, ci accorgeremo di come in realtà l’adesione heideggeriana al nazismo sia più complessa del previsto e non possa risolversi in una questione di comodo: si tratta di un’adesione che potremmo, in un certo senso, definire “strumentale”, in quanto Heidegger vede nel nazismo non un fine, ma uno strumento attraverso il quale far emergere alcune cose importanti. Sul versante culturale, gli studiosi del suo pensiero hanno individuato essenzialmente due fasi nella sua filosofia: il punto di confine tra di esse si colloca, anche se in modo non del tutto ben definito (poiché in quegli anni il filosofo pubblica pochissimo), all’incirca negli anni ’30. Dopo aver pronunciato il discorso rettorale di adesione al nazismo ed essersi immediatamente ritirato nella vita accademica, non pubblica più quasi nulla fino agli anni ’40. Da quel momento in poi si entra in una nuova stagione del suo pensiero: tra l’Heidegger degli anni ’20 e quello degli anni ’40 troviamo quella che lui stesso definisce “Kehre”, ovvero una svolta. Sul fatto che una svolta ci sia stata nel suo pensiero tutti gli studiosi concordano: meno chiaro, tuttavia, è di che genere essa sia stata. Qualcuno ha sostenuto che si tratta di una svolta radicale e che l’Heidegger degli anni ’40 dica cose diversissime da quello degli anni ’30, ma c’è anche chi, sulla scia dell’interpretazione che Heidegger stesso dà del proprio pensiero, tende a intendere tale svolta come lieve e piuttosto sfumata. Secondo questa linea interpretativa, il problema centrale nella filosofia heideggeriana resterebbe sempre lo stesso e a cambiare sarebbero esclusivamente gli strumenti impiegati dal filosofo nel tentativo di risolverlo. Questo permetterebbe anche di capire, almeno in parte, perché si studia Heidegger tra gli esistenzialisti sebbene egli non abbia mai accettato di essere etichettato come tale e, anzi, dopo la svolta, abbia polemizzato aspramente con l’esistenzialismo: ancora più curioso rispetto a questo rifiuto dell’etichetta esistenzialista è il fatto che la stragrande maggioranza dei pensatori esistenzialisti si ispiri ad Heidegger sebbene egli neghi che la propria filosofia sia esistenzialista. In gioventù, Heidegger oscilla fra teologia, fenomenologia e ontologia: proprio come Nietzsche, anch’egli può essere considerato un pensatore “inattuale”, che scrive nel Novecento ma che si occupa di problemi fin troppo classici. Heidegger, infatti, dedica costantemente la sua attenzione alla metafisica, in particolare alla dottrina dell’essere in Aristotele: come testimonianza dei suoi interessi metafisici merita di essere ricordata la sua tesi di dottorato su “La dottrina delle categorie e del significato in Duns Scoto” (1915).
L’ontologia sarà il nucleo di indagine della filosofia heideggeriana, anche nei momenti in cui il filosofo sembrerà più distante da essa. In questo periodo giovanile, però, egli si occupa anche di teologia di tradizione paolina: affrontando il problema della teologia cristiana, Heidegger insiste sul carattere di “evento” tipico dei contenuti cristiani. 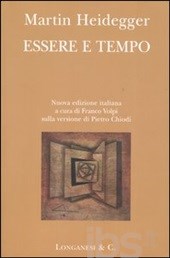 Nell’ontologia tradizionale le strutture fondamentali della realtà non avvengono, ma sono: ad avvenire sono i fatti, mentre, secondo quella tradizione avviata da Parmenide, l’essere in quanto tale è statico; in una concezione del genere, nota Heidegger, l’essere e il tempo sono due concetti che si escludono a vicenda, poiché l’essere è atemporale e il tempo è la dimensione del divenire. La novità introdotta dal cristianesimo è che l’essere per antonomasia (Dio) non si limita ad essere, ma, attraverso l’incarnazione del Verbo, avviene, cosicchè ci si trova di fronte ad un evento dell’essere. Si tratta di un’innovazione radicale, che stravolge la tradizione di stampo parmenidea: il fatto stesso che Platone parlasse in una sola opera (Il Timeo) del tempo e in essa non trattasse dell’essere (le idee), attesta la tradizionale inconciliabilità delle nozioni di essere e di tempo. Queste riflessioni di fondo resteranno costanti in tutta l’attività filosofica di Heidegger, tant’è che la sua opera più famosa, del 1927, si intitolerà “Essere e tempo”. E una delle principali prerogative di Heidegger è di giocare con le parole: in tedesco, “Essere e tempo” si intitola “Sein und Zeit” e il filosofo fa notare la forte assonanza tra i due termini, quasi come se, in definitiva, l’essere e il tempo fossero la stessa cosa. Ma in gioventù Heidegger, oltrechè dalla teologia, risulta anche influenzato dalla fenomenologia di Husserl: in particolare, in Heidegger resta l’idea husserliana che la coscienza sia sempre costitutivamente intenzionale; la coscienza, in altri termini, si riferisce sempre a qualcos’altro, qualsiasi atto umano è un riferirsi a qualcosa, cosicchè il nostro volere, pensare, e fare è sempre riferito a qualcosa. Se l’atteggiamento di Husserl, però, era iperclassico, in quanto portava all’esasperazione la tendenza teoretica riservata da Aristotele alla filosofia, quasi sganciandosi dal mondo (che non a caso veniva da Husserl messo tra parentesi), l’indagine esistenzialista (sebbene Heidegger rifiuti di essere bollato come “esistenzialista”) verte sull’esistenza e quest’ultima implica l’essere immersi in quel mondo sul quale Husserl sospendeva il giudizio.
Nell’ontologia tradizionale le strutture fondamentali della realtà non avvengono, ma sono: ad avvenire sono i fatti, mentre, secondo quella tradizione avviata da Parmenide, l’essere in quanto tale è statico; in una concezione del genere, nota Heidegger, l’essere e il tempo sono due concetti che si escludono a vicenda, poiché l’essere è atemporale e il tempo è la dimensione del divenire. La novità introdotta dal cristianesimo è che l’essere per antonomasia (Dio) non si limita ad essere, ma, attraverso l’incarnazione del Verbo, avviene, cosicchè ci si trova di fronte ad un evento dell’essere. Si tratta di un’innovazione radicale, che stravolge la tradizione di stampo parmenidea: il fatto stesso che Platone parlasse in una sola opera (Il Timeo) del tempo e in essa non trattasse dell’essere (le idee), attesta la tradizionale inconciliabilità delle nozioni di essere e di tempo. Queste riflessioni di fondo resteranno costanti in tutta l’attività filosofica di Heidegger, tant’è che la sua opera più famosa, del 1927, si intitolerà “Essere e tempo”. E una delle principali prerogative di Heidegger è di giocare con le parole: in tedesco, “Essere e tempo” si intitola “Sein und Zeit” e il filosofo fa notare la forte assonanza tra i due termini, quasi come se, in definitiva, l’essere e il tempo fossero la stessa cosa. Ma in gioventù Heidegger, oltrechè dalla teologia, risulta anche influenzato dalla fenomenologia di Husserl: in particolare, in Heidegger resta l’idea husserliana che la coscienza sia sempre costitutivamente intenzionale; la coscienza, in altri termini, si riferisce sempre a qualcos’altro, qualsiasi atto umano è un riferirsi a qualcosa, cosicchè il nostro volere, pensare, e fare è sempre riferito a qualcosa. Se l’atteggiamento di Husserl, però, era iperclassico, in quanto portava all’esasperazione la tendenza teoretica riservata da Aristotele alla filosofia, quasi sganciandosi dal mondo (che non a caso veniva da Husserl messo tra parentesi), l’indagine esistenzialista (sebbene Heidegger rifiuti di essere bollato come “esistenzialista”) verte sull’esistenza e quest’ultima implica l’essere immersi in quel mondo sul quale Husserl sospendeva il giudizio.
Dunque Heidegger eredità la nozione husserliana di “intenzionalità”, ma respinge nettamente l’ipotesi che essa resti interna solo all’orizzonte della coscienza: ne consegue che per Heidegger il carattere intenzionale non implica soltanto il tendere alle idee, ma anche il tendere e il riferirsi al mondo; questo atteggiamento, proprio di Heidegger, rispecchia in realtà buona parte delle posizioni esistenzialistiche, che per lo più vedono come marginale l’aspetto teoretico, tanto caro ad Husserl, perché l’esistenza è, in primo luogo, essere nel mondo. Se nel periodo giovanile il filosofo oscillava soprattutto tra la teologia e la fenomenologia, con la prima fase vera e propria della sua filosofia egli proietta la propria indagine sull’essere. Questa fase si apre con la pubblicazione di “Essere e tempo”: all’inizio dell’opera, Heidegger dichiara di condividere sostanzialmente l’antica affermazione aristotelica secondo cui il problema della filosofia è chiarire che cosa è l’essere; egli proverà dunque a fornire una risposta a tale quesito, ma fa subito notare come si debba necessariamente dare a tale domanda una risposta articolata in termini diversi rispetto a qualsiasi altra. Se alla domanda “cosa è x?” (dove x sta per “uomo”, “animale”, “casa”, ecc) si può rispondere dando una definizione, cioè effettuando un ritaglio all’interno dell’essere, quest’operazione è inattuabile se ci domandiamo “cosa è l’essere”, dato che l’essere è appunto quell’orizzonte all’interno del quale ritagliamo delle porzioni nel dare definizioni. E se l’essere è quell’orizzonte ultimo su cui si stagliano tutte le cose tranne che l’essere stesso, allora non ci si dovrà interrogare sulla definizione dell’essere, ma sul senso dell’essere: ed è a questo proposito che Heidegger si propone di percorrere una nuova strada, quella dell’analisi dell’esistenza. Infatti, per provare a comprendere il senso dell’essere si deve provare a porre questa domanda passando attraverso l’analisi di quell’ente particolarissimo che è radicato nell’essere e che si pone esso stesso domande sull’essere, quell’ente cioè per cui l’essere rappresenta un problema: per provare a cogliere il senso dell’essere si deve dunque provare ad indagare l’esistenza umana, dal momento che l’uomo è immerso nell’essere e ha la capacità di interrogarsi su di esso ( “l’uomo significa colui che può pensare“) . Cosa sono l’essere, l’ente e l’esistenza? L’essere, propriamente, non è una cosa: come aveva sottolineato Aristotele, la filosofia deve indagare sull’essere in quanto essere, depurato da ogni qualità ad esso inerente; da ciò deriva il fatto che l’essere non sia una cosa, ma l’orizzonte su cui si possono definire e riconoscere le singole cose, che altro non sono se non gli “enti”. L’esistenza, invece, ha sempre un carattere di trascendenza, come aveva già sottolineato Kierkegaard: ciò significa che un ente che esiste sta fuori di sé, ovvero non è mai solo ciò che è in quel determinato momento, ma anche quello che progetta di essere per il futuro. Ogni esistenza, dunque, è un progetto, un essere slanciato verso l’avvenire: se la pietra racchiude in se stessa tutto il proprio significato, l’uomo, invece, non è mai tutto in se stesso, ma si trascende di continuo, quasi come se pendesse in avanti. Sotto questo profilo, per Heidegger, solo l’uomo esiste: ecco perché l’uomo è un ente ma, a differenza degli altri enti, è dotato di esistenza. Heidegger tende frequentemente ad impiegare parole antiche colorandole di nuovi significati, convinto che scavando in esse si possano trovare significati nascosti e più profondi. Per fare ciò, si avvale di un artificio grafico che mette in luce come, pur essendo termini di vecchia data, vengano ripresi in una nuova accezione: mette i trattini tra le lettere; e così progetto diventa pro-getto, a sottolineare l’idea del gettarsi avanti dell’esistenza; quest’ultima diventa e-sistenza, con l’idea del venir fuori di continuo verso il futuro. Letteralmente, “esistenza” in tedesco sarebbe “da-sein”, cioè “essere qui”: in italiano diventa “esser-ci” e implica che l’esistenza sia sempre situata in un luogo del mondo e questo è connesso con l’intenzionalità fenomenologica (per cui ogni atto è un riferirsi a qualcosa) e con l’idea che l’uomo sia l’unico ente che si interroga sull’essere; inoltre, suggerisce l’idea sartreana secondo la quale l’uomo è gettato nel mondo ed è condannato ad essere libero. Quella di Heidegger è dunque una posizione apparentemente esistenzialista che, se meglio analizzata, si rivela invece ontologica: infatti, al pensatore tedesco interessa l’essere ma, poiché non lo si può trattare come tutti gli altri oggetti, egli ricorre ad un’ “analitica dell’esistenza” orientata a cogliere il senso dell’essere. Ecco perché, per Heidegger, l’analitica esistenziale non è un obiettivo, ma solo uno strumento: e in “Essere e tempo” egli attua questa analitica dell’esistenza nel tentativo di cogliere il senso dell’essere, non per fare un’analisi fine a se stessa sul senso dell’esistenza umana; l’opera, tuttavia, resta incompiuta perché Heidegger dice che gli è mancato il linguaggio per sviluppare pienamente l’analisi ontologica. Da queste considerazioni emerge come, in realtà, il tema trattato nell’opera è “Esistenza e tempo”, in quanto, per indagare sull’essere attraverso l’esistenza, Heidegger finisce per non trattare affatto la tematica dell’essere. L’ambiguità sta quindi nel fatto che ci troviamo di fronte ad un’opera che, nelle intenzioni dell’autore, doveva essere ontologica ma che in fin dei conti non fa altro che trattare dell’esistenza: ed è per questo motivo che molti pensatori hanno visto in Heidegger il punto di partenza per le riflessioni esistenzialistiche. Ma, stando a quanto abbiamo finora detto, possiamo dare ragione ad Heidegger quando dice che la “svolta” nel suo pensiero non è stata così radicale: il suo obiettivo resta sempre e comunque quello ontologico e se anche in “Essere e tempo” risalta l’analitica esistenziale, ciò non toglie che essa resti un mero strumento; sia nella sua prima fase (quella “esistenzialista”) sia nella seconda (che sarà “ermeneutica”) l’essere resta al centro dell’indagine. Nel periodo in cui Heidegger conduce l’analisi esistenziale, risulta centrale la coppia autenticità/inautenticità: già Kierkegaard, a suo tempo, aveva insistito sul fatto che è più facile che si salvi chi crede in qualcosa di sbagliato ma in modo sincero e autentico piuttosto di chi crede in modo inautentico in cose giuste. Heidegger riprende questa coppia di concetti e li applica all’esistenza, scavando, come sempre, nell’intimità delle parole e scoprendo in esse una verità nascosta. In particolare, egli nota, nella parola “autentico” è racchiusa la radice greca “autoV“, che significa “se stesso”; una cosa, pertanto, sarà autentica quando è se stessa, quando è propria fino in fondo.
Cerchiamo di capire meglio in che senso: si può parlare di esistenza autentica quando l’esser-ci, soggetto dell’esistenza, compie scelte vere, appunto “autentiche”, quando cioè nelle scelte mette in gioco se stesso come l’Abramo di Kierkegaard. Viceversa, un’esistenza sarà inautentica quando sarà caratterizzata da non-scelte, da un’assoluta non-originarietà. La distinzione nell’ambito dell’analitica esistenziale tra autentico e inautentico viene poi da Heidegger inserita in un contesto fenomenologico: si tratta, dice Heidegger, di vedere le strutture di fondo dell’esistenza così come esse si manifestano nella “quotidianità media“, ovvero nella vita di tutti i giorni. E dunque il pensatore tedesco procede all’analisi dei modi fondamentali in cui l’esistenza si manifesta: il primo concetto che emerge è che l’esistenza è un essere-nel-mondo; i trattini tra una parola e l’altra servono, in questo caso, non a separare (come era nel caso dell’esser-ci), bensì ad unire. E dire “essere nel mondo” senza i trattini è un altro modo per dire esser-ci, dato che “essere qui” vuol dire appunto essere situati nel mondo: se invece poniamo i trattini tra una parola e l’altra (essere-nel-mondo), tutto cambia. Se infatti lo scrivo senza trattini, do per scontato che ci sia un mondo già costituito e un essere che ad esso si rapporta; ma Heidegger vuole sottolineare come il mondo, propriamente parlando, esiste solo nella misura in cui è costituito dalla coscienza: essa si riferisce sempre, husserlianamente, a qualcosa e ciò comporta un relazionarsi pratico col mondo; ne consegue che, proprio come per Husserl era la coscienza ad essere intenzionale, anche per Heidegger le cose stanno in questi termini. Il mondo non è un qualcosa che esista prima: al contrario, è la natura stessa della coscienza che, proprio in virtù del suo naturale relazionarsi intenzionale, si crea il mondo, il quale si trova così ad esistere solo nella misura in cui ci sono coscienze che si relazionano a qualcosa. Con quest’asserzione, però, Heidegger non intende avvicinarsi alle tesi idealistiche e, soprattutto, fichteane dell’Io che pone il non-Io: infatti, non è la coscienza che produce il mondo in sè, ma, semplicemente, il mondo è l’insieme delle cose utilizzabili. Che poi ci sia un mondo indipendente da noi e dalla nostra coscienza, ad Heidegger non interessa, perché per noi esiste solo e soltanto il mondo con cui ci relazioniamo e quel mondo è appunto prodotto dalla coscienza, come si evince benissimo nel momento in cui Heidegger dice che esso è l’insieme delle cose che possiamo utilizzare. In tale prospettiva, è centrale la categoria di cura: la cura consiste nel badare e nel prestare attenzione alle cose poiché, se la coscienza è intenzionalità, allora essa non può che tendere alle cose del mondo e prendersene cura. Ed è a questo punto che affiora uno dei maggiori stravolgimenti mai avvenuti nella cultura occidentale: da Aristotele in poi era invalsa l’idea che l’uomo avesse nell’ambito della realtà un atteggiamento teoretico da cui tutti gli altri derivavano (la tecnica stessa altro non era se non un’applicazione del sapere); Heidegger stravolge questa concezione antichissima e sostiene che l’atteggiamento intenzionale della coscienza costituisce il mondo come insieme di cose utilizzabili con l’inevitabile conseguenza che la modalità originaria della coscienza è pratica, volta all’azione, poiché tende a usare le cose e a crearsi un mondo di cose utilizzabili. L’attività conoscitiva non è più, aristotelicamente, alla base della natura umana ma, al contrario, è uno dei tanti modi in cui si possono utilizzare le cose come strumenti dell’esistenza: conoscere una cosa è uno dei tanti modi in cui posso usare quella cosa, instaurando con essa un rapporto teoretico. In questa maniera, l’esser-ci è essere-nel-mondo: il problema è che ci sono due modi diversi di essere situati nel mondo; uno è quello dell’autenticità, l’altro è quello dell’inautenticità. L’uomo, infatti, è un essere e, in quanto tale, nel relazionarsi col mondo manifesta spesso una tendenza che Heidegger definisce alla “deiezione”, cioè al trasformarsi in una cosa come le altre: e ciò che distingue le cose dall’uomo è che esse sono tutte in se stesse, mentre l’esser-ci è sempre trascendente, ossia affacciato sul futuro. E nel suo relazionarsi col mondo, potrà assumere atteggiamenti che lo portino a rinunciare all’autenticità, rinunciando in questo modo all’esistenza e alla progettualità; il che richiama alla mente la vita estetica di Don Giovanni delineata da Kierkegaard, una vita in cui l’unica vera scelta che si compie è quella di non scegliere, cioè di lasciarsi vivere passivamente: e questa esistenza è immanentistica, non è vera, bensì è inautentica, dato che perde il suo carattere di libera progettualità proiettata nel futuro. L’esistenza inautentica, precisa Heidegger, è caratterizzata dal “Si” riflessivo (si fa, si pensa, si crede, ecc), imperante nell’età della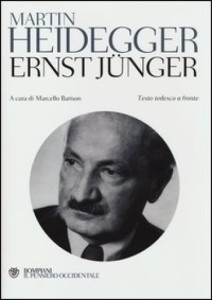 massificazione: e con il solito scavo nella terminologia, si può notare come in tedesco la parola “man” (“Si”) è molto affine a “mensch” (“uomo”), a sottolineare che il “Si” è l’atteggiamento proprio dell’uomo che si dedica ad un’esistenza inautentica, non propria. In particolare, questo atteggiamento nasce nel momento in cui l’uomo rinuncia alle proprie scelte per comportarsi nel modo in cui lo spinge a comportarsi il “Si”, cioè la collettività: e in ciò egli diventa una “cosa” priva di progettualità, viene passivamente trascinato dalla corrente e si trova di fronte alla scelta conformistica. Quando l’esistenza umana è inautentica, perché dominata dal “Si”, l’uomo non parla più né è indotto ad aspirare alla conoscenza: il parlare cede il passo alla “chiacchiera” e la conoscenza viene sostituita dalla “curiosità”. Infatti, nel momento in cui cedo al “Si”, non parlo più di cose che coscientemente sento mie e di cui voglio parlare con gli altri.
massificazione: e con il solito scavo nella terminologia, si può notare come in tedesco la parola “man” (“Si”) è molto affine a “mensch” (“uomo”), a sottolineare che il “Si” è l’atteggiamento proprio dell’uomo che si dedica ad un’esistenza inautentica, non propria. In particolare, questo atteggiamento nasce nel momento in cui l’uomo rinuncia alle proprie scelte per comportarsi nel modo in cui lo spinge a comportarsi il “Si”, cioè la collettività: e in ciò egli diventa una “cosa” priva di progettualità, viene passivamente trascinato dalla corrente e si trova di fronte alla scelta conformistica. Quando l’esistenza umana è inautentica, perché dominata dal “Si”, l’uomo non parla più né è indotto ad aspirare alla conoscenza: il parlare cede il passo alla “chiacchiera” e la conoscenza viene sostituita dalla “curiosità”. Infatti, nel momento in cui cedo al “Si”, non parlo più di cose che coscientemente sento mie e di cui voglio parlare con gli altri.
Al contrario, “chiacchiero” avvalendomi di modi di pensare comune e tendo a parlare delle cose di cui tutti parlano nel modo in cui tutti ne chiacchierano. E Heidegger nota una cosa piuttosto interessante: non si può sfuggire al “Si” nemmeno facendo gli anticonformisti perché, in definitiva, anche l’anti-conformismo è un conformismo. Nel momento in cui regna il conformismo, infatti, tutti cercano disperatamente di sottrarsi ad esso e perciò si rifugiano nell’anti-conformismo che, diventando meta di tutti, è ancora sotto il controllo del “Si”: trasgredendo la norma non si esce dai ranghi del “Si”, nota Heidegger, perché non si compie una libera scelta personale, ma anzi si trasgredisce come “Si” trasgredisce, cioè nello stesso modo in cui lo fanno anche gli altri. Un esempio di anti-conformismo che sfugge al “Si” può essere quello di Socrate, il quale sa tanto inquadrarsi perfettamente nelle situazioni canoniche quanto sottrarsi ad esse: nel “Simposio” platonico, egli partecipa come tutti gli altri al convivio ma poi, quand’è il momento, se ne va. Proprio in virtù dell’autenticità delle sue scelte egli è un vero anti-conformista: sceglie sempre liberamente senza mai farsi influenzare dal “Si”. Oltrechè dalla chiacchiera, l’epoca contemporanea è secondo Heidegger caratterizzata dalla curiosità: l’interesse culturale autentico e genuino, profondo e motivato interiormente viene meno e cede il passo ad una banale e morbosa curiosità dominata dal “Si”. Il risultato di questa situazione è la “deiezione”, cioè la trasformazione dell’uomo in cosa come tutte le altre: egli perde la sua libertà di scelta e tradisce l’esistenza autentica, abbracciando quella inautentica; quest’ultima, priva di ogni progettualità nel futuro, esula dalla temporalità, a differenza di quella autentica. Esaminiamo dunque l’esistenza autentica: centrale è il concetto di angoscia, che, come Kierkegaard, Heidegger riconduce alla paura del nulla. La grande novità consiste tuttavia nel fatto che Heidegger collega in positivo questo sentimento del nulla al problema della morte: riprendendo un’antica espressione platonica, si può affermare che la vita del saggio è una lunga preparazione alla morte, la quale (nella prospettiva platonica) altro non è se non un trapasso ad un’altra vita puramente spirituale; Dante stesso, similmente, afferma che il vivere è un correre alla morte. Heidegger, invece, parla espressamente di essere-per-la-morte, espressione che, un po’ come quella platonica, suggerisce come il vivere sia in funzione della morte. In sostanza, ciò che Heidegger vuol dire quando parla di essere-per-la-morte è che la caratteristica costitutiva dell’esser-ci è di essere finito e, in virtù di ciò, di sentire la prospettiva del nulla e di essere colto per questo dall’angoscia, la quale è, appunto, il sentimento della morte: ora, questo sentimento, nella tradizione precedente ad Heidegger era per lo più stato considerato come distruttivo, dal momento che, in vista della morte, ogni nostra azione perde di significato e, non a caso, di fronte al senso di questo carattere distruttivo della morte l’uomo è ricorso alla religione, cioè al convincimento che la morte non sia la fine di tutto; così era anche per Platone, che concepiva la morte come apertura di una nuova e più alta prospettiva di vita. Per Heidegger, invece, con essa finisce tutto e vivere per la morte significa condurre la propria esistenza nella piena consapevolezza che il nostro orizzonte di vita è limitato, senza però far perdere di significato alla vita o approdare alla religione, come invece è sempre stato tradizionalmente. Heidegger dice infatti che sono proprio il carattere finito dell’esistenza e l’angoscia che ne deriva a conferire un senso alla vita: è proprio l’angoscia, ovvero l’aver sempre presente la finitudine della propria esistenza, a dare un senso autentico alle scelte che si compiono. Infatti, si può parlare di “esistenza autentica” solo nel caso in cui vi sia progettualità e libertà assoluta nelle scelte: ma le scelte, se inquadrate in un orizzonte di vita infinito, non hanno senso, non sono progettuali fino in fondo. In una prospettiva di vita eterna, le scelte perdono di significato perché sono sempre reversibili: supponendo di godere di una vita eterna, nel momento in cui scelgo un lavoro scartandone un altro, non sto compiendo una scelta totalmente libera e progettuale, perché se anche quel lavoro non mi piace, posso sempre sceglierne un altro, senza perdere mai tempo (visto che usufruisco di una vita eterna). Sembra quasi che Heidegger legga l’eventualità di una vita eterna come una condanna. E molti suoi lettori, riflettendo su queste sue considerazioni, hanno evocato a tal proposito la letteratura sui vampiri: essi esemplificano perfettamente la tematica heideggeriana dell’immortalità come condanna a vivere in eterno. Nell’ambito della vita finita, questo non avviene: il numero di anni di cui si dispone è finito, come anche il numero di scelte che si possono fare; e poi, oltre ad essere limitate, le scelte che si possono fare si escludono a vicenda e, spesso, non sono reversibili: come diceva Kierkegaard, la “logica” dell’esistenza è quella dell’ “aut-aut”, si sceglie liberamente o una cosa o l’altra, e il fatto stesso di compiere quella scelta esclude l’altra. Ecco perché per Heidegger l’esistenza è autentica quando è pervasa dall’angoscia che scaturisce dal prendere coscienza della nostra finitudine: e il vivere-per-la-morte ha dunque una valenza altamente positiva, in quanto rende autentiche le scelte e, con esse, la vita; cosa che non potrebbe avvenire in una prospettiva di vita eterna. La conclusione provvisoria (in quanto l’opera resta incompiuta per la “mancanza di linguaggio” che impedisce all’autore di proseguire) di “Essere e tempo” concerne il carattere intrinsecamente storico dell’esistenza: le riflessioni sull’essere-per-la-morte suggeriscono efficacemente come l’esistenza non si collochi nell’eternità, ma in una dimensione storica e temporale; e Heidegger fa notare (sulla scia della constatazione epicurea che la morte non la incontriamo mai perché quando ci siamo noi non c’è lei e viceversa) che il fatto della morte non lo viviamo veramente mai, giacchè possiamo vivere come fatto solamente la morte altrui, mentre la nostra la viviamo sempre e soltanto come possibilità solo nostra, nella consapevolezza che, prima o poi, essa ci coglierà. Ne consegue che la morte ha per noi un significato non come fatto, ma come possibilità: e, a questo punto, Heidegger fa acutamente notare come nella società moderna, in cui non si parla ma si chiacchiera e non si aspira alla conoscenza ma alla curiosità, la morte è stata rimossa. E l’aspetto più inautentico dell’esistenza della società di massa risiede proprio nel fatto che si vive perfino la morte nel “Si”: non più “io muoio”, ma “Si muore”, quasi come se la morte non ci coinvolgesse mai in prima persona; essa viene tragicamente inserita nel “Si” generico e, pertanto, perde il suo significato di possibilità: viene meno l’essere-per-la-morte e, con esso, la libertà di scelta. Heidegger contrappone quindi la posizione comune sulla morte a quella che il saggio deve far propria: l’opinione comune esorcizza l’idea della morte, ritiene pusillanime intrattenervisi, la lascia indeterminata e in realtà nasconde la paura effettiva che la certezza della morte suscita. Il saggio invece ignora la paura e affronta l’angoscia della morte, vi convive e anzi anticipa dentro di sé la possibilità che essa si verifichi; scopre così che “la morte è la possibilità più propria dell’esser-ci“, e in tal modo si sottrae alla schiavitù dell’opinione comune, aprendosi alla possibilità di essere autenticamente se stesso e liberandosi dalle illusioni e dagli autoinganni del “Si”. Scrive Heidegger, in “Essere e tempo”, sull’atteggiamento del “Si” verso la morte: “il Si ha già pronta un’interpretazione anche per questo evento. Ciò che si dice a questo proposito, in modo esplicito o sfuggente, come per lo più accade, è questo: una volta o l’altra si
morirà, ma, per ora, si è ancora vivi. L’analisi del ‘si muore’ svela inequivocabilmente il modo di essere dell’essere-quotidiano-per-la-morte. In un discorso del genere la morte è concepita come qualcosa di indeterminato che, certamente, un giorno o l’altro, finirà per accadere, ma che, per intanto, non è ancora presente e quindi non ci minaccia. Il ‘si muore’ diffonde la convinzione che la morte riguarda il Si anonimo. L’interpretazione pubblica dell’esser-ci dice: ‘si muore’; ma poiché si allude sempre a ognuno degli Altri e a noi nella forma del Si anonimo, si sottintende: di volta in volta non sono io“. Ma la morte è la cosa che più di tutte ci appartiene ed è nostra fino in fondo, tant’è che nessun altro può viverla al posto nostro: essa è anzi l’unica certezza della nostra esistenza, in quanto, pur non potendo sapere pressochè nulla di ciò che ci accadrà in futuro, ciononostante possiamo con certezza affermare che, prima o poi, ci toccherà morire.
L’esistenza, nota Heidegger, è proiettata nel tempo e, soprattutto, nel tempo futuro, poiché essa è, per sua natura, progettualità; e nell’analisi che egli fa della temporalità, critica aspramente la tradizionale concezione che intende il tempo come una “cosa” divisa in tre parti (passato, presente, futuro): non si tratta di tre parti distinte, ma di tre aspetti della medesima cosa. A tal proposito, Heidegger fa notare come la parola tedesca che significa “storia” è molto simile al verbo “mandare” e, per questo motivo, egli tende ad interpretare la storia come destino; e questo, egli afferma, vale tanto per i popoli quanto per i singoli. Nel concetto di “storia come destino” Heidegger vede sintetizzata l’identità dei tre aspetti (passato, presente, futuro) che costituiscono il tempo: e dire che per ciascuno di noi la storia è destino implica che essa non sia solo il passato, né, tantomeno, semplicemente il futuro. Al contrario, l’idea che Heidegger evince dalla somiglianza della parola “storia” con la parola “mandare” è che il passato possa da noi essere vissuto in due maniere differenti: da un lato, lo si può accettare come un dato di fatto senza significati reconditi; ma, dall’altro lato, lo si può intendere come un “mandato”, cioè come un destino. E così possiamo concepire il nostro passato come un incarico ricevuto e proprio nella possibilità che abbiamo nel presente di scegliere se vedere il passato come mero dato di fatto o come destino risiede la possibilità che secondo Heidegger abbiamo di scegliere, paradossalmente, il nostro passato: inoltre, se lo leggiamo come un “mandato”, possiamo progettare in base ad esso il nostro futuro e, da questa stretta dipendenza fra le tre dimensioni temporali (passato, presente, futuro), si capisce benissimo come per Heidegger esse siano tre aspetti della medesima cosa. Infatti, l’io e i popoli compiono le loro scelte nel presente sulla base di un destino radicato nel passato e in vista di un progetto situato nel futuro. Sulla base di queste considerazioni, si può facilmente arguire perché Heidegger parli di “storicità dell’esistenza”: e con essa si chiude “Essere e tempo”, questa lunga e complessa analisi dell’esser-ci come via per cogliere l’essere. L’opera si chiude con un avvertimento dell’autore: “il chiarimento della costituzione dell’essere e dell’esserci resta soltanto una via: il fine è l’elaborazione del problema dell’essere in generale“; non essendo riuscito a mantener fede al suo proposito di indagare sull’essere, egli si propone ora di impostare la sua indagine in una nuova maniera. Ed è per questo motivo che Heidegger, dalla storicità dell’esistenza, cercherà di passare alla “storicità dell’essere”: i due concetti chiave del secondo Heidegger (quello del dopo la svolta) sono la metafisica e la verità. Egli opera una vera e propria distruzione della metafisica e un radicale stravolgimento della nozione di “verità”, due operazioni che richiamano immediatamente alla mente la filosofia di Nietzsche. Tuttavia, siamo di fronte a prospettive assai diverse, quasi antitetiche: nel caso della distruzione della metafisica, la partita si gioca tutta sul significato da attribuire al termine “metafisica”. Essa, per Nietzsche, altro non era se non un’ontologia, una pura e semplice pretesa di descrivere com’è il mondo; tant’è che, dichiarato il venir meno dell’essere, anche la metafisica, intesa appunto come descrizione dell’essere, perdeva ogni significato. Per Heidegger, però, la metafisica non è riducibile all’ontologia, in quanto non è il fare discorsi sull’essere, bensì è un certo modo di fare discorsi sull’essere: in particolare, la metafisica sarà quel modo specifico di fare discorsi sull’essere che smarrisce l’autentico significato dell’essere stesso, con il risultato che “ontologia” e “metafisica” sono due concetti antitetici. Detto un po’ banalmente: l’ontologia fa discorsi sull’essere, la metafisica fa discorsi sballati sull’essere. E per Heidegger la distruzione della metafisica si configura come rivalutazione totale dell’ontologia, mentre invece Nietzsche, distrutta una, non poteva che far saltare anche l’altra. La caratteristica portante della metafisica è, dunque, di concepire l’essere in modo errato: il problema del fraintendimento dell’essere era già affiorato in “Essere e tempo”, quando Heidegger faceva notare che l’essere non può essere studiato come un qualsiasi ente, in quanto, essendo impossibile individuarne i confini, non può diventare un oggetto di indagine. E il grande errore della metafisica sta proprio nel concepire l’essere come un qualsiasi altro ente: nel corso della storia, ora l’ha concepito come la somma di tutti gli enti, ora come l’ente supremo (il Dio della teologia, e Heidegger parla appunto di onto-teo-logia), ora, in maniera più raffinata, come aspetto comune a tutti gli enti (Aristotele l’aveva inteso così). La metafisica, dunque, ha concepito l’essere come un ente: ha cioè “smarrito la differenza ontologica“, cioè la differenza che sussiste tra essere e ente. A questo proposito, Heidegger distingue tra un livello “ontologico” proprio dell’essere e un livello “ontico” in cui l’essere viene confuso con gli enti e lo si abbassa al loro livello (che è appunto “ontico”), privandolo della sua specificità.
E Heidegger si propone di rivendicare un’ontologia: quello della metafisica, però, non è solamente un errore, bensì è, dice Heidegger, un “erramento“; il che suggerisce, contemporaneamente, l’idea dell’errore e dell’andare vagando. Si tratta di capire che l’errore della metafisica, commesso molti secoli addietro da Platone e dalla sua “ontificazione” dell’essere (attuatasi attraverso l’indebita trasformazione dell’essere in idee), non è puramente accidentale; al contrario, si è da allora sempre più verificato un erramento, uno sbandamento continuo in virtù del quale l’essere è sempre stato interpretato scorrettamente. Si deve pertanto tornare all’epoca in cui per la prima volta si è commesso tale errore per porre ad esso un riparo: ma è, dice Heidegger, un qualcosa di ben più profondo di un semplice errore. Infatti, non solo è un errore dell’essere, ma è anche un erramento dell’essere, il quale ha una sua storia e che, quindi, non è definito una volta per tutte; viceversa, l’essere segue un suo percorso lungo il quale, di volta in volta, si manifesta in modo diverso e i modi in cui esso si manifesta all’uomo sono in continua trasformazione, sicchè ci si trova di fronte ad un erramento che è, al contempo, dell’essere e dell’uomo. E anche se la metafisica è stata un errore, cioè un modo errato di manifestarsi dell’essere, ciò non toglie che in determinate epoche storiche l’essere non poteva che manifestarsi in quel modo: in particolare, l’epoca della metafisica, iniziata con Platone e chiusasi con Nietzsche (compreso), è l’epoca in cui l’essere si è, paradossalmente, manifestato sotto forma di oblio e di smarrimento. Come senz’altro si ricorderà, Nietzsche non solo aveva mutato il contenuto della verità: ne aveva stravolto la nozione stessa. Heidegger, in modo analogo, compie un’operazione simile e mette in luce l’esistenza di due concetti diversi di verità: un concetto metafisico di verità, e uno ontologico. Il concetto metafisico intende la verità come correttezza, ossia corrispondenza tra ciò che abbiamo nella nostra mente e ciò che è presente nella realtà esterna. La verità metafisicamente intesa tende allora a configurarsi come dominio dell’oggetto da parte del soggetto. Questa concezione della verità, invalsa con Platone, si è protratta per tutto il corso della storia, fino a Nietzsche compreso: se infatti concepiamo la verità metafisica come controllo e dominio dell’oggetto, allora siamo indotti a interpretare in senso metafisico perfino il pensiero scientifico e tecnico. La scienza e la tecnica, infatti, si configurano come  estremizzazione dell’atteggiamento metafisico, in quanto si propongono di dominare concettualmente e materialmente un oggetto esterno al soggetto. Nietzsche stesso (a cui Heidegger dedica due volumi intitolati “Nietzsche”) appare come il prodotto estremo dell’era metafisica: lo si evince benissimo dalla nozione nietzscheana di “volontà di potenza”, nozione secondo la quale viene meno l’importanza dell’essere e viene portato all’estremo il dominio concettuale del mondo da parte del soggetto; infatti, venendo a mancare l’essere, il soggetto si impone e propone interpretazioni potenti, che promuovono la vitalità e risultano sganciate dall’essere. Nietzsche stesso, del resto, dava un giudizio altamente positivo della tecnica, la quale, come abbiam visto, è un’espressione fortissima della metafisica. L’atteggiamento ontologico, invece, lo troviamo in un’altra accezione del termine verità: Heidegger, come suo solito, scava all’interno delle parole per riportare in superficie significati nascosti; la parola su cui egli compie ora tale operazione è la parola greca alhqeia (“verità”); essa, letteralmente, è costituita dall’ a privativa e dal verbo lanqanw (“nascondere”), cosicchè la verità è ciò che non sta nascosto. Nell’interpretazione heideggeriana, l’alhqeia è il non-nascondimento dell’essere; ma non nel senso che sta all’uomo rimuovere il velo che occulta la verità (cioè l’essere), come invece era per Schopenhauer. Al contrario, è l’essere stesso che si disvela: e non è un caso che l’ontologo per eccellenza, Parmenide, nel suo ipotetico viaggio narrato nel testo “Peri fusewV” incontrava diverse divinità (simboleggianti l’essere) che si toglievano da sole il velo che le copriva, senza che fosse il filosofo a compiere tale operazione. Con l’ontologia, dunque, la verità non è più concepita in funzione del soggetto, come invece avveniva con la metafisica: al contrario, il nuovo attore del processo non è più l’uomo, ma l’essere stesso, che si manifesta disvelandosi. La storia dell’essere, dice Heidegger, si articola in diverse tappe, ciascuna delle quali è caratterizzata da un modo particolare di manifestarsi dell’essere: ad ogni epoca storica corrisponde una particolare manifestazione dell’essere. Sorge però spontaneo un quesito: se l’essere è ciò che è, ovvero se l’essere è sempre quello, allora che senso ha parlare di una “storia” dell’essere?
estremizzazione dell’atteggiamento metafisico, in quanto si propongono di dominare concettualmente e materialmente un oggetto esterno al soggetto. Nietzsche stesso (a cui Heidegger dedica due volumi intitolati “Nietzsche”) appare come il prodotto estremo dell’era metafisica: lo si evince benissimo dalla nozione nietzscheana di “volontà di potenza”, nozione secondo la quale viene meno l’importanza dell’essere e viene portato all’estremo il dominio concettuale del mondo da parte del soggetto; infatti, venendo a mancare l’essere, il soggetto si impone e propone interpretazioni potenti, che promuovono la vitalità e risultano sganciate dall’essere. Nietzsche stesso, del resto, dava un giudizio altamente positivo della tecnica, la quale, come abbiam visto, è un’espressione fortissima della metafisica. L’atteggiamento ontologico, invece, lo troviamo in un’altra accezione del termine verità: Heidegger, come suo solito, scava all’interno delle parole per riportare in superficie significati nascosti; la parola su cui egli compie ora tale operazione è la parola greca alhqeia (“verità”); essa, letteralmente, è costituita dall’ a privativa e dal verbo lanqanw (“nascondere”), cosicchè la verità è ciò che non sta nascosto. Nell’interpretazione heideggeriana, l’alhqeia è il non-nascondimento dell’essere; ma non nel senso che sta all’uomo rimuovere il velo che occulta la verità (cioè l’essere), come invece era per Schopenhauer. Al contrario, è l’essere stesso che si disvela: e non è un caso che l’ontologo per eccellenza, Parmenide, nel suo ipotetico viaggio narrato nel testo “Peri fusewV” incontrava diverse divinità (simboleggianti l’essere) che si toglievano da sole il velo che le copriva, senza che fosse il filosofo a compiere tale operazione. Con l’ontologia, dunque, la verità non è più concepita in funzione del soggetto, come invece avveniva con la metafisica: al contrario, il nuovo attore del processo non è più l’uomo, ma l’essere stesso, che si manifesta disvelandosi. La storia dell’essere, dice Heidegger, si articola in diverse tappe, ciascuna delle quali è caratterizzata da un modo particolare di manifestarsi dell’essere: ad ogni epoca storica corrisponde una particolare manifestazione dell’essere. Sorge però spontaneo un quesito: se l’essere è ciò che è, ovvero se l’essere è sempre quello, allora che senso ha parlare di una “storia” dell’essere?
A questo punto Heidegger compie un nuovo scavo nelle parole: il termine “epoca” deriva dal greco epoch, con il quale gli scettici designavano la sospensione di giudizio sul mondo; Husserl stesso aveva impiegato tale termine per indicare l’atto con cui poneva il mondo “tra parentesi”. Ogni epoca, secondo Heidegger, è una sospensione della manifestazione dell’essere; ciò significa che il manifestarsi dell’essere come alhqeia implica che esso si disveli ma anche che sia un venir fuori da un nascondimento che fa parte della natura stessa dell’essere; in altri termini, quest’ultimo presenta nella sua natura sia il disvelamento sia il nascondimento, cosicchè in ogni epoca l’essere è disvelato ma, al contempo, resta in qualche misura nascosto. E i diversi equilibri, in continua trasformazione, che si instaurano nell’essere tra il venir fuori e lo stare nascosto rappresentano le epoche storiche. Ne consegue che ogni epoca è diversa dalle altre perché in ogni epoca l’essere si manifesta diversamente, rimanendo in sospeso (epoch) tra l’uscir fuori e il restar nascosto. Ma ogni epoca, dice Heidegger, si manifesta anche come pensiero: il filosofo tedesco, da un certo momento in poi, abbandona il termine “filosofia”, intriso di concezioni metafisiche accumulatesi nei secoli, e sceglie il termine “pensiero”, più rispettoso nei confronti dell’essere. In questa fase della riflessione heideggeriana, successiva alla “svolta”, l’uomo non è più l’attore della conoscenza, ma assume un atteggiamento collaborativo con l’essere. L’uomo deve infatti mettersi “in ascolto dell’essere” , quasi come se in attesa di una rivelazione improvvisa, e allora con l’espressione “pensiero dell’essere” si designano, contemporaneamente, l’attività con cui l’uomo riflette sull’essere sia l’attività con cui l’essere riflette su se stesso. L’uomo non è più il protagonista (come invece era in “Essere e tempo”), ma è il collaboratore dell’essere; o, per usare un’espressione heideggeriana divenuta celebre, l’uomo è il “pastore dell’essere“: e il pastore non è il proprietario del gregge, ma è semplicemente colui che lo custodisce. Allo stesso modo, l’uomo è tenuto a custodire l’essere senza per questo divenirne il padrone. Questa nuova posizione affiora soprattutto nella “Lettera sull’umanismo” (1947), con la quale Heidegger capovolge la prospettiva sartreana emersa in “L’esistenzialismo è un umanismo” e interpreta il compito del pensiero come impegno non per l’uomo (come invece violeva Sartre), ma per l’essere. In questo modo, il pensatore tedesco prende le distanze dall’esistenzialismo, a cui rinfaccia di assegnare il primato a quell’ente che è l’uomo, dimenticandosi dell’essere; l’uomo, dice Heidegger, è solo il “pastore dell’essere“, colui al quale è affidato il compito di salvaguardare e custodire nel pensiero la verità dell’essere. Con un’altra espressione divenuta altrettanto famosa, Heidegger sostiene che “il linguaggio è la casa dell’essere” : ed è in questa casa che l’uomo conduce la propria esistenza come inquilino, non come possessore, giacchè la casa appartiene all’essere. L’espressione heideggeriana rimanda inevitabilmente alla convinzione degli antichi secondo la quale il tempio è la casa di Dio, nel senso che è il luogo in cui Dio si manifesta meglio. Similmente, nella prospettiva heideggeriana, l’essere si manifesta al meglio nel linguaggio, che dell’essere costituisce appunto la casa: con quest’idea ritorna la tesi, già emersa in “Essere e tempo”, secondo la quale, per indagare l’essere, si deve indagare quell’ente particolare che sa riflettere sull’essere stesso; è solo nell’uomo che, attraverso il linguaggio, l’essere si manifesta al meglio. Ma Heidegger stravolge la nozione di linguaggio: infatti, il linguaggio che esprime il pensiero dell’essere non è un modo per comunicare, ma è il modo in cui l’essere si manifesta, ed è solo mettendosi in ascolto che si entra in contatto con esso. E dire che l’uomo abita nella casa dell’essere, cioè nel linguaggio, significa riconoscere che il linguaggio non è uno strumento che l’uomo si dà: al contrario, egli nasce e vive nel linguaggio, giacchè la sua vita è calata in esso, dall’inizio alla fine. E questo è vero per il linguaggio ma, più ancora, per l’essere: nella concezione ermeneutica si sottolinea, appunto, l’impossibilità di staccarsi dall’oggetto e di vederlo in modo distaccato, cosicchè non si può ipotizzare una conoscenza veramente oggettiva, bensì una comprensione dall’interno.
Da tutte queste considerazioni emerge come sia impossibile parlare del linguaggio e dell’essere in modo oggettivo e distaccato: a rigore, anzi, non si può neanche mai parlare del linguaggio, in quanto ci si trova sempre e comunque a parlare nel linguaggio. Allo stesso modo, non si può parlare dell’essere in modo distaccato, poiché, in quanto enti, siamo parti in causa: ma è possibile diventare strumenti in cui l’essere si manifesta attraverso il linguaggio; si può cioè lavorare sull’essere dall’interno, in modo ermeneutico, ed è ciò che si propone di fare soprattutto Gadamer, l’allievo di Heidegger. Molto rilevante è una raccolta di saggi il cui titolo è traducibile tanto con “Sentieri del bosco” quanto con “Sentieri interrotti”: Heidegger si serve infatti di una parola tecnica che indica quei sentieri del bosco che non portano da nessuna parte, ma che permettono solo di addentrarsi nel bosco. Con quest’immagine, Heidegger vuole dirci che l’essere è come un bosco e che i sentieri non sono strade verso l’essere, ma strade all’interno di esso, cosicchè si può girovagare all’interno dell’essere, senza un criterio che ci permetta di attingerlo; ed è anche in virtù di questa amara constatazione che Heidegger si allontana sempre più dalla filosofia per accostarsi alla poesia (intesa come manifestarsi dell’essere nel linguaggio) e al mettersi a disposizione dell’essere. Heidegger parla esplicitamente di “pensiero rammemorante“: in ogni epoca l’essere si manifesta e, al contempo, si nasconde (la metafisica stessa è un modo di manifestarsi) e questo viene espresso dallo stesso pensiero dei grandi filosofi, attraverso i quali l’essere si manifesta e si nasconde. Dunque, nelle pagine scritte dai vari filosofi e pensatori della storia c’è un detto (manifestarsi dell’essere) e un non-detto (tenersi nascosto dell’essere), presente ma nascosto dalle parole; e noi moderni possiamo approfittare del fatto che viviamo in un’altra epoca, in cui l’essere si manifesta diversamente, per far emergere dal pensiero degli antichi il loro non-detto: in questo consiste appunto il pensiero rammemorante. Grazie alle nuove disvelazioni dell’essere realizzatesi nelle nuove epoche storiche, possiamo in altri termini far emergere cose che i pensatori del passato hanno detto senza saperlo, inavvertitamente. Per rimanere all’immagine del bosco, Heidegger usa un’antica parola tedesca che significa, contemporaneamente, “illuminazione” e “radura”; la radura, quella parte del bosco in cui non vi sono piante, è dunque il luogo in cui si realizza una vera e propria illuminazione; questo significa che se è vero che i sentieri del bosco non portano da nessuna parte e, meno che mai, all’essere, è anche vero che possono condurre a radure in cui l’essere si illumina, in cui cioè si può far luce su di esso. Molto hegelianamente, heidegger sostiene che ogni manifestazione dell’essere è legittima: anche la tecnica, dunque, ha, in quanto espressione dell’essere, una sua legittimità, ma tuttavia essa è, come la scienza, una forma esasperata della metafisica. Proprio perché espressione della metafisica, dunque, la tecnica non può certo essere assolutamente positiva: ma, dice hegelianamente Heidegger, è necessario che gli aspetti negativi vengano vissuti fino in fondo per poter sperare in un cambiamento radicale; tanto più che Hölderlin (il poeta preferito di Heidegger) ha insegnato che “dove è il pericolo, cresce anche ciò che salva“. Il vantaggio della tecnica, se proprio vogliamo vedere come Hegel “la rosa nella croce“, sta nel far emergere la vera e profonda natura della metafisica e del suo tipico dominio dell’uomo sull’essere. Solo se si prende coscienza dell’erramento della metafisica con la tecnica si prospetta anche la possibilità di un nuovo e più corretto cominciamento filosofico. E qualcosa di simile Heidegger lo pensava anche del nazismo: dopo averlo letto, in un periodo in cui simpatizzava ancora per esso, come destino scelto attivamente dal popolo tedesco, egli maturò sempre più la convinzione che il nazismo non fosse positivo in sé, ma solo nella misura in cui, come la tecnica, faceva emergere in una forma estrema l’errore/erramento della metafisica. Anche nell’opera d’arte (soprattutto i quadri) assistiamo sempre ad un gioco tra il detto e il non-detto, cosicchè si cerca di far emergere dalla materia qualche significato, come se l’artista si facesse portavoce dell’essere. E nell’epoca d’arte l’essere si manifesta e si nasconde contemporaneamente: sicchè il critico di oggi può leggere in essa dei significati che l’autore non sapeva di averci messo. Questo giustifica anche il fatto che spesso il critico tira fuori concetti che l’artista non conosceva, ma che ciononostante erano presenti nell’opera d’arte. In questo modo, viene anche giustificata la pluralità delle interpretazioni della medesima opera.
(Fonte originaria www.filosofico.net, con il consenso dell’autore)








2 Comments