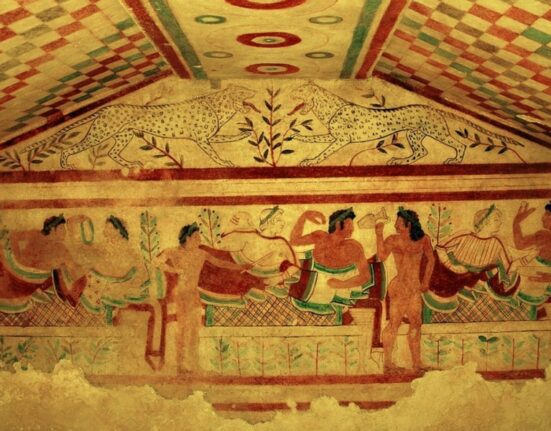In un’opera dal titolo molto accattivante sul piano pubblicitario – però non rispondente alla esatta realtà dei fatti – di Giulio M. Facchetti, L’enigma svelato della lingua etrusca (Roma 2000), nel risvolto della sopraccoperta l’Autore – che è laureato in giurisprudenza – si è presentato in questo modo testuale: «Giulio M. Facchetti, studioso di diritto romano e di storia antica, è attualmente dottorando di ricerca all’Università di Pavia e collabora presso l’Università statale di Milano; cultore di linguistica storica e profondo conoscitore dei problemi della lingua etrusca e delle scritture e lingue dell’antica Creta, negli ultimi anni ha pubblicato, in sedi scientifiche, diversi notevoli interventi sulla scrittura minoica Lineare A e, recentemente, il testo specialistico Frammenti di diritto privato etrusco».
Ovviamente in questi ultimi 15 anni egli ha fatto progressi nella sua carriera accademica, diventando professore aggregato nell’Università dell’Insubria (Varese) ed effettuando nuove acquisizioni nei suoi numerosi campi di interesse.
Ad esaminare e discutere minutamente un’opera di 300 pagine, come questa del Facchetti, sarebbe troppo lungo e dovrei scrivere una mia opera di almeno uguale spessore. Perciò intendo limitarmi all’esame di una sua opera più recente e assai più breve: Appunti di morfologia etrusca (Firenze 2002) con l’intento di esaminare quale sia la sua competenza effettiva in una lingua dei cui problemi egli si è presentato come “profondo conoscitore”.
A pagina 9, num. 1. Non è esatto affermare che uno dei morfemi del plurale etrusco sia –ar, -er, -ur. Se si esamina con attenzione, si deve concludere che il vero morfema è –r, il quale viene fatto precedere da una delle quattro vocali etrusche: a, e, i, u. Esempi clenar «figli», aiser «dèi», tusurϑir «coniugi», ϑansur «attori, celebranti» (non «cerimonieri»!).
Non è vero che l’altro morfema del plurale etrusco sia –cva, –χva. In realtà questo è un “plurale articolato”, cioè composto col pronome ca «questo» in posizione enclitica e col valore di articolo determinativo, per cui culścva non significa semplicemente «porte», ma significa «le porte»; avilχva non significa «anni», ma significa «gli anni». Invece il vero morfema del plurale è –va, come dimostra chiaramente l’appellativo citato subito dopo dallo stesso Facchetti, zusleva «offerte».
Non è affatto certo che il plur. in –r indichi esseri animati: ecco alcuni esempi contrari: acazr (acaz-r) «cose fatte, manufatti, oggetti»; cepar «cippi, cippi confinari»; [ceren cepar nac amce «curate (di tenere) i cippi confinari come erano» (da confrontare col lat. cippus, finora di origine ignota; dell, deli)]; cerur «(oggetti) fatti, manufatti, (vasi) fittili»; naper«napure, mappe» (misura terriera al plur.) [da confrontare coi lat. mappa, nappa «salvietta, tovagliolo, fazzoletto, drappo», lat. napurae «fiocchi per adornare i maiali da sacrificare» (huth naper lescan «quattro napure o mappe in larghezza»)]; mamer probabilmente «cessioni, donazioni», plur. di mama; śacnicleri cilϑl śpureri meϑlumeric enaś «ai sacrifici di culto per le città e le federazioni nostre».
Pagina 10. Non è vero che non si possano spiegare in altro modo le alternanze ci avil «tre anni», ci clenar «tre figli», ci zusle «tre offerte», ci huśur «tre ragazzi». Si possono spiegare facilmente dicendo che la “declinazione di gruppo” coi numerali non era obbligatoria; e se ne capisce la ragione: il plurale era già indicato chiaramente proprio dal numerale.
Pagina 12. Iscrizione ET, Cr 5.2 – 4: Laris Avle Larisal clenar / sval cn suϑi ceriχunce | apac atic / saniśva ϑui cesu | Clavtieϑurasi, che io traduco «Laris (e) Aulo figli di Laris da vivi questo sepolcro avevano costruito; i genitori, e il padre e la madre, (sono) qui deposti – Per la famiglia Claudia». Invece il Facchetti ha tradotto la seconda parte in questo modo: «le paterne (e) le materne <ossa> qui giacciono – nel (sepolcro) dei Claudii». Senonché apac atic, non sono affatto aggettivi, tanto meno al plurale, ma sono sostantivi con la copulativa enclitica –c e significano «e padre e madre» (in polisindeto). D’altronde anche lui esprime dubbi che saniśva significhi <ossa>, mentre significa di certo «genitori», essendo il plurale di sanś(-l) «(del) genitore». Inoltre cesu è sicuramente un participio passato e non un indicativo presente plurale. Clavtieϑurasi è un dativo sigmatico di comodo oppure di appartenenza e nient’affatto un locativo.
Il Facchetti cita di continuo l’etruscologo Luciano Agostiniani, che evidentemente considera il suo “Maestro” e del quale accetta tutte le tesi ad occhi chiusi, compresa la strana interpretazione e traduzione della formula mlaχ mlakas «buono per cosa buona, «cosa buona per un buono» (I opera pg. 144; II pg. 73). Su questa formula invece esiste ormai da tempo una consolidata comunis opinio (ad esempio di A. Trombetti, C. Battisti, M. Runes, K. Olzscha, F. Slotty, M. Pallottino), secondo cui essa in realtà è una “formula di offerta”. Il Pallottino negli «Studi Etruschi» (1931, 1996) ha scritto ripetutamente e testualmente: «Il concetto di donazione ex voto (MLAX) nell’ambito funerario è ormai acquisito con certezza». In effetti la formula propriamente significa «sciogliendo un voto» e già il valente etruscologo A. J. Pfiffig l’aveva confrontata con quelle lat. donum donans, votum vovens, votum solvens (con l’accusativo dell’oggetto interno come nella formula etrusca). Da parte mia quindici anni fa ero intervenuto con uno scritto per dimostrare che questo significato si adatta alla perfezione in tutti i numerosi casi in cui compare la formula, intera o a membri disgiunti, mentre il significato di «buono per cosa buona» si adatta soltanto in pochi casi, invece non si adatta per nulla in numerosi altri (M. Pittau, Tabula Cortonensis – Lamine di Pirgi e altri testi etruschi tradotti e commentati, Sassari 2000, capo 8).
Anche il Facchetti ha abboccato appieno alla “favola” di quello che sarebbe un caso morfologico nuovo della lingua etrusca, chiamato dal suo inventore “pertinentivo”. Ma si tratta di un caso morfologico per il quale costui ha presentato rarissimi e incertissimi esempi, dispersi ampiamente nel tempo e nello spazio e soprattutto non caratterizzati da morfemi chiari e distinti. Con la sua nuova trovata l’inventore da una parte ha voluto attribuire al “pertinentivo” complementi morfosintattici che si inquadravano alla perfezione già nell’ablativo, dall’altra ha voluto eliminare del tutto il caso dativo. Questo invece esiste realmente, caratterizzato dai morfemi -i come dativo asigmatico e –si come dativo sigmatico: dativo asigmatico: Aritimi (Aritim-i) «a/per Artemide», śpureri(śpur-er-i)«alle/per le città»; dativo sigmatico Avilesi (Avile-si) «a/da/per Aulo»; apasi (apa-si) «al/del padre» (in dativo di appartenenza); Atranesi (Atrane-si) «(fabbricato) da Atrano» (in dativo di agente); asigmatico e sigmatico: Aχlei Truiesi (Aχle-i Truie-si) «a/per Achille Troiano» (il Facchetti invece ha tradotto «nell’Achille di Troia»!).
Ne è derivata tutta una grande confusione, quella che risulta documentata anche dallo schema della “declinazione etrusca” presentata dal Facchetti nelle pagine 11-12 e spiegata nelle seguenti: non se ne capisce nulla!
Esempi: a pagina 13 il Facchetti scrive di aver individuato per la prima volta la costruzione del “doppio locativo”, col possibile significato di “tra … e …”. A pagina 15 egli scrive: «Il pertinentivo è, in realtà, un esempio del carattere agglutinante dell’etrusco: si tratta, morfologicamente parlando, del “locativo del genitivo”! Ma di grazia – chiedo io – cosa significano mai “doppio locativo” e “locativo del genitivo”? Queste due non sono altro che frasi prive di senso!
Più avanti egli scrive: «Etr. Avile-s-i significa letteralmente “in (quello) di Avile”, “nell(àmbito) di Avile”; dunque una frase come mi mulu Avilesi (“io (sono) donato nell'(àmbito) di Avile” va disambiguata dal contesto linguistico e materiale. Perché Avilesi può indicare, per esempio, sia il donante che il donatario». Ma – obietto io – come è pensabile che gli Etruschi parlassero in codesto modo del tutto ambiguo? Forse che essi non facevano altro che esprimersi con frasi sibilline, cioè aventi più significati anche contrastanti? In realtà quella che certamente era una ambiguità propriamente linguistica, sul piano del contesto “fattuale” o linguistico-pragmatico era invece del tutto chiara: si vedeva o si sapeva dai fatti se Avile era il donatore oppure il donatario dell’oggetto donato.
Anche il Facchetti cade nell’errore di enfatizzare troppo il fenomeno della agglutinazione esistente nella lingua etrusca, dato che fenomeni di agglutinazione, anche se sporadici, si constatano pure in molte altre lingue, ad esempio pure nell’italiano: andiamocene! (and-iamo-ce-ne!); vàttene! (va-tte-ne!), diciamocelo! (dic-iamo-ce-lo!), diteglielo! (di-te-glie-lo!); infischiandocene (infischia-ndo-ce-ne); prendendocele (prende-ndo-ce-le).
In ogni modo Avilesi non è affatto un esempio di agglutinazione, ma è solamente un prenome in dativo sigmatico, Avile-si, da intendersi o come dativo di attribuzione «a/per Aulo» oppure come dativo d’agente «da Aulo».
Dietro il fenomeno enfatizzato dell’agglutinazione, esistente – in forma assai ridotta – pure nella lingua etrusca, i suoi fanatici – compreso il Facchetti – procedono a dividere e separare i lessemi come se fossero altrettanti salamini da affettare, con risultati finali non solo privi di valore scientifico, ma francamente umoristici. E sorvolo sul larghissimo uso che il Facchetti fa dell’asterisco per indicare fatti linguistici ipotizzati ma non documentati: così procedendo egli fonda le sue argomentazioni su ipotesi di ipotesi di ipotesi…
Potrei continuare a lungo, ma preferisco chiudere con una considerazione generale, che però non rivolgo solamente al Facchetti: si deve evitare con grande cura di cadere nell’errore di ritenere che il materiale documentario della lingua etrusca conservatoci abbia il carattere e il pregio della piena e assoluta esattezza e genuinità, errore madornale per cui si ritiene di poter procedere alla analisi totale e minuta del corpus etrusco con tutta sicurezza, come se si trattasse delle formule numeriche che risultano, ad esempio, nelle tavole della trigonometria o dei logaritmi. E invece non è affatto così: il corpus linguistico etrusco oscilla nell’ampio ambito di ben otto secoli, nell’ambito di uno spazio immenso, che va da Pontecagnano a Capua, a Caere, Chiusi, Cortona, Bologna sino a Spina, Adria e Feltre, da Piacenza a Genova, a Marsiglia, in Corsica, in Sardegna e perfino a Cartagine. Inoltre è del tutto certo che esso è stato scritto da numerosissimi scribi, alcuni certamente forniti di sufficiente capacità di linguaggio e di cultura, altri invece dotati di scarse conoscenze di lingua e di ortografia, tanto che non poche iscrizioni mostrano evidenti segni di errori di lingua e di scrittura. Infine è un fatto, un fatto ovviamente deprecato, che moltissime iscrizioni etrusche hanno subìto, per l’ingiuria del tempo e degli eventi, numerosi e gravi danni che ne hanno pregiudicato gravemente e per sempre la lettura, la traduzione e la semplice interpretazione. Si deve infine evitare con cura di trarre conclusioni morfologiche e semantiche dai numerosi vocaboli documentati una sola volta che incontriamo nel corpus (gli hapax legómena), perché anche questi possono essere il frutto di errori di scrittura e di lingua.
Per tutte queste ragioni negative, singole o collettive, le analisi minutissime e puntuali che troppi cultori della lingua etrusca fanno nei loro scritti sono del tutto aleatorie e spesso del tutto campate in aria. Questa mia considerazione generale non costituisce affatto il suono della campana a morte per lo studio della lingua etrusca, ma costituisce solamente un invito ad essere molto più prudenti nelle nostre analisi, intepretazioni e traduzioni.
Massimo Pittau