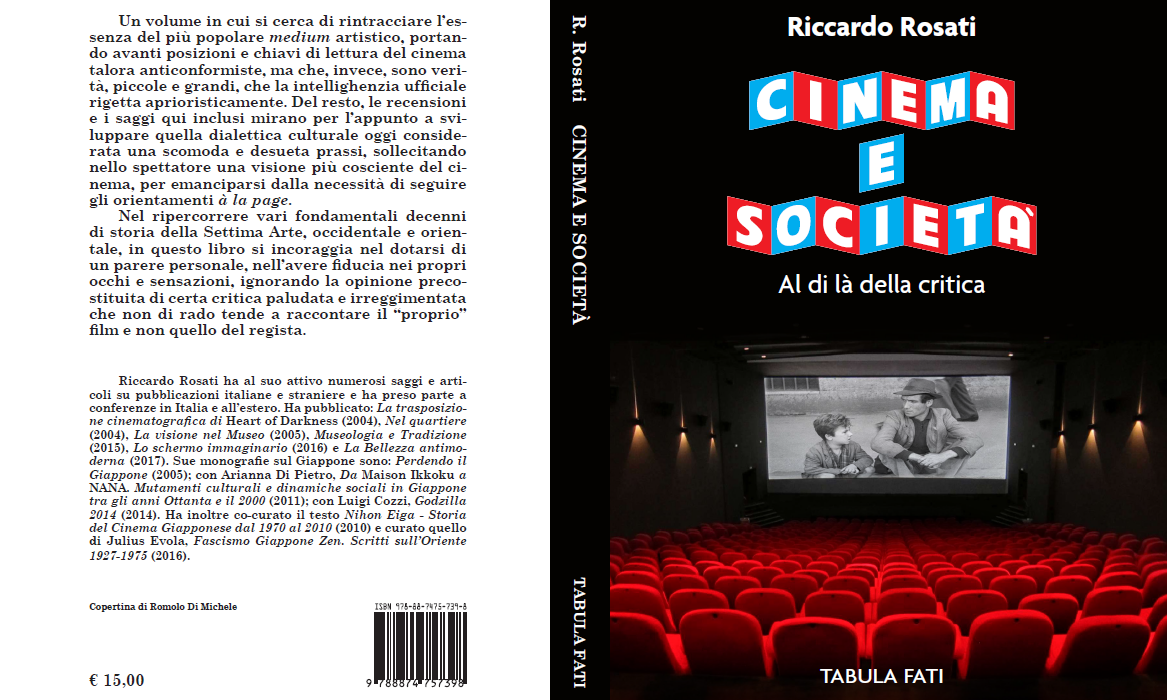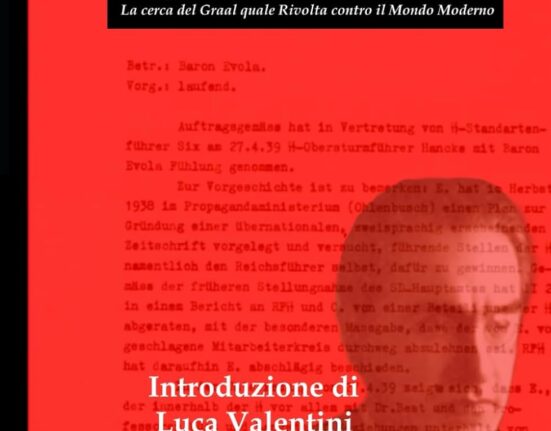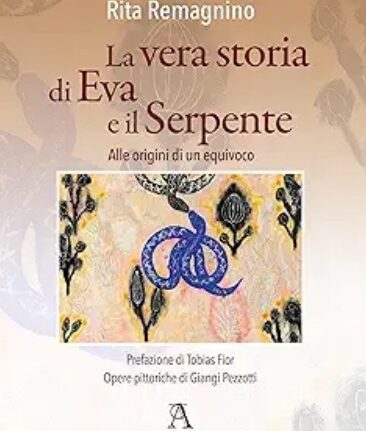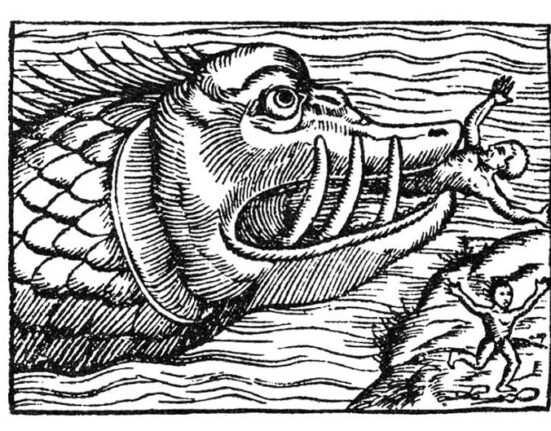Nell’introduzione al suo prezioso volume Cinema e Società (Tabula Fati, 2020) il critico cinematografico Riccardo Rosati – producendo l’esempio di un saggio di Mario Praz (1896 – 1982) – ci informa con sintesi e precisione qual è l’obbiettivo del suo lavoro, ideale continuazione e complemento di una sua precedente opera, Lo schermo immaginario (Tabula Fati, 2016): definire una compiuta “idea di cinema”, agganciandosi alla “disciplina della comparatistica” in critica letteraria (Praz). “Idea di cinema” come “idea politica”? Anche. Infatti, chiudendo l’introduzione, Rosati spiega:
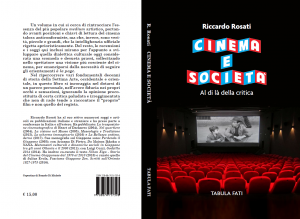
Ci auguriamo che i nostri pensieri eterodossi possano almeno incoraggiare a considerare la Settima Arte quale un medium comunicativo aperto a tutti, e non un semplice feudo della critica specializzata, che detta canoni perlopiù non condivisi dal pubblico. Da qui, la scelta del titolo: “Cinema e Società”, con entrambi i sostantivi che lo compongono con la lettera iniziale maiuscola. Perché? Semplice, poiché la società ha costantemente influenzato il cinema, e quest’ultimo ne ha puntualmente rappresentato ogni singola sfaccettatura. Per parlare di un film, differentemente che per un quadro o un romanzo, sono sufficienti gli occhi e tanta sana curiosità. Forse è questo l’unico messaggio “politico” presente nel volume, il pensare con la propria testa, visto che se una pellicola appartiene al pubblico, allora anche una Nazione è della sua Popolazione; lo spettatore in sala o l’elettore che si reca al voto deve ricordarsi che ha delle precipue responsabilità: sapere giudicare e avere una opinione.
Il libro prosegue con recensioni di film e saggi più lunghi su pellicole e registi collegati all’Oriente, aprendosi con il capitolo intitolato Cinema mimetico, dedicato – più o meno – alla cinematografia non “di genere”; diciamo “più o meno”, perché lo stesso Rosati aveva chiarito la questione nell’introduzione:
Crediamo, infatti, che non esista il cosiddetto “genere” nettamente distinto da quello che tecnicamente si chiama “cinema mimetico”, poiché il modo di analizzare un film da parte di uno studioso avveduto deve essere coerente, non influenzato dalla tipologia di opera che sta affrontando in quel determinato momento.

Le schede delle recensioni – ordinate cronologicamente seguendo le date d’uscita dei film – si muovono lungo un notevole arco temporale e Rosati sceglie indifferentemente (ma volutamente) pellicole di successo al botteghino e titoli meno noti, italiani e internazionali. Il suo interesse principale è infatti quello di rintracciare fra le righe narrative dei film analizzati, tracce della società contemporanea “reale”; non tralasciando ovviamente il momento “tecnico/analitico” su soggetto, sceneggiatura, regia, recitazione, luci, inquadrature, movimento della telecamera, montaggio, etc. Il primo film recensito è Scipione detto anche l’Africano (Magni – Italia, 1971); Rosati vi vede un riflesso della Roma e dell’Italia contemporanee:
Il film non è solo una acuta riflessione sugli inguaribili mali della politica, ma mette specialmente alla berlina il millenario dualismo di una città divisa tra la sua naturale vocazione universale di capitale del mondo e il suo essere gretta, provinciale e pressapochista.
Nel film di Magni la tragedia della politica corrotta viene brillantemente mascherata con i toni brillanti della commedia. Nella scena del processo – intentato contro Scipione l’Asiatico e Scipione l’Africano accusati di essersi intascati parte dei soldi destinati alle già ingenti spese di guerra e di vettovagliamento dei militi – l’Asiatico (Ruggero Mastroianni), rivolgendosi a Catone il Censore (Vittorio Gassman) dice, in romanesco:
Er sordato in guera, pensa solo a magnà. Magna e more. E tu, di fronte allo spettro della morte, je stai a lesinà er magnà?
E Catone risponde:
Eh, ma… ma il fatto è che voi avete seguitato a magnà pure dopo che lo spettro della morte s’era dileguato…
Al che l’Asiatico ribatte, con ampio gesto del braccio e largo parlare:
Ma intanto la Pace Romana stenneva l’ala su tutta la Siria! A Catò… E pure ‘ste cose contano. Er leggionario magna… la civiltà cammina.

Allo stesso modo (cinema=società) viene letto The Believer (Bean – USA, 2001), film incentrato sulla figura di Daniel Burros, ebreo americano e allo stesso momento attivista nazionalsocialista, emblema di un’America sicuramente schizofrenica. Rosati inaugura la recensione con una riflessione su un celeberrimo pamphlet politico:
“I Protocolli dei Savi di Sion”, apparsi all’inizio del secolo scorso, sono stati oggetto di vari studi e critiche, e sono ormai chiaramente giudicati un falso in chiave antisemita, redatto dalla polizia segreta russa tra il 1903 e il 1905. Ciò malgrado, il punto non è questo, ovvero quello della non autenticità di tali scritti, bensì un altro: seppur falsi, alcune delle teorie in essi contenute sono da considerarsi plausibili? Inoltre, tali teorie si sono poi attuate nel tempo e hanno una qualche logica di base nello scenario politico internazionale? Piuttosto che subire sempre la “fobia antisemita”, la quale impedisce oggi di censurare qualsiasi ebreo che possa addirittura aver commesso dei reati, senza venir immancabilmente bollati come filonazisti — pensiamo all’entourage di Dominique Strauss-Kahn che ha accusato Abel Ferrara, per il suo film “Welcome to New York” (2004), ispirato alle note vicende dell’uomo d’affari francese di religione ebraica, di essere, per l’appunto, antisemita – dovremmo ragionare su alcune evidenti influenze della finanza e intellighenzia ebraiche sul mondo occidentale. Ci sarebbe altresì la necessità di fare dei distinguo tra “antisemitismo” e “antisionismo”, che non sono affatto la stessa cosa.
È la stessa tesi esposta nel 1937 da Julius Evola nell’introduzione al volume I “Protocolli” dei “Savi Anziani” di Sion (Baldini & Castoldi e “La Vita Italiana”), ristampato in Italia da Giovanni Preziosi dopo che lo aveva pubblicato per la prima volta sedici anni prima:
Quand’anche (cioè: dato e non concesso) i “Protocolli” non fossero “autentici” nel senso più ristretto, è come se essi lo fossero, per due ragioni capitali e decisive: 1) Perché i fatti ne dimostrano la verità; 2) Perché la loro corrispondenza con le idee-madre dell’Ebraismo tradizionale e moderno è incontestabile.
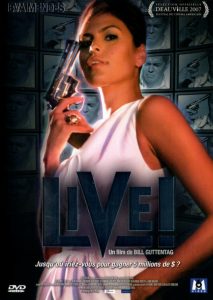
Ecco dunque come il cinema, l’analisi del cinema dei giorni nostri ci permette di spaziare in argomenti provenienti da mondi apparentemente lontani. L’America, per esempio, è ancora il “faro della civiltà occidentale”? Una risposta ci viene dalla recensione di Live! (Guttentag – USA, 2007), una parodia “nera” del mondo della televisione e dei reality show:
Un altro aspetto importante affrontato nel film è quello legato al mondo dietro alla macchina da presa. Ovvero, quell’ambiente meschino popolato di autori senza un briciolo di cultura, avvocati arrivisti e dirigenti sprovvisti di coscienza. Di conseguenza, Guttentag ci rivela l’autentico spirito americano di oggi: un popolo malato di adrenalina e ossessionato dal successo. Si ridicolizza quel Paese che, all’indomani di due rovinose guerre che avevano messo in ginocchio il mondo intero, poteva forse incarnare quei valori di progresso e speranza che i nostri nonni ricercavano in una società nuova. Tuttavia, l’America odierna è ben diversa da quella degli anni Cinquanta e Sessanta. Non che noi europei abbiamo il diritto di sentirci migliori, visto che da decenni seguiamo, e talvolta persino anticipiamo, le degenerazioni di marca statunitense.
Rosati torna di nuovo a occuparsi del Belpaese, con la scheda che racconta Et in Terra pax (Botrugno e Coluccini – Italia, 2010), una pellicola ambientata a Roma nel “degrado delle periferie”, degrado umano e architettonico:
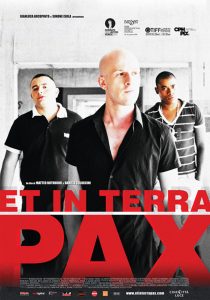
I protagonisti ritratti nel film, più che colpevoli, sembrano vittime predestinate, condannate a priori dal degrado in cui sono costrette a vivere, in una società fintamente multiculturale — multietnica, questo sì — dove la globalizzazione ha tramutato l’individuo in consumatore, con un unico diritto/dovere: acquistare! Una fotografia di discreto livello si concentra in più occasioni in modo intelligente sulle architetture, vere “responsabili” del disagio in cui vivono oggi molte persone, non soltanto in Italia. Da “Et in terra pax” si evince l’ovvio, almeno per coloro che hanno il coraggio e la capacità di pensare con la propria testa, dunque lontani da una ideologia da difendere a ogni costo, in nome di un confuso, quanto inattuabile, progetto per un mondo migliore. Inoltre, è ormai acclarato il totale fallimento della architettura modernista di stampo socialista, da Le Corbusier, passando per le Vele di Scampia allo Zen di Palermo, giungendo infine al “Serpentone” di Corviale, dove è ambientato il film. Questi enormi palazzi, nati per imporre e non incoraggiare la socializzazione, sono diventati non-luoghi immersi nel degrado, ingestibili, per via di una manutenzione difficilissima. Gigantesche isole di cemento, senza storia né un legame con la cultura architettonica della città che le ospita. Questo modo di fare architettura è considerato da tempo non solo come parte del modernismo, ma anche il frutto di una visione distorta della società, concretizzatasi, appunto, sul piano urbanistico.
Il film Starbuck (Scott – Canada, 2011), storia di David, un immaturo donatore di sperma che scopre di essere “padre” di oltre 500 bambini nati grazie all’inseminazione artificiale, consente a Rosati di riflettere sul concetto moderno di “famiglia” e sul ruolo di quello che oggi si vorrebbe chiamare, fantascientificamente, “genitore uno”:
La morale che viene qui proposta è forse banale, ma di questi tempi vale la pena ricordarla. L’evoluzione compiuta da David, da irresponsabile perdigiorno, a padre amorevole, è dovuta a una semplice, quanto inconfutabile verità: le responsabilità fanno bene! Ormai siamo tristemente abituati a dei quarantenni con la camicia fuori dai pantaloni, tatuati, perennemente abbronzati e in cerca di ragazzine. Uomini che dovrebbero essere dei padri di famiglia, quindi il pilastro delle nostre società; tuttavia, anziché costruire il futuro, costoro buttano il tempo sui “social media” o in palestra per farsi la “tartaruga”, sperando così di coprire quella pancetta che avanza inesorabilmente con l’età. Bambinoni assai immaturi, spavaldi nei modi, ma insicuri dentro. Ciononostante, la riflessione più utile che ci suggerisce questa storia è un’altra, ovvero la fondamentale importanza della paternità: oggi molte donne occidentali disconoscono il rilevante ruolo dell’uomo nella famiglia. È assodato come questa nostra società malata veda sempre di più il maschio come una specie di “donatore”; sovente le mogli pensano in segreto: “tanto posso fare a meno di lui, me lo cresco da sola”. L’opera di Ken Scott afferma proprio il contrario. Il protagonista non solo diventa finalmente adulto, grazie al rapporto con i suoi innumerevoli figli, ma scopre, e questa è la cosa sulla quale dovremmo riflettere, di essere un bravissimo genitore e che i suoi figli sono stati capaci di tirare fuori il meglio di lui. Crescere senza un padre, vederlo due volte al mese è devastante per un bambino. David, da “donatore”, compie il cammino inverso da quello che la nostra “società del tangibile” vorrebbe che fosse prassi, cioè una “norma” malvagia, atta a distruggere la famiglia. Senza clamori o battute da mal di pancia, questa pellicola risulta gradevolissima nella sua essenzialità e stigmatizza quasi sottovoce delle situazioni che sono divenute consuetudine e che dovrebbero essere invece delle eccezioni. Se la figura materna è l’amore in senso lato, è altrettanto vero che il padre rappresenta la identità, e come afferma la vecchia suora in quell’importantissimo film che è “La grande bellezza” (2013) di Paolo Sorrentino: “Le radici sono importanti”.

Film citato non a caso perché poi Rosati approfondisce, con una delle recensioni più sentite del suo libro. La grande bellezza (Sorrentino – Italia, 2013) divise a suo tempo il pubblico italiano, fra chi lo vide “perché andava visto” e chi lo vide “perché voleva vederlo”. Il sottoscritto partì sicuramente prevenuto verso questa che – a torto – poteva essere considerata “un’opera di regime” visto il battage della stampa a giornali unificati. Il film fu invece una positiva sorpresa. Il 5 marzo 2014 lo commentai così, con un breve post su Facebook, riflettendo su alcune recensioni giornalistiche:
Mi chiedo come sia possibile parlare di film che “trasmette un messaggio positivo”. Il mondano Gambardella è metafora della morte dello spirito italiano! Bel film, tremendo però! Ci credo che gli abbiano dato l’Oscar: “La grande bellezza” è il manifesto di una nazione in coma – che tanto piace agli speculatori stranieri – da comprare a prezzo di saldo!
Ancora oggi la penso così. Per Rosati – e non solo lui – il film ha creato e continua a creare divisioni e malumori “politici” sia a sinistra, sia a destra:
“In primis”, la sinistra, che si è sentita palesemente attaccata da Sorrentino (coautore, con Umberto Contarrello, anche della sceneggiatura), la quale esterna una malcelata ostilità verso la sua opera, però messa definitivamente a tacere dalla vittoria della ambita statuetta nel 2014 da parte del regista napoletano. Tuttavia, la destra — specialmente quella più volgarotta, “cafonal” direbbero alcuni — da parte sua ha trovato “La grande bellezza” un film noioso e pedante. In breve cercheremo di analizzare entrambe le reazioni, tipiche di un Paese da tempo lacerato, condannato a un manicheismo di bassa lega, degno davvero della opposizione tra i sostenitori di Bartali e Coppi. Come detto, Sorrentino nel suo film spara a zero sulla sinistra italiana, in particolare sui “radical chic”, autentici parassiti della società. Poteva benissimo ridicolizzare i soliti e ormai satiricamente lisi “berluscones”, invece se la è presa con quelli che noi da anni definiamo i benpensanti del progresso. Lo ha fatto, ad esempio, con la celebre tirata di Jep, atta a demolire lo stereotipo femminista, incarnato qui da una ricca e snob militante progressista. (…) Chiaramente, la sinistra mai gli ha perdonato un attacco frontale di tale portata. Il fatto importante però è un altro, ovvero che il cineasta ha non solo — tramite la tirata del suo protagonista — evidenziato una lapalissiana verità, ma la cosa ben più “grave” è che egli non può certo essere considerato un uomo di destra. Ragion per cui, la sua denuncia diventa ancor più incisiva. Il punto è che, già a partire dal suo film di prossima uscita (“La giovinezza”), Sorrentino in produzioni tutte italiane lo vedremo poco, comprensibilmente disgustato da una critica ottusa e militante. Continuerà a girare sempre più in inglese e ad avvalersi di attori stranieri. Forse farà la fine di un altro nostro grande, Bernardo Bertolucci, che da quando smise di fare cinema “impegnato”, per regalarci capolavori come “L’ultimo imperatore” (1987), venne sistematicamente mal sopportato dai cinéphile gauchiste. Fare dei film dal respiro internazionale, tradendo la Causa? La sinistra non può semplicemente accettarlo. Sul totale disprezzo che la destra ha mostrato per l’opera di Sorrentino non vi è francamente molto da dire. È un male antico, quello della poca cultura in certi ambiti e ce ne dispiace assai, poiché in passato era l’esatto contrario; di destra o semplici conservatori furono quasi tutte le maggiori menti italiane, da Evola a Gentile; da Praz a Tucci, passando per Pirandello. Ciò malgrado, il più noto “speaker” radiofonico romano, appartenente a questa area politica, invece di lodare la critica di Sorrentino verso la sinistra, ha promosso mesi fa una crociata contro “La grande bellezza”, film reo di aver “denigrato” Roma. Costui, che naviga esclusivamente sulle facili idiosincrasie al grido di: “Cor veleno corve”, non solo non ci ha capito proprio nulla della storia narrata da Sorrentino, ma ha persino dimostrato una certa ignoranza, sostenendo pubblicamente che sia meglio vedere le commedie di Checco Zalone, che i film dell’artista napoletano!
Interessante per Rosati anche Il segreto di Italia (Belluco – Italia, 2014), un film sull’eccidio partigiano di Codevigo; secondo il critico, pur non essendo la pellicola un’opera eccelsa (nella scheda parla di “occasione persa”) è già una gran cosa che esca sugli schermi un film dedicato a uno dei tanti massacri dei partigiani. Non occorrerebbe nemmeno dirlo, ma all’epoca Il segreto di Italia fu stroncato (se la presero persino con la recitazione di Romina Power, che interpretava la protagonista Italia da adulta) e pesantemente attaccato dall’ANPI di Padova con queste parole:

Escludiamo che tutte quelle vittime possano essere definite innocenti. Fra i ravennati vi erano molti fascisti che si erano distinti, fino all’arrivo degli Alleati in Romagna – estate 1944 – nel comandare la repressione antipartigiana e nel condurre, a fianco dei nazisti, azioni di rappresaglia contro le popolazioni civili; e i più anziani di loro, nei primi anni Venti, erano stati squadristi in prima fila nel reprimere il movimento dei braccianti e dei contadini di quelle zone. Tutte queste premesse nel racconto di Belluco non esistono, tutto si annega in una melassa qualunquista in cui sono tutti uguali: veneziani, padovani, austriaci, fascisti, tedeschi, comunisti. Come se il paese, Codevigo, non avesse mai conosciuto le sofferenze, le divisioni, le ingiustizie sociali, la repressione.
Dopo la (positiva) recensione di Youth di Sorrentino (2015), che chiude un viaggio di quasi 45 anni nel “cinema mimetico” (non dimenticando alcuni celebri documentari), Rosati sposta il suo occhio sulla cinematografia asiatica (del quale è esperto a livello nazionale), con il capitolo Altre visioni d’Oriente, diviso in due parti: Recensioni e Saggi. Il suo obiettivo è quello di far comprendere meglio agli Occidentali, gli argomenti, i sentimenti, le tradizioni, etc. degli Orientali, puntando l’obiettivo (perdonateci il voluto bisticcio) sulle opere in celluloide maggiormente di rottura, che rappresentano volti meno noti, negativi, squallidi, violenti, incoerenti dei Paesi che le hanno prodotte.
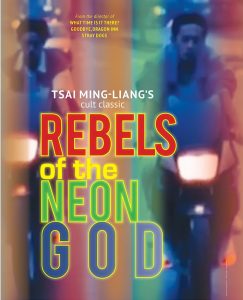
Lo spaccato della ex Formosa che emerge impietosamente da Rebels of the Neon God (Tsai Ming-liang – Taiwan, 1992), con i suoi “giovinastri” deviati, viene abilmente riassunto da Rosati con brevi pennellate:
(…) La presenza immancabile dell’acqua, l’utilizzo dei suoni acusmatici, la colonna sonora come fenomeno indipendente dalla narrazione, lunghi silenzi e dialoghi ridotti all’essenziale. Tutto ciò lo si ritrova in questa pellicola lenta e malinconica, dove siamo testimoni dell’isolamento e “straniamento” culturale della gioventù asiatica. Che sia il Giappone, la Cina o, come per Tsai, Taiwan, lo sfrenato modernismo orientale, che si incarna in megalopoli inumane e rumorose, miete le proprie “vittime” preferibilmente tra i giovani.
Sincera la commozione di Rosati nell’affrontare l’ultima pellicola (film-testamento, forse) del grande maestro Akira Kurosawa (1910 – 1998), Madadayo – Il compleanno (Giappone, 1993):
Intimo, riflessivo, catartico, sono solo alcuni degli aggettivi utilizzabili per questa suggestiva storia, della quale apprezziamo soprattutto un finale tra i più poetici mai usciti dall’estro del regista. Un film che non rappresenta solamente il “saluto” definitivo di Kurosawa alla Settima Arte, ma anche alla vita, nel segno di una elegia su di un Giappone che già all’epoca in cui è ambientata la narrazione guardava con nostalgia alla ingenuità perduta, prepotentemente soppiantata dal progresso. Una pellicola che si attesta quale sincera testimonianza di determinati lati reconditi dell’animo nipponico, di cui questo fondamentale autore, così vicino alla cinematografia occidentale, non è poi stato tra i migliori “cantori”. Eppure, con la sua ultima fatica, Kurosawa tocca con meravigliosa sapienza le corde più segrete del suo Popolo. Proprio alla fine egli è riuscito a riconciliarsi con quella essenzialità che ha reso grande l’arte cinematografica giapponese. Film fatti di pura riflessione, di attese e ricordi, latori di emozioni pacate, quanto assolutamente incisive. Tutto questo lo si ritrova in “Madadayo”, una pellicola che non sarebbe eccessivo definire sublime.

Una delicatezza, quella dell’opera conclusiva di Kurosawa, che non pare invece riscontrarsi nella cinematografia di Takashi Miike, un autore molto ben rappresentato nel volume (con i suoi film di azione e violenza criminale, pieni di omaggi palesi agli “spaghetti western” e a Quentin Tarantino, addirittura chiamato dal regista nipponico a recitare nel suo Sukiyaki Western Django del 2007) che propone, nella sua trilogia dedicata negli anni Novanta e nei primi del Duemila alla Yakuza, un lettura “anti-nipponica” del Giappone, del tutto lontano da quell’immagine perfetta di sé che il Sol Levante vorrebbe proiettare all’esterno. Assenza di valori, delinquenza, droga, corruzione, e altri lati oscuri.
Non è che in Cina siano messi meglio, però… Singolare è infatti il caso di Jiang Hu: Life on the Road (1999) del regista e documentarista Wu Wenguang, che per un anno segue il viaggio itinerante di una rustica e scalcinata compagnia teatrale la quale, montando il tendone nelle non propriamente bucoliche periferie di città e metropoli, organizza spettacoli a metà strada fra il cabaret, il concerto pop, il balletto e il circo – dove non mancano anche giovani signorine esibirsi in mutandine e reggiseno sul palco (che vengono in parte reclutate “alla buona” fra le ragazzine più carine presenti fra il pubblico nelle varie tappe): sigarette perennemente in bocca, pasti consumati con mani luride accoccolati per terra fra polvere e immondizia, igiene inesistente, attori che dormono su stuoie e materassi gettati dove capita e viaggiano stipati su camion come bestiame, corruzione negli uffici pubblici che devono dare l’autorizzazione allo spettacolo, perenne confusione e gazzarra, disordine e caos, etc. A un certo punto il boss dello show, un maneggione gigantesco, è ripreso mentre mangia una mela, ma prima giustamente la sbuccia… usando gli incisivi come un castoro e sputando le bucce per strada. Sembra quasi di stare a Prato, la città dove vive il sottoscritto. Ma leggiamo il Rosati:

Il documentario ricerca la realtà, senza la minima pretesa di una qualche formale composizione filmica. Vi si mostra la crudezza della situazione, non badando a logiche narrative. Non esistono un vero inizio e fine della storia, abbiamo perciò a che fare con la più perfetta tranche de vie che si possa immaginare. Preziosissima è inoltre la rappresentazione di taluni costumi “intimi” dei cinesi, con i loro sputi, gargarismi e modi che a noi risultano orripilanti, ma che dovremmo invece interpretare come una particolare forma di socializzazione propria di una ben più ricca civiltà ultramillenaria. Tuttavia, l’elemento caratterizzante che si manifesta con assoluta chiarezza in Jiang Hu è la completa assenza di una sfera privata nella quotidianità dei cinesi. Costoro sono capaci di vivere con nulla o quasi, al freddo e con una igiene che farebbe rabbrividire la maggior parte degli occidentali e il tutto in comunione con gli altri, condividendo la stessa tenda, come a voler ribadire la vecchia idea che il circo altro non è che una delle più ciniche e forti metafore della esistenza. Questo documentario chiarisce altresì quanto la proverbiale chiassosità dei cinesi sia alla fine un modo tutto loro per “stare insieme”, come lo è del resto lo spartirsi le pietanze su dei tavoli che al termine del pasto sembrano spesso lo scenario di una qualche forma di naumachia culinaria. Pare proprio che gran parte della loro cultura popolare aspiri ad abbattere qualsivoglia filtro affettivo, onde creare un forte senso comunitario.
Rosati non manca di compiere una rapida incursione nel subcontinente indiano. My Name is Khan (Karan Johar – India, 2010), racconta la storia di Rizwan Khan, musulmano autistico di Bombai emigrato da ragazzo in America. La situazione è molto meno semplice di quello che può sembrare e molti spunti invitano a più ponderata riflessione: l’11 settembre arriva su quelle comunità come un’onda in piena, facendole debordare dal tanto decantato melting pot, travolgendo tutto in uno tsunami di dubbi e incomprensioni:
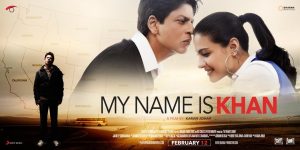
Molti converranno che il problema di fondo di Bollywood stia nella inabilità di raccontare la realtà. Con “My Name is Khan” questo postulato viene, almeno in parte, scalfito. Sebbene la “Mecca” del cinema indiano persista in una produzione di puro intrattenimento, con una continua rappresentazione estetizzante e patinata del mondo, per converso, la pellicola di Karan Johar osserva e riflette sulla società di oggi. Difatti, il film ci suggerisce considerazioni utili sul modo di vivere degli “altri”, ed è irrilevante se questa alterità sia dovuta alla religione o a un handicap mentale, e conta ancora meno il fatto che tutto questo avvenga attraverso una narrazione fluviale, al cui centro vi è il dramma di un uomo talmente buono, da risultare forse poco credibile. Nel rivendicare il proprio nome e la sua onestà, Rizwan Khan ci insegna a non tirarci indietro nell’attestare la nostra unicità, per quanto piccola possa essere, nella fredda omologazione del “villaggio globale”.
Le Recensioni terminano con Little Sister, un film giapponese del 2015. I Saggi del capitolo dedicato all’Oriente si aprono con una disamina di Lost in Translation, diretto nel 2003 da Sofia Coppola, una pellicola americana ambientata a Tokyo che, secondo Rosati, risente troppo del pregiudizio occidentale che tende a dipingere il Giappone (e in fin dei conti l’intero Oriente) a colpi di stereotipi “turistici” preconfezionati, per cui le città sono sempre “giungle di grattacieli”, le folle sono disumanizzate, l’unico divertimento è il “karaoke”, la cultura e la lingua (aliene) creano barriere insormontabili che costringono lo “straniero” a isolarsi, etc. Ma Rosati vede un barlume di luce in fondo al tunnel:
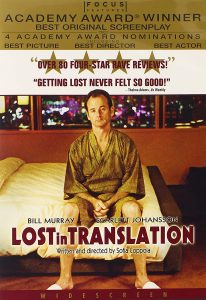
Ciononostante, non sarebbe giusto rifiutare “in toto” l’affresco che la pellicola fa del Giappone, come se fosse tutta una “bugia romanzata”. Effettivamente, in determinati contesti sociali, Tôkyô può diventare assai banale. Tenteremo, seppur brevemente, di spiegare cosa intendiamo con questo termine. L’ambiente che descrive la Coppola è quello degli stranieri, solitamente benestanti e dai gusti alto borghesi, i quali, nella enorme metropoli nipponica, fanno spesso comunità a sé, isolandosi e attestandosi in tal modo come un elemento allogeno. Se poi estendiamo questa situazione agli anglosassoni che si trovano di passaggio oppure vivono a Tôkyô, questo isolamento diventa perfino più radicale. Ciò è dovuto in buona parte al problema della barriera linguistica: imparare così bene il giapponese tanto da intrattenere rapporti interpersonali non è certo roba da poco e necessita di svariati anni di attenta pratica; inoltre, spesso chi è di madrelingua inglese “pretende” che tutti parlino abbastanza correntemente questa lingua, cosa che non è così usuale in Giappone, dove la conoscenza dell’inglese non è ancora totalmente diffusa e sostanziali problemi fonetici, insieme all’utilizzo di molte storpiature di parole inglesi, solitamente ne rallentano l’apprendimento. Dunque, possiamo affermare che molti anglosassoni a Tôkyô si comportano come i due protagonisti. Ragion per cui, se è pur lecito stigmatizzare il film della Coppola per lo scarsissimo interesse che in esso si dimostra verso la cultura giapponese, è altrettanto vero che questa pellicola rappresenta un preciso resoconto di come alcuni stranieri vivano e percepiscano il Giappone, essendone una parte passiva e scarsamente integrata. Il film incarna, quindi, la visione di un turista snob, che vive una esperienza probabilmente molto simile a quella della stessa Coppola in terra giapponese. Tôkyô è forse l’unica città del Paese che permetta, grazie alla sua vastità e alla mancanza di un centro, una vita in cui lo straniero possa in qualche modo esistere senza incrociare così spesso la quotidianità della società che lo ospita. Tale è, infatti, il Giappone descritto dalla regista americana: grandi e lussuosi alberghi, locali esclusivi e quei pochi giapponesi che si incontrano sono imbevuti di Occidente.
Giappone sicuramente più tradizionale quello raccontato da Yukio Mishima nel mediometraggio Yukoku (Patriottismo), da lui prodotto, diretto e interpretato nel 1966 (basandosi su un racconto preesistente); sono gli ultimi momenti di vita del tenente Takeyama e di sua moglie Reiko, che si tolgono la vita con il suicidio rituale giapponese (a Takeyama era stato ordinato di uccidere i suoi commilitoni ribelli, rei di aver tentato un colpo di stato nel 1936, ma lui disobbedisce in maniera del tutto onorevole). Si tratta di un film carico di sensualità (la terza parte vede i due attori e unici protagonisti, Mishima e Tsuruoka, nudi nell’atto d’amore) e di suggestioni gore e splatter (la scena del suicidio è crudamente rappresentata); impossibile, infine, non vedere Yukoku come una prefigurazione, una profezia, una premonizione del vero seppuku di Mishima (25 novembre 1970). La pellicola, dopo la morte di Mishima, era stata data per perduta perché la moglie dello scrittore aveva voluto che tutte le copie fossero distrutte; solo nel 2005 è stato casualmente ritrovato l’originale. Secondo Rosati:

“Yûkoku” è un film che andrebbe studiato, andando oltre la sua superficiale patina politica, per poter meglio apprezzare l’universo artistico e culturale di un autore in cui estetica e vita sono indissolubilmente legate. Difatti, la tesi che verrà sostenuta in questo scritto è la seguente: l’accostamento della vita e delle opere di Mishima a una matrice di stampo principalmente politico, per quanto concerne gli ultimi dieci anni della sua esistenza, è limitante, giacché così si rischia di adombrare quella che è, secondo noi, la vera essenza di questo scrittore e del suo lavoro, ovvero una continua ricerca del “gesto estetico” volto a ridare ordine e morale al Giappone moderno. “Gesto” salvifico dunque che, però, proprio in uno stile esistenziale talvolta eccessivo simile a quello di Oscar Wilde, viene quasi sempre celato sotto la provocazione. Sembra che lo stesso Mishima, come leggiamo in queste sue parole cariche di sincera emozione, ambisse a voler essere frainteso da coloro che egli reputava ormai troppo corrotti per comprenderlo: “Un lettore attento coglierà in questo mio scritto l’eco delle mie esperienze, dei miei aneliti, delle mie angosce, delle mie passioni, delle mie confessioni e dei miei presagi. E un giorno comprenderà forse le mie metafore e dirà: ‘Ah, era questo che intendeva!’” (…) L’attivismo nazionalista è chiaramente anch’esso presente in Patriottismo, che tuttavia non può essere considerato come l’aspetto cardine dell’opera. Invero, la interpretazione che qui si intende dare della figura pubblica di Mishima, nonché della sua battaglia politica, è in parte distante dalla idea che la critica e l’opinione diffusa hanno in Italia di questo autore. Sarebbe a dire, che invece di leggere gli ultimi dieci anni della sua vita come frutto di un acceso nazionalismo, si preferisce qui contestualizzare il patriottismo di Mishima all’interno di un più complesso ragionamento estetico, che egli applica alla vita, vista come una autentica battaglia morale: “Reiko sentiva che finalmente avrebbe potuto assaporare la dolcezza e l’amarezza del grande principio morale in cui il marito credeva”. Lo scrittore giapponese auspicava infatti che, glorificando il martirio di Takeyama, egli avrebbe potuto scuotere in qualche modo l’animo dei figli di quel Giappone devastato dalla guerra e che lui stesso considerava “corrotto”, ormai lontanissimo dallo spirito del “Nihonno kokoro” (riscoperta delle antiche virtù tradizionali). Ragion per cui, è probabile che Mishima abbia giudicato utile riproporre la sua storia per mezzo di un “medium” di grande efficacia qual è il cinema, aggiungendovi per giunta un altro inconfondibile elemento identitario per tutto il popolo dell’Arcipelago, ovvero il Nô, col suo chiaro retaggio shintoista. (…) Mishima non ha mai nascosto come per lui la morte fosse un “grande principio morale”, ricollegandosi così a un ideale secondo cui il momento della fine di un essere umano è finanche più importante di ciò che ha fatto in vita. Egli auspicava che questa morale del sacrificio fosse ripresa dalla società giapponese dell’epoca; in essa poi si racchiude il senso profondo degli ultimi dieci anni di vita di Mishima. Coloro che intravidero in lui solo un ultranazionalista e un intellettuale reazionario caddero nella trappola che Mishima stesso aveva teso a osservatori sbrigativi e pieni di pregiudizi. Solo andando oltre la fitta patina di provocazioni e contraddizioni di cui è rivestito il suo pensiero è possibile leggere una poetica intrisa di estetica, tanto da fondere assieme bellezza e giustizia, in una prospettiva, ci arrischiamo a sostenere, persino neoplatonica.

Dopo Mishima Rosati si occupa del regista giapponese Shoei Imamura, scomparso ottantenne nel 2006, un altro protagonista della cinepresa critico e non “facile da maneggiare”:
Imamura ha creato caricature iperboliche, le quali si attestano come incisive allegorie delle turbolenti condizioni sociali di una Nazione fragile e dal futuro incerto. Il cammino del Giappone verso la democratizzazione è diventato sempre più cinico, concedendo ampi margini d’azione a personaggi senza scrupoli e dediti all’opportunismo economico. Questa è in fondo la inarrestabile marea della modernizzazione/occidentalizzazione e — ancor peggio — della spersonalizzazione tipica dell’era globale, dove si espande convulsamente una cultura frammentata e votata a un gusto pop per la imitazione e il consumo di massa. Il cinema di Imamura riflette perciò il forte sentimento di spaesamento del suo Popolo, attraverso un linguaggio narrativo discontinuo, in cui regnano ellissi e inquadrature con la macchina da presa fuori asse.
Il terzo regista giapponese affrontato da Rosati nei Saggi è Nagisa Oshima (1932 – 2013), noto a livello popolare in Occidente per Ecco l’impero dei sensi (1976) e soprattutto per Furyo (1983), dove recitava anche David Bowie. Segue un intervento sull’animazione nipponica dedicata allo sport (serie tv “Tommy, la stella dei Giants” e “Rocky Joe”), che chiude il capitolo e l’intero corpo centrale del libro.
Nella Postfazione Francesco Santarelli ci offre una sua interpretazione del volume di Rosati:
Rosati non è uno “spettatore”. Non si fa raccontare dai film, impassibile, la realtà. Non si accontenta della mera fruizione. Nei suoi saggi e nelle sue recensioni, mai banali, penetra nel tessuto profondo di questa modernissima Arte per portarne alla luce alcune verità, innanzitutto, ma non solo, relative al rapporto mimetico della Tecnica con la Storia. Dal cinema mimetico al cinema orientale, tuttavia, e benché non si tratti di un testo unitario, nei vari “frammenti” di cui si compone l’Opera si coglie un filo conduttore, limpidamente illustrato dall’Autore nella sua Introduzione: la volontà di far “pensare con la propria testa” il lettore. Rosati è molto distante dalla figura del critico moderno. A ben vedere, infatti, non vi è mai in lui la imposizione di un punto di vista. Ma vi è profonda conoscenza, questa sì, necessaria a guidare chi specialista non è, senza però pilotarlo. Indica la strada, senza imporre una meta.
Nella Appendice leggiamo con estremo interesse e comunanza di sentire Zardoz ovvero il fardello dell’immortalità di Stefano Coccia, un saggio breve su quella straordinaria pellicola di John Boorman del 1974 che il sottoscritto vide per la prima volta su RAI 3 nel 1981, inserita nella programmazione serale “Schegge di futuro” curata da Enrico Ghezzi. Ci congediamo lasciando parlare Coccia:

Ma come osserveremo andando avanti, nel cinema di Boorman (Un tranquillo weekend di paura, Excalibur, La foresta di smeraldo) il confronto serrato tra Eros e Thanatos ed il sempre problematico dialogo tra Uomo e Natura sono destinati quasi sempre a risolversi con la sconfitta della superbia umana, con il ripristino dell’ordine naturale. Ed è così che nell’universo distopico di Zardoz, apparentemente immortale, invincibile, ma votato in cuor suo ad implodere, il “bruto” Zed porterà l’unica rivoluzione possibile: la Morte. Un modo come un altro per ricordare, in compagnia delle figure iniziatiche splendidamente interpretate da Sean Connery e Charlotte Rampling, quanto possa essere noiosa, disumana e avvilente l’immortalità, se svincolata artificialmente dal flusso naturale degli eventi. Ecco, affrontare siffatte tematiche quale corollario dei brillanti scritti di Rosati su politica e società potrebbe essere difficilmente spiegabile, quasi un volo pindarico o una sterile provocazione, se tale provocazione non la si ancorasse invece a una lapidaria ma difficilmente equivocabile considerazione: anche il cinema fantastico, in particolare la science fiction così in voga nei periodi di crisi, può dirci molto sulle tensioni ideologiche e sociali che caratterizzano la realtà in cui viene prodotto, su quella cornice antropologica cui si allude più o meno obliquamente. E riguardo a questo pensiamo che Rosati, autore di un altro testo ardito e penetrante nelle analisi come Lo schermo immaginario, potrà senz’altro concordare. Sta di fatto che la realizzazione di Zardoz va a collocarsi nel 1974, ovvero a metà di un decennio che per la storia occidentale appare particolarmente ricco di contrasti ideologici, di ansie riguardanti il futuro, di scenari interni complicati e di contese tra blocchi contrapposti assai rischiose a livello internazionale. Un mood talmente cupo e ansiogeno si innestò nelle produzioni cinematografiche dell’epoca in modo alquanto pervicace.
Riccardo Rosati
CINEMA E SOCIETÀ – Al di là della critica
Presentazione di Pier Luigi Manieri
Postfazione di Francesco Santarelli
Appendice di Stefano Coccia
pagg. 176 – € 15,00
collana Maschera e Volto n. 22
Tabula Fati, gennaio 2020
Francesco G. Manetti