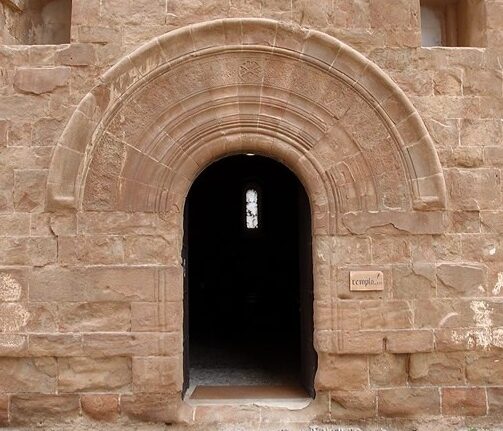I. Natura del linguaggio angelico e umano nel De Vulgari Eloquentia
Nel De Vulgari Eloquentia, Dante propone una compiuta riflessione su ciò che il dono della lingua ha rappresentato fin dalle più lontane origini e quali sono le sue principali caratteristiche in quanto veicolo della rivelazione divina e del pensiero umano. Inizialmente, il poeta della Commedia delinea una generale distinzione tra lingua naturalis, ovvero lingua nativa, e lingua artificialis, e cioè la fredda lingua dei manuali, per riconoscere alla prima una maggiore nobiltà e spontaneità in quanto più antica e radicata nella cultura di ogni parlante[1].
Dopo la lingua umana, Dante si occupa di un ulteriore e più etereo processo comunicativo ovvero il dispiegamento degli intelletti angelici. «Ora gli angeli», scrive Dante, «per effondere i loro pensieri glorificanti possiedono una prontissima e ineffabile capacità intellettuale, in virtù della quale ciascuno si fa compiutamente palese all’altro con la sua sola esistenza, o meglio attraverso quello specchio splendentissimo in cui tutti si riflettono nel pieno della loro bellezza e si rispecchiano con tutto l’ardore del loro desiderio: è dunque evidente che essi non avevano bisogno di alcun segno linguistico»[2].
Tutto ciò prepara una teoria ben precisa sulle origini ultraterrene del linguaggio; una teoria legata innanzi tutto a quell’idioma adamitico che si è poi tramandato nelle forme dell’ebraico biblico[3] e che costituì la sopravvivenza del linguaggio archetipico alla maledizione della Torre di Babele[4]. Secondo Dante, infatti, «In questa forma di linguaggio parlò Adamo; in questa parlarono tutti i suoi posteri fino alla costruzione della torre di Babele – che viene interpretata come torre della confusione; questa forma di linguaggio fu quella che ereditarono i figli di Eber, che da lui furono chiamati Ebrei. Ad essi soli rimase dopo la confusione, affinché il nostro Redentore, che per il lato umano della sua natura doveva nascere da loro, fruisse non di una lingua della confusione, ma di una lingua di grazia»[5].
Questo passo del De Vulgari Eloquentia affronta in maniera decisa e deliberata una questione molto problematica: quella dell’ebraico quale lingua al contempo sacra e messianica. La predilezione di Dante per l’ebraico non è d’altronde dettata né da una preferenza personale né da considerazioni puramente storiche, ma è ben radicata in un preciso ordine di idee che, come accadeva spesso nel Medioevo, vede in ogni accadimento di rilievo un adempimento delle profezie bibliche, come dimostrato dall’opera di San Bernardo di Chiaravalle e di Gioacchino da Fiore, personalità che Dante annoverò tra le sue guide principali[6].
Il De Vulgari Eloquentia concepisce la storia della lingua divina e umana come polarizzata su due estremi ben distinti: da un lato, quella lingua espressiva del puro soffio primordiale che l’Adamo edenico, che sarà poi messianico, riceve come un dono a lui riservato e, dall’altro lato, quel caos babelico la cui cifra principale sarà la confusione dei codici comunicativi[7].
Proprio tra questi due estremi, Dante innesta la ricerca della lingua illustre.
Nonostante le parlate regionali italiane siano anch’esse delle lingue della confusione, e pertanto condannate per inerzia a dar vita ad altre lingue della confusione, il poeta fiorentino intraprende un vero e proprio processo di sublimazione linguistica che nel corso del De Vulgari Eloquentia viene variamente definito per mezzo di incisive metafore: una è quella del lavoro di setaccio[8], altra ancora è quella della caccia alla creatura che fa sentire il suo profumo ovunque, ma che non si manifesta in nessun luogo[9]. Non a caso, la tensione discorsiva di gran parte del Primo Libro è incentrata proprio sulla critica dei vernacoli, i quali vengono spesso condannati non solo per ragioni estetiche, ma perché affetti da una pronunciata tendenza al ferino e al turpe che, con la loquela, coinvolge anche la disposizione interiore di chi ne fa uso. Nella concezione dantesca, infatti, la lingua non è semplicemente sostanza fonetica e sonora, ma anche veicolo di influssi immateriali prorompenti dall’anima umana.
Sotto quest’ultimo punto di vista, l’esclusivo linguaggio che Dante si fa carico di coniare è del tutto inseparabile dal raffinamento interiore necessario alla sua comprensione, in quanto le parole sono destinate ad alludere a stati interiori che possono essere intesi solo da chi li prova, per parafrasare un noto verso dello stesso Alighieri; perché, pur non essendo la lingua adamitica, il volgare illustre è anch’esso legato ad un’ispirazione trascendente. Lì dove l’Adamo edenico «parlò immediatamente, non appena fu investito dal soffio della Virtù che dà la vita»[10], anche il volgare illustre è «investito di un magistero e di un potere che lo sollevano in alto, e solleva in alto i suoi con l’onore e la gloria», senza peraltro dimenticare che il termine illustre ha qui un significato ben diverso da quello che ha assunto ai giorni nostri[11].
Il Secondo Libro: un’intuizione
Il Secondo Libro del De Vulgari Eloquentia ha per argomento gli aspetti puramente formali e stilistici legati alla lingua illustre: le caratteristiche fonetiche della poesia, il ritmo, le parole che più si addicono ad una lingua che voglia liberarsi dai gravami dialettali.
Eppure alcuni passi sembrano alludere a questioni non puramente retoriche. Uno in particolare può costituire un vero e proprio tesoro per la decifrazione del linguaggio dantesco; soprattutto in relazione al Paradiso.
Scrive Dante, nel definire quei termini che spiccano per una particolare soavità:
«E definiamo ben pettinati i vocaboli trisillabici o molto vicini al trisillabismo, senza aspirazione, senza accento acuto o circonflesso, senza le consonanti doppie z e x, senza liquide geminate o poste subito dopo una muta, i vocaboli insomma quasi levigati, che a pronunciarli ti lasciano come una soavità in bocca quali
Amore, Donna, Disio,
Virtute, Donar, Letitia,
Salute, Securtate, Defesa»[12].
Questo paragrafo, dal tono quasi interlocutorio e che potrebbe apparire quale una semplice prescrizione stilistica, può rivelarsi fondamentale per avvicinarci alla comprensione del linguaggio adottato da Dante e da coloro che avevano intelletto d’Amore. I nove termini sono difatti elencati in un particolare ordine che sembra richiamare la gerarchia da essi rivestita nella poetica del Dolce Stil Novo; ben oltre, essi possono offrire anche delle precise analogie con le sfere celesti descritte nel Paradiso. È come se Dante avesse voluto codificare l’intera gerarchia spirituale che si apprestava a dispiegare nell’ultima cantica della sua Commedia in nove semplici parole.
L’ultima di queste parole, defesa, si adatta bene in effetti a descrivere la prima delle sfere celesti, quella lunare, la quale, posta a ridosso della sfera di fuoco, offre una vera e propria difesa rispetto alla dimensione mondana e profana a tutte le altre sfere superiori.
In merito alla penultima parola, securtate, essa corrisponderebbe, secondo l’intuizione, al cielo di Mercurio nel quale risiedono gli spiriti cosiddetti attivi i quali ricoprirono alti uffici, lottando per la giustizia e vigilando sulla condotta delle loro popolazioni.
La terzultima parola è poi salute.
Come noto, il termine rimanda al saluto di Beatrice la quale, nella Commedia, verrà ad impersonare l’intelligenza trascendente, la sapienza purificata[13]. Salute potrebbe dunque corrispondere al cielo di Venere, che è il cielo nel quale l’ombra del cono di luce prodotto dalla terra in opposizione al sole si dilegua del tutto[14].
Il primato di Amore e Donna nel gruppo delle nove parole non fa che confermare queste impressioni. I due termini hanno infatti assoluta rilevanza nella simbologia della poetica dantesca, e della Commedia in particolare, in quanto simboli rispettivamente della suprema potenza universale e dell’intelligenza trascendente; essi non possono essere circoscritti all’ambito di una precisa sfera planetaria bensì, per analogia, ricondotti alla funzione del primo mobile e della sfera delle stelle fisse così come appare nel Paradiso.

IMMAGINE COPERTINA: Gustave Doré, La confusione delle lingue, incisione, 1865
FONTE ARTICOLO IGNOTA SCINTILLA
NOTE
[1] DVE, Lib. I, II, 1.
[2] Ivi: «Cum igitur angeli ad pandendas gloriosas eorum conceptiones habeant promptissimam atque ineffabilem sufficientiam intellectus, qua vel alter alteri totaliter innotescit per se, vel saltim per illud fulgentissimum Speculum in quo cuncti representantur pulcerrimi atque avidissimi speculantur, nullo signo locutionis indiguisse videntur».
[3] Ivi, V e VI.
[4] Ivi, Lib. I, VI, 5 e I, VII, 4. La posizione dantesca rispetto a questo punto sembra essere mutata nel Paradiso, lì dove Adamo rivela che la lingua ebraica era già “tutta spenta” ben prima della costruzione della torre babelica, ma in realtà quanto detto dal primo uomo riguarda “i mortali” e non i Patriarchi e Adamo stesso i quali, nella loro immortalità, hanno ancora piena memoria dell’ebraico delle origini. Si veda Paradiso XXVI, 103-142. Tracce di questa concezione dell’ebraico quale lingua immortale possono essere trovate anche in Matteo 5, 18.
[5] Ibidem, I, VI, 5-6: «Hac forma locutionis locutus est Adam; hac forma locutionis locuti sunt omnes posteri eius usque ad edificationem turris Babel, que turris confusionis interpretatur; hanc formam locutionis hereditati sunt filii Heber, qui ab eo dicti sunt Hebrei. Hiis solis post onfusionem remansit, ut Redemptor noster, qui ex illis oriturus erat secundum humanitatem, non lingua confusionis, sed gratie frueretur». La descrizione di Dante sul linguaggio primordiale non si limita a questo passo, ma occupa ampi tratti dei Capitoli: IV, V, e VI del Primo Libro.
[6] Si veda un passo estremamente rilevante di Gioacchino da Fiore a questo proposito: Sull’Apocalisse, (Enchiridion super Apocalypsim), Feltrinelli, 2008, pp. 145-172.
[7] DVE, Lib. I, VII, 7.
[8] Ibidem, Lib. II, VII, 3. «Intuearis ergo, lector, actente quantum ad exaceranda egregia verba te cribrare oportet». “Osserva dunque, o lettore, e attentamente che lavoro di setaccio ti occorre fare per separare le parole eccellenti da quelle da scartare”.
[9] Ibidem, Lib. I, XVI, 1. «Postquam venati saltus et pascua sumus Ytalie, nec pantheram quam sequimur adinvenimus, ut ipsam reperire possimus rationabilius investigemus de illa ut, solerti studio, redolentem ubique et necubi apparentem nostris penitus irretiamus tenticulis». “Dopo che abbiamo cacciato per monti boscosi e pascoli d’Italia e non abbiamo trovato la pantera che bracchiamo, per poterla scovare proseguiamo la ricerca con mezzi più razionali, sicché applicandoci con impegno, possiamo irretire totalmente coi nostri lacci la creatura che fa sentire il suo profumo ovunque e non si manifesta in nessun luogo”.
[10] Ibidem, Lib. I, V, 1: «(…) rationabiliter dicimus ipsum loquentem primum, mox postquam afflatus est ab animante Virtute, incunctanter fuisse locutum».
[11] Ivi: «(…) rationabiliter dicimus ipsum loquentem primum, mox postquam afflatus est ab animante Virtute, incunctanter fuisse locutum».
[12] Ibidem, Lib. II, VII, 5: «Et pexa vocamus illa que, trisillaba vel vicinissima trisillabitati, sine aspiratione, sine accentu acuto vel circumflexo, sine z vel x duplicibus, sine duarum liquidarum geminatione vel positione immediate post mutam, dolata quasi, loquentem cum quadam suavitate relinquunt: ut amore, donna, disio, virtute, donare, letitia, salute, securtate, defesa».
[13] Le opere dantesche offrono spesso insegnamenti tratti dalla matematica pitagorica per la quale i numeri non sono mere quantità, ma hanno di per se stessi un alto valore simbolico. Il DVE non fa eccezione in questo senso, difatti nel corso di un’approfondita riflessione sulle gerarchie che coinvolgono l’intera manifestazione Dante scrive: “(…) et simplicissima quantitas, quod est unum, in impari numero redolet magis quam in pari” ovvero “(…) e la quantità più semplice, l’unità, si fa sentire più nei numeri dispari che nei pari” (DVE, I, XVI, 5).
[14] Paradiso, IX, 118-120. “Da questo cielo, in cui l’ombra s’appunta/ che ‘l vostro mondo face, pria ch’altra alma/ del triunfo di Cristo fu assunta” A parlare a Dante è qui il trovatore Folchetto da Marsiglia. Per il termine Salute si legga anche il sonetto di Guido Cavalcanti “Chi è questa che viene, che ogni uom la mira” nel quale il poeta canta: “Non fu s’alta già la mente nostra/ e non si pose ‘n noi tanta salute/ che propiamente n’aviàn conoscenza”. Proprio alla mancanza di Salute di cui si parla in questi versi potrebbe alludere un passo dell’Inferno nel quale Dante incontra il padre di Cavalcanti. Si veda Inferno, X, 61-63.