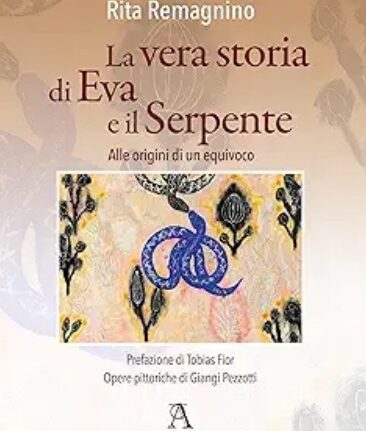Nella sua opera Les Fleurs du Mal Charles Baudelaire parla del mare come di una donna: “Tu lo abbracci con gli occhi e con le braccia … “. Altri poeti hanno identificato la strada di casa con il volto di una donna, o paragonato alla donna l’imprevedibile mutevolezza del mare. Ma è nelle speculazioni orientali, nel cristianesimo dei primi secoli e nella gnosi che il tema Donna-Luna-Acqua-Perla si presenta con maggiore frequenza.
Tuffatevi nell’oceano alla ricerca della perla nascosta, diceva sant’Efrem, e ritroverete la vostra divinità. A quali acque alludeva il teologo siriaco? C’entra probabilmente il punto più perlifero del mondo, che durante l’ultimo periodo glaciale fu anche un importante crocevia culturale, cioè il triangolo formato da Nuova Zelanda, Isola di Pasqua e isole Hawaii.
Nulla di strano se le riflessioni e gli accostamenti originati da questa magnifica concrezione naturale provenissero da un vertiginoso passato, se non addirittura dai tormenti nostalgici dei navigatori paleolitici assillati dal ricordo della patria lontana e di donne in attesa sulla terraferma di un ritorno che non si sapeva se ci sarebbe mai stato.
Nata dal lampo di luce che penetra l’ostrica, cioè dall’unione dell’Acqua con il Fuoco, la perla divenne un bel momento il simbolo del dramma spirituale della caduta dell’uomo, considerata in ogni caso reversibile in quanto il lampo di luce trattenuto all’interno del guscio recava con sé il germe della salvezza.
Si trattava insomma di una promessa, di un patto sottinteso, di un’alleanza tra elementi differenti che continuamente si rinnovava. Nelle gesta dell’eroe culturale tibetano Gesar (versione classica del XV secolo) la Dea della Compassione è una bambina con “un guscio di conchiglia in testa e ha uno scudo sferico di luce bianca che l’avvolge” (Gyanpian Gyamco e Wu Wei, L’epica di re Gesar, Anteo, Cavriago, 2022).
Altrettanto ricco di significati appare l’habitat della perla, che in quanto ad esperienze accumulate non ha niente da invidiare a nessuno, avendone viste e passate di tutti i colori. Nel 1947 il ricercatore norvegese Thor Heyerdahl ne indagò gli aspetti storico-antropologici, sperando in cuor suo di risvegliare i colleghi del mondo accademico, arroccati nell’idea neo-coloniale di aborigeni semianalfabeti (cioè, «inferiori») in grado di muoversi lungo le coste per pescare, ma incapaci di affrontare una navigazione d’alto mare.
Come potevano esserne sicuri? Su quali conoscenze poggiava tale teoria? Avevano forse avuto esperienze marinare, o vissuto a stretto contatto con le popolazioni indigene? Un qualunque lupo di mare avrebbe potuto smentirli in un minuto, spiegando loro come i pericoli diminuiscano durante la navigazione che si svolge lontana dalle insidie delle coste.
A maggior ragione in una situazione di acque particolarmente basse quale era stata quella dell’ultima Era Glaciale, nessuno avrebbe indugiato più del dovuto fra gli scogli con il rischio di sfracellarsi, quando l’abbondanza di terre emerse invitava le imbarcazioni a prendere il largo.
Deriso e sbeffeggiato dai colleghi rintanati nelle biblioteche della Vecchia Europa, già allora malata di suprematismo occidentale, il ricercatore norvegese decise di passare dalle parole ai fatti e varò la Kon Tiki Expedition. A bordo di una grande zattera di balsa progettata secondo un modello andino, o sudamericano, e più che mai deciso a dimostrare la propria teoria, Heyerdahl salpò con un piccolo equipaggio di cinque persone da Callao (Perù) e dopo 101 giorni di navigazione arrivò sano e salvo nell’arcipelago di Tuamotu (Polinesia francese).

L’attraversamento del Pacifico da est a ovest fu favorito dalla Corrente di Humboldt, un’aria marina fredda di origine antartica che scorre nella parte meridionale dell’Oceano Pacifico meridionale con direzione Sud-Nord, risale lungo le coste del Cile, procede in Perù ed infine si unisce alla corrente equatoriale del Sud [immagine 1].
Si erano avvalsi della stessa «spinta» i navigatori primordiali provenienti dall’Asia e dall’Antartide Minore, sgombro dai ghiacci fino al 4000 a.C.? Altre correnti «amiche» circolavano in tempi preistorici nell’Oceano Pacifico?
Difficile dirlo. Se comunque in acque molto più profonde e sopra una zattera da due soldi ce l’aveva fatta un giovane norvegese che non sapeva neppure nuotare, figurarsi i navigatori dell’Era Glaciale in acque più basse di centoventi metri e al timone di navi d’alto mare.
Sulle rotte dei viracochas
All’epoca della Kon Tiki Expedition Heyerdahl era già un veterano del Pacifico. Sull’isola marchesiana di Fatu-Hiva aveva trascorso una luna di miele durata quindici lunghi mesi (tra il 1937 e il 1938), nonché valutato insieme alla neo-mogliettina la possibilità di non tornare mai più a casa.
Entrambi appassionati ricercatori i due giovani frequentarono luoghi mai visti prima da occhi occidentali, scovando nella fitta giungla lastre perfettamente squadrate e pesanti tonnellate, bassorilievi di figure in posizione yoga (accovacciate con le braccia ad angolo retto), petroglifi dove abbondavano simboli solari, spirali, piccole figure umane, pesci, tartarughe ed altri animali (T. Heyerdahl, Fatu-Hiva, Club degli Editori, Milano, 1974).
In particolare l’«ornamento degli occhi» era un motivo ricorrente. Dappertutto c’erano occhi simili a quelli delle dee-Uccello eurasiatiche. Occhi tondi come i soli radianti della cultura Tiwanaku (boliviana e peruviana). Occhi espressi da puntini circondati da anelli concentrici. Ma anche bocche enormi, gambe minuscole appena stilizzate e mani intrecciate su pingui ventri.
Spiccava tra le incisioni una curiosa imbarcazione a forma di mezzaluna con il fondo ricurvo, la poppa e la prua molto elevate, due alberi e file di remi. Per quanto se ne sapeva, i Polinesiani avevano sempre usato canoe incavate e zattere piatte ricavate da un tronco singolo; a quale grande imbarcazione si erano dunque ispirati gli antichi scultori locali?
Uno studio comparato dello strano vascello permise agli Heyerdahl di tracciare un parallelo tra l’America precolombiana e le isole del Pacifico subequatoriale, dove innumerevoli volte si supponeva avessero gettato l’ancora le navi provenienti da Bolivia, Perù, Cile e dirette a Ceylon.
Sull’isola di Hivaoa gli Heyerdahl studiarono alcuni colossi alti tre metri (chiamati i «giganti di Puamau») e scolpiti in un unico blocco di pietra rossa all’interno del perimetro di un grande tempio, di cui restavano nel sottobosco tracce di mura ciclopiche e statue semisepolte nel terreno.
Non era chiaro quale artista visionario avesse ritratto sulle pietre i puma, animali sconosciuti sia in Polinesia che in Australia. Una coppia quasi identica di questi felini era però incisa in rilievo a Tiahuanaco, e precisamente sulla base di una statua di pietra rossa raffigurante Con-Tici-Viracocha, il barbuto re-sole sudamericano, che, secondo la narrazione orale tramandata dagli aymara, predecessori degli Incas, era arrivato dal mare insieme a una flotta di grandi navi dalle prue affusolate.
Analogamente il patrimonio culturale delle Isole Marchesi conservava il racconto di un certo Tiki, o Tici, giunto in tempi remoti dall’ancestrale Te-Fiti, ovvero «da Oriente», dove non c’era altra terra che il Sudamerica.
Gli Heyerdahl si dissero che se due indizi facevano una coincidenza, tre facevano una prova, e perciò valeva la pena di proseguire le ricerche. Trovarono infatti somiglianze inequivocabili tra il materiale catalogato e certe statue rinvenute a San Agustin, nelle Ande settentrionali, a est delle Isole Marchesi, sempre dritto in direzione di Tiahuanaco.
Consapevole del valore delle narrazioni tradizionali, che non creavano certo trame dal nulla ma semmai tramandavano la Memoria, la giovane coppia dedicò parte del proprio tempo all’ascolto di tutti gli uomini colti delle tribù polinesiane, i quali ripetevano all’unisono le peripezie di un popolo ancestrale, laborioso e sapiente, con i capelli rossicci e la pelle chiara, poi sconfitto da nuovi stranieri venuti dal mare.
Evidentemente le isole erano state un importante luogo di transito battuto inizialmente da stirpi solari (eurasiatiche?) che civilizzarono gli aborigeni, e successivamente da gruppi più agguerriti (sudamericani?) che imponendosi sui «rossi» dal viso pallido non riuscirono tuttavia a cancellarne il ricordo.
Principalmente per questa ragione i primi europei sbarcati in tempi ormai storici nelle Isole del Sud furono bene accolti dagli autoctoni, che li scambiarono per un gruppo di ritorno dei leggendari viracochas. Con la differenza, rispetto allo sbarco di Cortés nello Yucatan, che nelle Hawaii il capitano Cook ci rimise la pelle non appena gli indigeni si accorsero dell’errore.
I Maestri dell’Ovest
Essendo giovani, svegli e preparati, i due norvegesi insistettero sulla reale discendenza dei Polinesiani, diversi da tutti gli altri per forma del capo e del naso, colore e struttura dei capelli, statura, incarnato, barba e peli del corpo.
Per esempio nelle Isole Marchesi il 7,2% degli uomini e il 9,5% delle donne aveva gli occhi azzurri. Senza contare il ritrovamento di teschi dolicocefali compatibili con quelli eurasiatici e la presenza di tradizioni che parlavano di «terre fredde», ovvero di un paese remoto chiamato Atia-te-varinga-nui, che significava «aria-coperta-di-riso», dove “gli dèi trascorrevano il loro tempo nell’acqua [o nel ghiaccio?] durante la stagione fredda … l’uccello nero-bianco voleva raggiungere il cielo, ma glielo vietava la crudezza del freddo” (T. Heyerdahl, op. cit.).
Senza un’imbeccata esterna i Polinesiani non avrebbero mai potuto descrivere climi invernali, temperature rigide, nebbia e neve, alberi verdeggianti soltanto per metà dell’anno. Erano inoltre presenti nella parlata corrente interessanti contaminazioni glottologiche; per esempio il popolo primordiale delle Hawaii si chiamava Maoli e quello della Nuova Zelanda, per parentela diretta, Maori; gli antichi capi di governo di Tahiti erano detti Ari’i (Ali’i in hawaiano) e creduti déi altissimi e sapienti «discesi dalla cima della montagna nebbiosa di Temehane».
Ai tempi della spedizione degli Heyerdahl esisteva nelle Isole della Società (Polinesia francese), e forse esiste ancora, l’arcaica società segreta degli ari’i, un circolo esclusivo riservato ai «discendenti degli dèi» che in tempi remoti portarono la civiltà in Polinesia. Mentre nell’arcipelago hawaiano al vertice di ogni clan famigliare c’era un ari’i rahi, o capo (rahi) dei nobili (ari’i), e la società era suddivisa in caste (capi, sacerdoti, popolani).
Non potevano mancare nel patrimonio culturale della regione i poemi che ricordavano in modo nostalgico e dolente le «isole perdute», o «isole nascoste dagli dèi» (12 in tutto, il numero-cardine dei popoli Ari), sulla maggiore delle quali erano apparse all’inizio dei tempi le due principali divinità hawaiane.
Grazie al buon governo di costoro gli antenati degli isolani erano vissuti in pace per parecchio tempo, bevendo un nettare di lunga vita chiamato awa (simile al soma indiano e all’haoma iranico) e cibandosi delle delizie offerte dalla flora locale.
Finché un tale di nome Kumuhonua si ribellò all’ordine costituito e infranse la legge del divino Kane. Immediatamente il sovversivo e i suoi sodali furono allontanati dalla comunità, ma purtroppo il provvedimento non bastò a ricucire tutte le smagliature scivolate nel frattempo all’interno della rete sociale, ovvero a parare i colpi della sventura, sempre in agguato, che arrivò poco dopo sotto forma di diluvio universale. Angeli caduti in Polinesia? Ma allora, dove diavolo era nata la storia … del diavolo?
Gli eroi culturali dell’Est
Dopo avere studiato, catalogato e annotato con cura tutte le «anomalie» presenti nell’area gli Heyerdahl giunsero alla conclusione che il triangolo strategico (Isola di Pasqua a est, Samoa/Nuova Zelanda a ovest, Hawaii a nord) era stato il fulcro del Pacifico prima del sollevamento dei mari [immagine 2].
Almeno due importanti ondate migratorie lo avevano coinvolto e trasformato: la prima, più antica, proveniente da ovest (Eurasia) e la seconda, più recente, proveniente da est (Sudamerica). In entrambi i casi i forestieri erano giunti dal mare e non ci voleva un genio per immaginare lo stupore e la meraviglia degli indigeni, pratici solo di zattere rudimentali, alla vista di navi simili a montagne di legno sormontate da immense tele e mosse dall’energia del vento.
Un isolano non sarebbe stato in grado di progettarle, e tanto meno di governarle, perciò i piloti dovevano possedere doti divine. Solo degli esseri soprannaturali potevano condurre imbarcazioni del genere da un approdo all’altro, allungando una mano per acchiappare i fulmini quando colpita dalle tempeste oceaniche la nave rollava paurosamente e sembrava non doversi più raddrizzare.
Per completare il quadro gli Heyerdahl associarono ogni singolo flusso migratorio a una determinata condizione geo-climatica, giungendo alla conclusione che durante l’ultima fase del disgelo, mentre le acque marine salivano inesorabilmente e interi arcipelaghi finivano sott’acqua, doveva esserci stato un periodo in cui le correnti bloccavano la navigazione da ovest (→Eurasia) e favorivano quella da est (←Sudamerica).
Indipendentemente dalla loro volontà gli abitanti del fatidico «triangolo» erano così passati dal pacifico governo dei vecchi eurasiatici a quello più dinamico degli eroi culturali sudamericani, ai quali andava comunque riconosciuto il merito di avere introdotto nelle isole la coltivazione della patata dolce e della zucca a fiasco, della noce di cocco, dell’ananas e della papaia.
Tra gli eroi culturali più citati dagli anziani locali vi erano l’impavido Rata, che dopo avere superato una serie di prove in «oceani multicolori» (sciamanici?) uccise la Tridacna Gigante divoratrice di navi ed equipaggi (una specie di kraken); l’intraprendente Kupé, che scoprì la Nuova Zelanda; il geniale Hiro, considerato il padre-ingegnere di tutte le strutture navali oceaniche.
Proprio al sopraggiungere di questi personaggi gli isolani facevano risalire l’uso di adornarsi di piume, ornamenti ai quali erano attribuite virtù medico-magiche. I primi a servirsene furono i membri delle caste autoctone più elevate, i quali, a quanto pare, avevano un debole per le penne rosse dell”i’iwi” (scarlet honeycreeper) e dell”apapane”, entrambe specie abbastanza diffuse nelle verdeggianti foreste pluviali delle Hawaii, una delle masse continentali più giovani del pianeta composta da 137 isole vulcaniche che coprono un’area di 2.414 chilometri.

Hawaii, l’ombelico del Pacifico
Al termine di quell’avventurosa esperienza gli Heyerdahl confermarono quanto già negli ambienti culturali europei si cominciava ad intuire, nonostante quasi nessuno osasse dirlo apertamente: durante l’ultima Era Glaciale le acque del Pacifico furono percorse in lungo e in largo dai navigatori paleolitici e perciò, sì, effettivamente, l’uomo del XX secolo non era il più evoluto apparso sulla Terra.
Negare una tale evidenza significava lasciare senza risposte le numerose affinità culturali e linguistiche presenti in quell’area marina, le parentele genetiche e somatiche, le somiglianze di alcuni isolani con i Nativi americani e di altri con gli eurasiatici. Troppa roba da controllare tutta insieme. D’altra parte ammetterlo voleva dire aprire la porta a scenari inediti; ma la salvezza dalla menzogna non stava forse nella libera ricerca condotta senza particolari aspettative, o false speranze?
Tuttora nelle Hawaii qualche sognatore (categoria umana che non teme l’estinzione) racconta di avere «visto» alzarsi dalla linea d’orizzonte, in genere all’alba o al tramonto, una delle isole perdute avvolta da una luce rossastra. Certi giorni il fantasma si può scorgere sul fondale, mentre in altre occasioni l’ombra appare a pelo d’acqua, tutto dipende dall’umore degli dèi.
Ancora non è chiaro chi abitasse le terre emerse del Pacifico subequatoriale prima dell’arrivo dei navigatori intercontinentali (il piccolo popolo dei Menehune, gente di bassa statura che lavorava la pietra?); ma in futuro ci sarà tempo anche per rispondere a questa domanda.
Per il momento basti sapere che da almeno trentamila anni il triangolo formato da Nuova Zelanda, Isole Hawaii e Isola di Pasqua è un teatro strategico di primaria importanza. Dopo un lungo periodo di oblio lo spostamento del baricentro degli equilibri geopolitici mondiali dall’Atlantico al Pacifico lo sta riportando al centro dell’attenzione, segno che un nuovo cammino sta per iniziare (J. Diamond, Collasso: come le civiltà scelgono di vivere o morire, Einaudi, Torino, 2014).
L’area che parte da Singapore e termina nei mari contesi tra Cina, Taiwan e Filippine è il nuovo centro degli interessi economici delle super-potenze. Ormai tutto passa dalla gigantesca rete di scambi commerciali formata dall’insieme di isole che compongono l’attuale Melanesia, Micronesia e Polinesia, direttamente comunicanti con la regione indonesiana.
Al proprio destino geografico non si sfugge.
Dunque com’era all’inizio, così sarà alla fine? La storia del ciclo presente terminerà là dove tutto è iniziato, tra l’Artico e il Pacifico? Impossibile fare previsioni in un momento caotico come l’attuale, ma certo lo studio della Preistoria è una stampella di cui oggi non si può fare a meno. Solo dall’attenta osservazione dell’alba si possono ricavare gli strumenti necessari a prevedere il tramonto, e sperare di non morire di paura durante la notte, in attesa del mattino successivo.