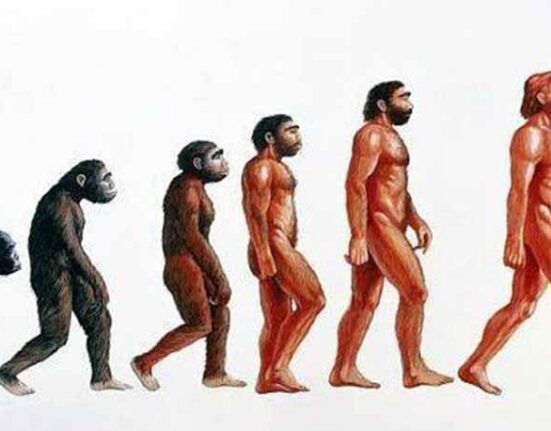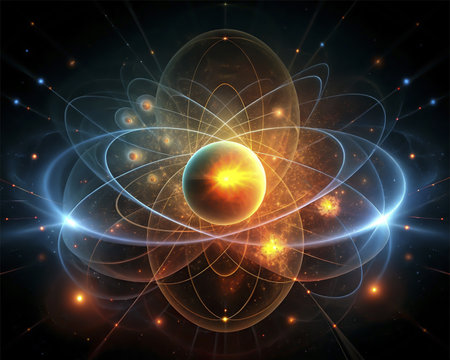cità dell’umano, e la sua riconducibilità ad un’origine monofiletica, è stata indagata anche da un punto di vista più prettamente scientifico; in termini biologici l’argomentazione principale risiede nella totale interfecondità reciproca di tutti i vari gruppi e, con ciò, l’evidenza che questi non rappresentano l’inizio incipiente di specie diverse. Passando al punto di vista glottologico, il già incontrato Alfredo Trombetti fu convinto sostenitore di una fonte comune di tutte le famiglie linguistiche del pianeta, mentre, più recentemente, Merritt Ruhlen ha rilevato come tutte le oltre 5000 lingue sparse nel mondo condividano più o meno il medesimo grado di complessità, cosa che risulterebbe incoerente con un’origine polifiletica delle stesse; in generale i ricercatori odierni osservano che tutte le lingue mondiali si basano sulla combinazione di una quantità di fonemi che può variare da un massimo di 40 ad un minimo di 14, numeri che, pur nella loro relativa distanza, appartengono ad uno stesso ordine di grandezza a testimonianza di un’origine quasi certamente non indipendente.
probabile siano state assunte e reinterpretate concezioni sciamaniche residuali e valenze magico-totemiche, come forse per il caso della trasformazione in uccello, concezioni che sembrano ben radicate anche nel vasto corpus ellenico. Nuccio D’Anna riconduce infatti ad un tipo di spiritualità sciamanica – ma non per questo necessariamente estranea al mondo indoeuropeo – il numeroso raggruppamento di esseri divini preolimpici dalle caratteristiche “acquatiche”, ma anche le figure di Hefestos e dello stesso Apollo, e con esso tutta una serie di personaggi semi-mitici ritenuti i suoi più devoti adoratori. Ad esempio Eliade ricorda l’iperboreo Abari che era dotato di poteri oracolari e magici; leggende analoghe parlano di bilocazioni, discese agli inferi, estasi di altri personaggi greci, tutti collegamenti piuttosto chiari con il fenomeno siberiano e in generale tra la vocazione apollinea e quella sciamanica. Una vocazione che sembra aver interessato anche il corpus norreno, se è vero che Massimo Centini vi rileva sorprendenti connessioni con alcune funzioni dello stesso Odino.
rò rilevato che l’influenza, senz’altro notevole, che le categorie bachofeniane esercitarono sulle elaborazioni di Julius Evola, rappresentano un elemento abbastanza isolato nell’ambito degli autori che si accostarono allo studio delle dottrine tradizionali, qualcuno anzi sottolineando come tali categorie, da questo punto di vista, non possano essere sorrette da una vera autorità dottrinaria. Ma è proprio da tali categorie che Evola ricevette un’impostazione che diversi ricercatori hanno definito “dualistica”, e che Di Vona accosta alle concezioni di Platone e Parmenide in merito alla “dottrina delle due nature”; una visuale che, accogliendo in pratica il concetto di una chiara scissione tra mondo terreno e dominio celeste, sembra quasi prevalere anche sulla tradizionale tripartizione dell’uomo (Spirito, Anima, Corpo). Tale impostazione trasmise al pensatore romano la tendenza in ogni ambito, e quindi anche in quello storico che qui più ci interessa, a sottolineare maggiormente gli aspetti separativi piuttosto che quelli unitari, ed a contrapporre elementi che invece, con un diverso approccio interpretativo, avrebbero potuto essere letti come certamente diversificati ma comunque riconducibili ad un’unica realtà di fondo. Si arriva così alla situazione, per certi versi paradossale, che Evola, pur giungendo ad ammettere teoricamente una “Tradizione Primordiale”, ne postuli, nel 1930 su “La Torre” due “grandi ed opposte formulazioni”, una cioè legata al Nord e poi all’Occidente, l’altra legata al Sud e poi all’Oriente. Anche nel 1931 Di Vona segnala un intervento nel quale il Nostro metteva in dubbio l’unità trascendente della Tradizione e nel quale si interrogava se fosse concepibile una “differenziazione originaria” in seno a quella spiritualità che “farebbe da sfondo” ad ogni civiltà tradizionale. A questa differenziazione Evola – ricalcando il Bachofen – continua sempre a far corrispondere la dicotomia tra tipo sacerdotale (tradizioni meridionali) e tipo eroico (tradizioni nordico-occidentali), quindi con il nostro campo attestato sui valori dell’azione, pur in forme materialistiche certamente da condannare; tale condanna, però, secondo Evola non deve far cadere – all’opposto – in forme di spiritualità anti-occidentale, di tipo contemplativo-ascetico, tra le quali pone anche quella dei Veda (che “non è la nostra tradizione”) né, come sottolineerà in Rivolta, in forme estremo-orientali di tipo sciamanico, a suo giudizio di inferiore levatura spirituale, quindi in disaccordo con quanto più sopra esposto.
almeno alcune popolazioni subsahariane.
Bibliografia consultata per il presente articolo:
le origini – Morcelliana – 2000