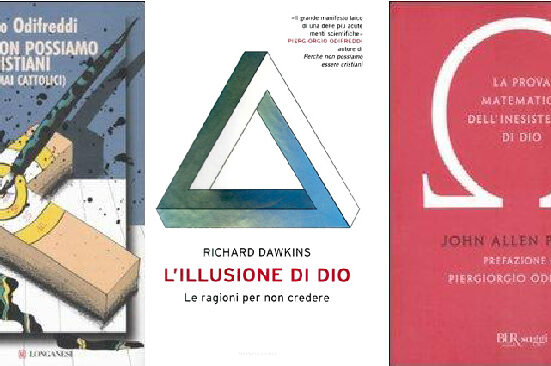La realtà che viviamo tutti i giorni è passibile di diverse interpretazioni. È un po’ quello che dicono le religioni quando si riferiscono alla scelta che l’uomo deve compiere tra Bene e Male. Ogni evento che accade è in sé un fenomeno fisico, cioè neutro, quindi se è giusto o sbagliato, bello o brutto dipende in definitiva da come noi lo consideriamo. Un vulcano che erutta è semplicemente un fenomeno fisico, ma se fa bello spettacolo al tramonto lo consideriamo in maniera positiva, se la sua lava distrugge qualche casa lo consideriamo un evento negativo.
La psicologia insegna che noi viviamo nelle nostre fantasie. Il giudizio sugli altri, sul mondo che ci circonda, sulle cose che facciamo, e altro, non è quasi mai del tutto oggettivo, ma dipende dai nostri personalissimi metri di giudizio, anche se noi tendiamo a dare a questi moti interiori una valenza oggettiva e assoluta.
Facciamo l’esempio di un quadro. Il nostro occhio è una struttura anatomica che cattura la luce, trasforma il segnale luminoso in energia chimica che si trasmette dalle vie nervose periferiche al cervello. In questo processo non ci sono dati oggettivi, innanzitutto perché il mondo esterno appare diverso da persona a persona, nella percezione c’è sempre una componente soggettiva, e questo apparve chiaramente sin dai primi esperimenti sulle leggi della percezione. In secondo luogo il critico d’arte ha ciò che viene definito “occhio culturale”, cioè l’uomo non solo vede un quadro ma interpreta ciò che vede in riferimento a quanto già conosce. Non esiste un quadro in sé, il quadro si pone sempre sulla scia di altre opere artistiche, del “sistema” culturale di riferimento. Il critico d’arte giudica un quadro in quanto espressione di una certa cultura di un certo tempo e luogo. Così come un romanzo si pone entro il “sistema” letteratura e lo arricchisce. Quelle parole non sono assolute, la fabula e l’intreccio acquisiscono un senso pieno solamente in riferimento alla cultura di appartenenza. Il critico d’arte o il critico letterario interpreta un’opera all’interno del “sistema” facendo risaltare quello che lui ritiene significativo in base alla propria conoscenza e al proprio giudizio.
Detto in altri termini, il mondo esterno è un simbolo, cioè un segno materiale collegato a significati ulteriori. Questi significati ulteriori devono essere interpretati dalla mente della persona che si approccia a quei segni.
Il nostro cammino su questa terra è una scoperta continua di nuove interpretazioni, sempre migliori ma mai completamente compiute. L’esperienza acquisita negli anni serve a farci capire meglio la realtà esterna, senza mai pretendere di aver acquisito una conoscenza assoluta, cioè di aver capito tutto.
Nella vita una persona può commettere molti sbagli, ma, se decide di capire meglio ciò che fa, può sempre migliorare. È questo l’aspetto tragico della vita, e si chiama libertà. Nulla è dato per scontato, siamo tutti persone in cerca della via. Le possibilità che si accavallano nel nostro percorso devono essere scelte da noi mediante una consapevolezza sempre maggiore che acquisiamo strada facendo.

In questo percorso sono due i più grandi ostacoli. Il primo è l’auto-sabotaggio. Ci creiamo dei limiti mentali e attribuiamo agli altri la colpa di questi. È facile che un medico dalla scarsa erudizione o dalla difettosa competenza si creda un luminare per compensare la sua scarsa preparazione. Si parla di ipertrofia dell’Io, mostra una immagine vincente e forte, sapiente e decisa e poi umilia gli altri. Tutto questo per nascondere alla propria coscienza le gravi lacune nella pratica medica. Ad un certo punto a quel medico arriva un segnale dall’esterno: un paziente valuta che è un incapace e glielo dice o rifiuta il parere. Il medico dovrebbe aspettarsi la critica se avesse una immagine reale di sé. In realtà vive nelle sue illusioni e non capisce la critica, il giusto feedback che ha avuto dal mondo esterno, quindi cade in depressione, piange di non essere un bravo medico, si ritiene un fallito, sperimenta un disagio esistenziale. In realtà la colpa del suo disagio è solamente sua, si è auto-sabotato, vivere nelle illusioni crea una possibile tensione con il mondo esterno, alla quale poi non era per nulla preparato.
Il secondo ostacolo è credere di conoscere gli altri. Spesso noi pensiamo che gli altri la vedano come noi. È possibile, specie tra amici, ma è anche possibile che gli altri non condividano le nostre idee. Noi abbiamo avuto delle esperienze che ci hanno spinto a pensarla in un modo, loro altre esperienze. Il mondo è aperto alle più svariate interpretazioni, le persone esprimono giudizi sulle cose e sugli avvenimenti dei quali non sappiamo nulla. Giudicare gli altri basandoci sulla nostra opinione o sulle apparenze si chiama psicologismo. Prima di tutto dobbiamo chiedere le ragioni dell’altro e poi dobbiamo considerare l’ipotesi che forse non potremmo nemmeno capirle. Per questo una volta si diceva in chiesa che non bisogna mai giudicare gli altri.
Facciamo l’esempio di una persona che vive rubando. Un benpensante dice in senso dispregiativo: Questi è un ladro! Ma dietro questo giudizio c’è tutta una storia che nessuno può conoscere nei dettagli, se non la persona stessa. E in ogni modo dipende dal reo come ha deciso di approcciarsi agli avvenimenti che ha vissuto e lo hanno reso un tale ladro. La sensibilità varia da persona a persona, non siamo tutti uguali. La legge giudica sempre l’azione e non le motivazioni che hanno reso una persona un reo. Credere di giudicare l’animo (e non solo le azioni) di una persona è qualche cosa non solo di sbagliato ma di stupido, in quanto non capiamo che ogni persona ha una soggettività unica sulla quale non possiamo esprimere giudizi definitivi.
Un processo penale è come una ricerca scientifica. Lo scienziato esprime una ipotesi e poi cerca di verificarla mediante le prove. Le prove di loro natura non sono mai assolute, dipendono infatti dalla conoscenza che abbiamo, la quale non è mai assoluta, cioè può ampliarsi nel tempo. Quindi se cambia la cognizione di un fenomeno, cambia anche la legge scientifica, annullandosi o sviluppandosi. Una volta il processo penale si basava sul dibattimento, cioè in sostanza sulla confessione e sui testimoni. Oggi si basa soprattutto sulle cosiddette Scienze Forensi, cioè le attività scientifiche che si compiono sul luogo del delitto o scena del crimine. Questa attività scientifica fornisce una conoscenza maggiore e più precisa rispetto alla semplice testimonianza, e ha permesso di scagionare degli innocenti.
Lo scienziato Jeffrey scoprì un modo nuovo di identificare il DNA, che fu applicato dalla polizia per la prima volta nel 1985 su un caso di omicidio. Da allora in poi sono stati assolti molti presunti delinquenti che ad un processo dibattimentale risultarono colpevoli, ma che in realtà erano innocenti.
La conoscenza che abbiamo dei fatti è sempre relativa allo stato attuale delle ricerche, il quale non è mai perfettamente compiuto. Anche l’analisi del DNA ha avuto dei miglioramenti, che una volta erano impensabili. L’analisi del DNA è molto complessa e i due campioni genetici (quello sulla scena del crimine e quello del sospettato) non vengono confrontati totalmente ma solo in alcune regioni considerate particolarmente variabili. Oggi è possibile risalire al colpevole anche da tracce invisibili, come quelle sui mozziconi di sigaretta degli esecutori degli attentati di Capace lasciati sulla scena del crimine: con la nuova tecnica si è analizzato il materiale repertato e si è arrivati alla loro incriminazione. Gli studi sul DNA di applicazione forense sono in continua evoluzione: DNA vegetale, DNA animale, indicazioni sull’epoca della morte, caratteristiche fisiche. Oggi si stanno sviluppando metodiche per indentificare un delinquente anche studiando i batteri corporei lasciati sulla scena del crimine e addirittura l’odore (mediante cani altamente addestrati: odorologia forense).
Tuttavia la realtà esterna resta sempre un puzzle che non può mai essere ricomposto definitivamente. In questo senso appare un mistero. Nessun uomo che fa ricerca crede di avere raggiunto la verità assoluta, ma al massimo di aver aggiunto un tassello verso la conoscenza.
È vero che oggi la ricerca sul crimine ha raggiunto traguardi notevoli, ma è possibile che le tracce (impronte, DNA, e così via) non rimangano (il killer indossava i guanti) o vengano tolte con sostanze specifiche. Quando le tracce materiali sono esigue (non c’è la classica prova che incastra un criminale), gli investigatori ricorrono al criminal profiling, cioè tracciano un possibile profilo psicologico del criminale con lo scopo di restringere la cerchia dei sospettati.
Ma il profilo non è mai una prova, è solo un aiuto nelle indagini. Esso poi si applica soprattutto per i crimini seriali, e solo raramente per i crimini singoli. Poi la teoria del profilo si è evoluta: prima vi era la semplice distinzione tra criminale disorganizzato e criminale organizzato, oggi si parla di livelli di organizzazione, da una minima organizzazione a una organizzazione massima ma sempre con altri elementi di disorganizzazione compresenti. Ciò rende la possibilità di scoprire un possibile colpevole, ben più difficile. Ma esistono dei crimini dove nemmeno il criminal profiling dà molte possibilità di successo nell’investigazione, come nel serial bombing, cioè nel dinamitardo che nonostante metta molte bombe, da esse è difficile risalire a chi possa essere. Oltretutto chi mette una bomba è di solito molto organizzato, quindi sta attento a non lasciare indizi. Ci sono solitari o gruppi terroristici che usano accortezze anche nell’inviare un pacco bomba. Chi vuole inviare una bomba, non mette il nome proprio o un nome sconosciuto (sembrerebbe sospetto). Quindi, mettiamo che il dinamitardo voglia inviare un pacco bomba a un’azienda, invia il pacco a nome di quella stessa azienda a un destinatario inesistente: allora quando le poste si accorgono che il destinatario non esiste, rimandano il pacco indietro al mittente, cioè all’azienda da colpire. L’impiegato dell’azienda prende il pacco e verifica chi lo ha inviato, ma non pensa che sia un pacco bomba, bensì che qualche altro impiegato lo abbia inviato, e allora lo apre: la bomba raggiunge il bersaglio. Esistono, infatti, dei reati nei quali il criminal profiling non è mai utile: non solo i dinamitardi, ma tutti i reati di terrorismo. Allora in questi casi gli analisti del FBI, della CIA e degli altri servizi segreti del mondo ricorrono ad altri modi per scoprire un possibile delinquente.
Ma il problema della non conoscenza è ancor più profondo, in ogni tipo di scienza. Se ci pensiamo bene, una legge scientifica è convalidata da una serie di esperimenti, ma nessuno può dire che ha fatto tutti gli esperimenti necessari per dimostrarla. Ne ha fatti solo alcuni, quelli permessi dal centro di ricerca o ideati dalla equipe. Dal punto di vista filosofico, è stato notato da più parti che la maggior parte delle idee filosofiche non solo è falsa ma è completamente assurda. Piaget in una famosa intervista disse che dalla filosofia si avvicinò alla psicologia perché almeno quest’ultima disciplina è supportata da prove. Ma nonostante questo gli psicologi dicono certamente molte cose contemporaneamente, ma altrettante del tutto divergenti.
Tuttavia ciò non toglie che la vita abbia in sé un senso, solo che il senso non è discorsivo, ma è intuitivo. Pascal diceva che il cuore ha ragioni che la mente non conosce.
È nell’amore il senso recondito di ogni cosa. Ṛg-Veda X, 129, 4:
kāmas tad agre sam avartatādhi manaso retaḥ prathamaṃ yad āsīt sato bandhum asati nir avindan hṛdi pratīṣyā kavayo manīṣā, “All’inizio sorse poi Amore, che era il primo seme della Mente. Scrutando nei loro cuori i sapienti scoprirono, con la loro saggezza, il legame tra l’essere e il non essere”.
L’amore è un potentissimo atto di conoscenza intuitiva e non razionale. Il senso della vita sta nell’amore e non nei discorsi degli scienziati o dei filosofi. La verità non è un oggetto razionale ma una unione amorosa tra la persona e la realtà che la circonda. La gioia nasce non dalle cose che si possiedono ma dall’amore che abbiamo verso quel poco che possediamo. Il quale è tutto se abbiamo scoperto, mediante le vicissitudini della vita, che ha un valore incommensurabile. Perché è così importante? Perché in esso possiamo scorgervi la voce di Dio.
Dio non è una persona come noi, è invece qualcosa che oltrepassa tutto ciò che si possa dire o pensare. Dio si rivela in qualsiasi maniera, dall’amore per un figlio appena nato all’amore per un ideale. Il senso del sacro sta dappertutto, sta nelle cose che abbiamo, in esse possiamo scoprire, se ben guardiamo, il mistero che le anima. Questo atto di amore verso le cose è la armonia del mondo di cui parlavano i filosofi. Per sentirla non dobbiamo avere in mente la formula matematica esatta che spiega tutto ma, liberi dai limiti dell’egoismo, dobbiamo aprirci. È ciò che gli junghiani chiamano esperienza del Sé. Sentirsi parte del tutto.
In questo tutto sta Dio. Esso può prendere le sembianze di un’opera d’arte rifinita fino allo sfinimento o ammirata fino all’estasi, oppure di una famiglia adorata, oppure di una religione che dà sempre nuovi significati e suscita sempre più amore.
Dio è quella pura essenza (quiddità) che sta in tutte le cose senza identificarsi con esse in quanto le oltrepassa infinitamente. Tutti cercano Dio anche se non lo sanno. Alcuni hanno più consapevolezza della ricerca e trovano, in ciò che fanno nella dimensione terrena, il senso sacro della propria esistenza. Anche se in questa esistenza terrena Dio non potrà mai essere del tutto raggiunto, ma solo ricercato e trovato in modo imperfetto.
Cusano (De apice theoriae 3):
nam quiditas, quae semper quaesita est et quaeritur et quaerentur, si esset penitus ignota, quomodo quaereretur, quando etiam reperta maneret incognita? Ideo aiebat quidam sapiens ipsam ab omnibus, licet a remotis, videri, “infatti, se la quiddità, che è stata sempre ricercata, è sempre ricercata e sarà sempre ricercata, fosse del tutto sconosciuta, in che modo la si potrebbe ricercare, dato che, anche se venisse scoperta, non verrebbe riconosciuta? Per questo, un certo sapiente diceva che essa è vista da tutti, per quanto da lontano”.
I mistici dicono che Dio può parlare in ogni maniera. Nel cristianesimo occidentale ci sono persone che vanno sempre alla Messa. I loro occhi tradiscono che hanno trovato qualche cosa. Un ateo non potrà mai capire ciò che queste persone hanno trovato, perché la religione non è una vuota esteriorizzazione di tesi filosofiche, ma è un atto di amore verso quel tutto percepito dagli occhi dell’anima, e in quel pane misteriosamente presente.
A volte i fedeli scelgono un padre spirituale, che, anche al di fuori della confessione, indichi loro la via interpretando i dettagli della loro storia personale. Nell’Oriente cristiano il padre spirituale non è sempre un sacerdote, come in Occidente, ma una madre di famiglia o un amico. Dio, se vuole e l’anima apre gli occhi per capirlo, può esprimersi con la bocca di tutti. Si dice che ogni vero cristiano è al tempo stesso re, sacerdote e profeta.
Giovanni 3, 8:
“Lo Spirito soffia dove vuole, senti la sua voce ma non sai da dove viene e dove va”, che nell’originale greco suona to pneuma opou thelei pnei kai tēn phōnēn autou akoueis, all’ouk oidas pothen erchetai kai tou upagei.
Dio o Assoluto non risiede nei cieli così come angeli e defunti non sono in mondi separati da noi. Lo spirituale sta dappertutto, risiede in ogni cosa, solo che non ne abbiamo coscienza. In sanscrito si dice che satyam jñānam anantam Brahma, l’Assoluto è Pura Esistenza, Onnisciente e Infinito. Ma queste antiche parole sanscrite vogliono anche dire che l’Assoluto sta nella realtà, è la realtà stessa, così come noi la possiamo conoscere ed esperire, il suo essere infinito assoluto abita proprio qui.
Le religioni sono sistemi di contatto con questo Assoluto. Esse indicano varie vie, dalla conoscenza al rito, e altre. La via giusta per ognuno di noi la sceglie la propria individualità. Non ci sono percorsi validi per tutti. Per alcuni una religione formale è addirittura incomprensibile e queste persone scoprono il sacro per esempio amando la famiglia fino ad annullarsi per i figli.
L’induismo propone, tra le tante, anche la via della bhakti. Esiste un amore del sacro, un amore del tutto che deve essere associato alla vita del mondo. Lo hanno ad esempio i laici che vanno a Messa e vi scoprono Dio, ma restano nel mondo. Altre persone, invece, hanno bisogno di amare Dio in maniera totale. È questa la bhakti! Il monaco che passa la vita nel tempio a fare atti di devozione verso una divinità personale. Il senso della devozione del monaco non sta nella esecuzione di un precetto formale ma nel compimento di un atto di amore.
Nel Nāradabhaktisūtra, cap. 3, è scritto che “l’essenza di questo amore è eterna”, nell’originale sanscrito suona amṛta-svarūpā ca. Questo amore totale verso Dio è espresso anche da altre religioni, pensiamo ai mistici cristiani, ai cabalisti ebrei, ai sufi musulmani.
In questo amore esclusivo verso Dio, il credere in Dio è una completa donazione di sé a Lui, l’offerta della propria vita, che così diviene un canto continuo di lode verso Dio. È significativo che il verbo latino credo derivi da “dare (do) il cuore” (cre: stessa radice del greco kardia, “cuore”, presente ancora oggi in “cardiaco”), esatto corrispondente del vedico śrad-dha, la fiducia nell’efficacia rituale, poi la fede.
Persio nella Satira II biasima chi si rivolge agli dei per chiedere cose empie (la morte di qualcuno) o beni apparenti (bellezza, ricchezza): bisogna chiedere cose giuste. E l’offerta non deve essere solo formale ma accompagnata da una condotta etica rigorosa:
conpositum ius fasque animo sanctosque recessus/mentis et incoctum generoso pectus honesto, “un animo dove armonizzino il diritto umano e quello divino, la purezza dei propri intenti più profondi e un cuore imbevuto di nobile onestà”.
Da queste parole possiamo trarre la conseguenza che la religione non è un rito vuoto, ma deve essere accompagnata da un animo predisposto all’amore verso Dio.
Osea 6, 6:
“Amore voglio e non sacrificio”.
Dio non è una persona come noi ma non diciamo che sia qualcosa di impersonale. È una coscienza assoluta, svincolata dalla materia, ma gli induisti dicono che si può incarnare (come dicono anche i cristiani riferendosi a Cristo), e può avere anche dei sentimenti, come gli dei greci preda delle passioni o il Dio biblico che scatena il diluvio.
Dio non è limitato nello spazio fisico e può apparire e comunicare ovunque: un oggetto (pensiamo ai totem degli animisti) o i sofferenti. La persona che in India pratica la bhakti può ricevere l’ordine di accudire le persone bisognose perché in esse si manifesta la stessa divinità che adora con atti devozionali, i sacrifici. Non ricorda la vita dei sacerdoti cristiani che dedicano la vita alla Messa e all’amore verso gli altri? In India il Linga Purūṇa (I, cap. 82) enuncia anche delle regole di condotta simili a quelle dei monaci di tutte le religioni: non rubare (asteya), erranza e non matrimonio (brahmacārya), assenza di ambizione (alobha), rinuncia ai beni materiali (tyāga), non violenza (ahimsā).
Ci sono devoti che sentono talmente potente in sé l’amore che Dio ha verso di loro che non fanno altro che ricambiarlo offrendo la vita per Lui con atti continui di devozione e di servizio. I santi vivono sulla terra con la speranza continua e il desiderio ardente di morire per incontrare il Dio dei Cieli. San Cipriano appena prima che il boia gli mozzasse la testa dispose che questi fosse pagato con 25 monete perché gli apriva la vita nel Cielo.
Il martire cristiano sa che, unendosi alla croce e alla morte di Cristo, con lui parteciperà anche alla gloria. Tertulliano diceva che il sangue dei martiri è seme per i nuovi cristiani. Il martire, aggiungendo ciò che manca alla sofferenza di Cristo, partecipa anche all’opera della redenzione.
Lao Tseu (Tao te Ching 22):
“I Santi abbracciando l’Uno erano la regola del mondo”.
Secondo le varie religioni il mondo è un progetto di Dio che crea gli uomini affinché questi lo riamino a loro volta. Corano 5, 54:
“O voi che credete, se qualcuno di voi rinnegherà la sua Religione, Allah susciterà una comunità che Lui amerà e che Lo amerà, l-lahu biqawmin yuḥibbuhum wayuḥibbūnahu, umile con i credenti e fiera con i miscredenti, che lotterà per la causa di Allah e che non teme il biasimo di nessuno. Questa è la grazia di Allah ed Egli la dà a chi vuole”.
L’amore che l’uomo prova verso Dio deve avere come conseguenza la devozione. Nella comunità di Qumran si pregavano i salmi e l’orante ringraziava Dio per aver avuto la possibilità di conoscere la sua grazia attraverso lo spirito della conoscenza e confessava:
“Ti amo liberamente e con tutto il cuore e con tutta l’anima mi sono purificato dall’impurità” (1 QH 7, 23).
La conseguenza ultima dell’amore dell’uomo nei confronti di Dio è la divinizzazione dell’uomo. L’uomo offre il cuore a Dio come atto di amore attraverso il sacrificio e, in questo rito, Dio eleva l’uomo alla sua dignità. Il mistero della rinascita del fedele nel mondo degli dei attraverso il rito offerto alle divinità, è espresso in India dal termine sanscrito dīkṣā.
Maitrāyaṇī-Saṃhitā III, 6, 1:
antarhito vai daivāt kṣayān mānuṣaḥ kṣayo mānuṣād evainaṃ kṣayād antardadhaty atho rakṣasām ananvāyāyaiti vā eṣo ‘smāl lokād yo dīkṣate, “la dimora umana è separata dalla dimora divina; la cerimonia trasporta il sacrificante fuori dal mondo umano; se ne va da questo mondo chi fa la dīkṣā”.
Qualcosa di simile abbiamo in uno scritto del Nuovo Testamento, la Prima Lettera di Giovanni, nella quale si rivela la sorte ultima di chi accoglie il messaggio evangelico:
“Carissimi, fin d’ora siamo figli di Dio, e non è stato ancora rivelato ciò che saremo. Sappiamo però che quando si sarà manifestato, saremo simili a lui, poiché lo vedremo così come egli è”, omoioi autōi esometha, oti opsometha auton kathōs estin.
Questa divinizzazione e il gaudio relativo dipendono dall’amore verso la sostanza divina. Ficino (Teologia platonica XVIII, 8):
“E dal momento che il gaudio è proporzionato all’amore, le menti che hanno amato più ardentemente, unendosi più profondamente, come succede nell’amore, sono più profondamente trasportate nel bene, interius transferuntur in bonum, e così, proprio grazie al contributo dato dalla disposizione all’amore, godono anche più dolcemente”, suaviusque fruuntur.
In molti ritengono che il sacro si possa esprimere nella propria vita o almeno ricercare in vari modi. Non esiste un’unica via, cioè un unico sistema religioso o magico o iniziatico. Pensiamo all’induismo, che in sé nemmeno esiste, in quanto formato da correnti anche molto diverse tra loro, le principali correnti bhakti sono shivaismo, visnuismo e shaktismo. Stessa cosa si può dire del buddhismo, termine occidentale che copre una realtà pressoché infinita di scuole o più antiche o più moderne. I primi canoni buddhisti sono andati perduti perché le scuole si sono estinte: una derivazione da una di esse però è costituita dal buddhismo theravada, ma non era la scuola più importante. Il Buddha operò nel VI secolo a. C. e questa forma di buddhismo apparve all’incirca nel III secolo a. C. Tutti noi abbiamo sentito la parola giapponese zen, è una forma di buddhismo che dalla Cina apparve in Giappone attorno al IX secolo dell’era volgare.
Nella stessa maniera si può considerare l’ebraismo, dalle correnti più ortodosse e nazionaliste a quelle più libere, per cui ci sono anche ebrei taoisti o ebrei induisti. Ma anche nell’antichità c’erano sette variegate, e ci deve essere stato anche un ebraismo diverso da quello testimoniato nella Bibbia. Da queste scuole sarebbe sorto il giudaismo rabbinico, la cui letteratura è costituita eminentemente dal Talmud (ma non solo), basato sul midrash, cioè sulla interpretazione minuziosa del testo biblico o in senso normativo (halakico) o in senso teologico (haggadico).
Nel 1906 fu pubblicato un volume destinato a sconvolgere le idee degli studiosi circa il giudaismo del V secolo a.C. Si tratta di Aramaic Papyri from Assuan di Archibald Sayce e Arthur Cowley, un testo in cui erano trascritti e tradotti con belle riproduzioni alcuni dei testi di una comunità giudaica che risiedeva in età achemenide a Elefantina, un isolotto nel Nilo situato di fronte alla moderna Assuan, nell’Alto Egitto. L’interesse suscitato dalla pubblicazione indusse un archeologo tedesco, Otto Rubensohn, a cominciare scavi archeologici a Elefantina in quello stesso anno e poco dopo alla missione tedesca si affiancò una missione francese guidata da Charles Clermont Ganneau. Nel corso degli scavi si trovarono centinaia di testi aramaici che gettarono nuova luce sulla diaspora giudaica d’età achemenide, lasciando emergere una forma di giudaismo diversa rispetto a quella testimoniata nella Bibbia.
Questa comunità giudaica possedeva un tempio dedicato a YHWH, conosceva il sabato ma non sembrava considerarlo giorno di riposo e, pur avendo YHWH come dio principale, non lo riteneva l’unico dio.
Sono i documenti più antichi che abbiamo di una comunità giudaica fuori dalla Palestina. Alcuni parlano di albori della diaspora ebraica. Nel V secolo a. C. l’Egitto era sotto la dominazione achemenide, cioè persiana. L’impero achemenide era enorme: dall’Asia centrale alla Mesopotamia e a tutta l’Asia minore, e ancora, fino all’Egitto. Quindi Elefantina sta all’estremo sud dell’impero achemenide. L’Egitto fu conquistato dagli achemenidi per opera di Cambise II nel 525 a. C. Cambise ha una fama pessima in Egitto, come distruttore di templi. Anche se gli scavi archeologici hanno dimostrato che di distruzione di templi egiziani ce ne sono poche. Gli egiziani digeriscono molto male l’invasione egiziana e quindi inventano storie senza fondamento, oltretutto lo straniero Cambise si fa proclamare faraone dell’Egitto.
A Elefantina vi era il tempio del dio egiziano Khnum, il dio ariete, un dio creatore, rappresentato come un vasaio che plasma gli esseri umani. Era il principale centro religioso del dio, servito da ricchi sacerdoti. Esso venne ampliato sui resti del tempio di YHWH della comunità giudaica.
Vicino Elefantina, quindi a sud dell’Egitto, vi era la prima cateratta del Nilo (ove il fiume diventa più veloce, ce ne sono altre cinque), e per questo erano ivi stanziati militari achemenidi: nel percorso del Nilo da nord a sud le merci erano portate da grosse navi, ma dalla prima cateratta queste non potevano navigare, quindi tutte le merci dovevano essere traslate su imbarcazioni più piccole. Non solo, ma dopo la prima cateratta inizia la Nubia, quindi i militari achemenidi volevano assicurarsi che non scoppiassero rivolte.
All’inizio si pensava che questi papiri aramaici provenissero da Assuan (vicino Elefantina). In effetti vi era un grosso traffico di papiri che venivano portati sul mercato da personaggi quali tombaroli e gli esperti caddero in errore sulla provenienza. All’epoca gli scavi archeologici erano sterri, cioè senza la stratigrafia e la datazione di ogni strato nonché senza la localizzazione, come invece si fa oggi: si scavava quasi a caso solo per trovare del materiale.
Cowley scrisse:
“Per quanto si apprende da questi testi Mosè potrebbe non essere mai esistito, non ci sarebbe stata schiavitù in Egitto, nessun esodo, nessuna monarchia, nessun profeta”.
A Elefantina sono stati trovati il 56% di tutti i testi aramaici rinvenuti in Egitto: 600 testi tra papiri, frammenti di papiri, cocci, qualche rara iscrizione su sarcofago. Nessun tipo di testo biblico né una sola riga di ebraico, la comunità comunicava in aramaico. Quest’ultima cosa non sorprende, perché l’ebraico cessa di essere parlato nella vita quotidiana a partire dalla diaspora babilonese, cioè quando il babilonese Nabucodonosor conquista Gerusalemme nel VI secolo a.C. e costringe alla fuga molti ebrei. L’ebraico resterà tuttavia la lingua della religione.
Di solito le varie correnti dell’induismo sono anch’esse composite, per cui si può parlare di una stratificazione storica:
- Sostrato vedico;
- Apporti autoctoni;
- Contributi successivi.
Non si tratta di una religione in senso occidentale, perché non ci sono una struttura centralizzata, elementi sempre stabili e unificati, un solo testo sacro accettato da tutti, riti omogenei.
Nell’induismo, nel jainismo e nel buddhismo c’è sempre la dottrina della liberazione dell’Io inferiore. Anche se cambia l’essenza di tale liberazione. Per l’induismo anche l’arte serve alla liberazione perché attraverso la contemplazione dell’immagine divina può raggiungere l’essenza divina. L’arte induista è sacrale e non libera (in quanto codificata da una tradizione ben consolidata).
Le immagini così colorate provenienti dall’induismo possono essere interpretate in tre maniere (Panofsky):
- Approccio pre-iconografico: ha come oggetto il soggetto primario o naturale, cioè ciò che vediamo, per esempio un uomo danzante, cioè un personaggio maschile dalla pelle blu che danza muovendo le quattro braccia;
- Analisi iconografica: ha come oggetto il soggetto secondario o convenzionale, cioè il dio Shiva Nataraja, una rappresentazione famosissima;
- Analisi iconologica: ha come oggetto il significato intrinseco, cioè la danza di Shiva significa la distruzione e la ricreazione dell’universo.
Una divinità indiana può essere rappresentata in queste maniere:
- Antropomorfa (vyakta o manifesta);
- Vyaktavyakta o manifesta e non manifesta (a metà tra simbolo e immagine, come il linga, un fallo con il volto di Shiva);
- Avyakta o non manifesta, cioè simbolica, il linga puro, cioè un fallo;
- Zoomorfa;
- Geometrica: lo yantra, cioè una specie di mandala (che è buddhista), cioè un simbolo geometrico evocativo.
All’origine tutte le divinità erano rappresentate in maniera aniconica, cioè con simboli sacri, come yantra o alberi sacri. In seguito per impulso dei brahmani (a partire dalla metà del I millennio a. C.) si instaura un rapporto diretto con la divinità detto bhakti, con l’esigenza da parte del fedele di vedere il dio amato e quindi nasce la murti, cioè l’immagine del dio. Si è scritto molto sul perché nasce questa esigenza di immagine. Alcuni pensano anche che sia qualcosa di eterodosso, proveniente da altre religioni indiane o dall’ellenismo greco. Esistono molte immagini delle divinità, ma ci si riferisce alla murti come a quella che sta nel tempio induista.
In base alle caste dell’induismo l’immagine sacra (murti) può servire a:
- Brahmana: identificazione con il dio (liberazione);
- Ksatriya: ottenimento di vantaggi morali;
- Vaisya: ottenimento di vantaggi materiali;
- Sudra: ottenimento di poteri magici.
Una divinità induista può essere rappresentata:
- Secondo i guna, cioè le tendenze generali della realtà: sattvica (benefico, immagini pacifiche di protezione e che elargiscono grazie); rajasika (regale, secondo l’aspetto del potere e del dominio); tamasika (terrifico, per quelle divinità armate minacciose).
- Secondo le rasa, cioè le emozioni che può suscitare: per esempio erotico, comico, compassionevole, e così via.
La murti nel tempio ha spesso simboli regali e il cordino brahmanico (segno della casta più alta, la quale può evocare con pieno diritto la divinità). Le divinità indiane hanno spesso più braccia. Perché? Natura ignea dei primi dei, ma anche la danza sacra, ovvero capacità di interventi multipli, oppure possibilità di afferrare tutti i doni portati dai fedeli.
Marco Calzoli